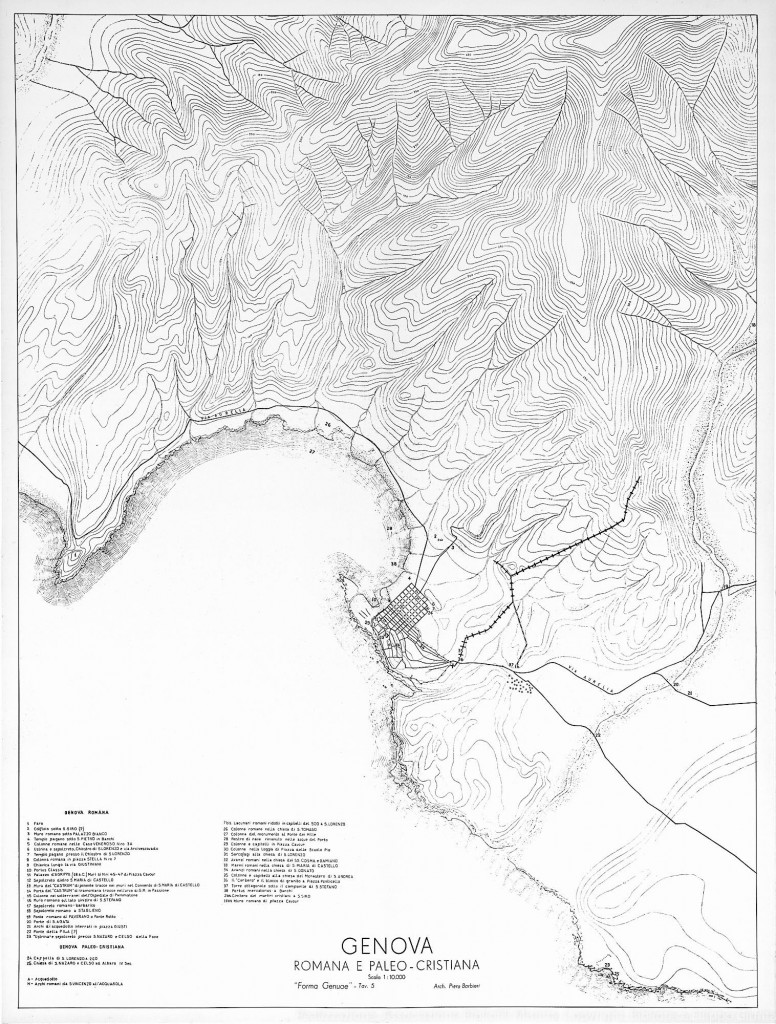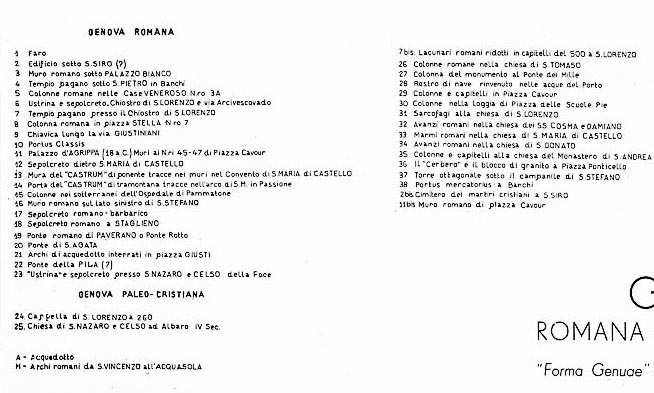- II e I secolo
- 03.1 GENOVA NELLA ROMA REPUBBLICANA
- * * *
- LA LIGURIA DOPO LE GUERRE DEI ROMANI
- * * *
- LA STORIA DI GENOVA NELL’EPOCA ROMANA
- L’IMPIANTO ROMANO
- ———————————- (I) La via romea per valle Scrivia e val Lavagna non è segnata negli itinerari, perchè era essenzialmente una via di servizio locale, o come si direbbe al giorno d’ oggi, provinciale, la strada cioè di cui si servivano per andare direttamente a Roma le popolazioni del Tortonese, del Libarnese, dell’Astigiano e dell’Acquese. Nel 1906 fra Savignone e Casella si scoprì lungo la via delle tombe che contenevano fra l’altro una bella moneta d’oro di Antonino Pio. Altre tombe furono trovate a Ronco. Questa via si chiamava con molti nomi, di Valle Scrivia, di Fontan-a Bon-a, di Paderna, di Patrania, ed anche Petrania e Petronia. L’egregio Gerolamo Rossi (Atti Società Ligure di Storia Patria XXXIX) ha raccolto molti elementi storici a riguardo di questa strada, ma ciò che mi sembra importante a rilevare è questo : 1° Che era la via romea di cui si servivano i paesi d’oltre giogo, e perciò restò in attività nel medio evo per i continui pellegrinaggi a Roma, e perciò vi fiorirono più che altrove i castelli feudali, Pietrabissara, Borgo Fornari, Busalla, Savignone, Montoggio, Roccatagliata, S. Salvatore di Lavagna, e perciò diventò la base del dominio dei conti di Lavagna, che la custodirono gelosamente da Savignone a S. Salvatore, e perciò la troviamo nel medio evo frequentatissima dai Tortonesi, i quali hanno case commerciali e rappresentanze a Sestri, che per mezzo di questa strada fa commercio colla valle del Po (V. Cabotto e Legò, Carte di Tortona). 2. Che il nome di Petronia le è venuto non già da un Petronio romano, ma dalla natura dei luoghi. Dalle osservazioni fatte sui luoghi su vasta scala ho potuto convincermi che si chiamavano «Arni, Erni» i fiumi, i torrenti, (come ernia, e cav-erna la grotta fatta a cunicoli tortuosi). L’abitato fra gli arni od erni è «T-erni, Tr-arni o Trani, è N-arni è D-erna», e la via che segue la tortuosità dei torrenti è «pa d’ erna, pa t’ erna, pa trani-a» tre forme che corrispondono a Derna, Terni e Trani. Il pa-trani-a (tutta fra gli arni) è la stessa cosa che pe-trani-a, (per in mezzo agli arni). Chi sa come si pronunzia l’a nel versante nord dell’appennino, sa che il Petrania si pronunzia Petronia. La oscillazione fra patronia e petronia fu notata dal Fabretti in alcune lapidi (Corp. Inscr. ital., p. 1336). La oscillazione fra petrania e petronia è pure comunissima come avviene per Ferania e Feronia; il confronto è del Rossi ed è giustissimo. La via di cui parliamo si chiamava e si chiama ancora di Paderna verso il Tortonese, si chiamava invece Patrania in val Trebbia e val Lavagna. Bisogna conoscere bene l’Appennino ligure per capire la naturalezza di questa frase applicata a tale strada. Nulla di più accidentato di tutti quei torrenti e torrentelli tortuosi che formano l’alta val Trebbia e l’alta val Scrivia. 3. La via che era unica da Lavagna alla Scoffera si divideva in due a questo punto (crux patrania); una la (Paderna) andava per Valle Scrivia, l’altra la (Patrania) andava per Val Trebbia a Piacenza. Sulla Patrania di Piacenza erano nel medio evo due impianti benedettini, uno a To-ri-gia, l’altro a Monte Bruno, i quali, essendo riuniti sotto un solo Abate, formavano l’Abbazia di Patrania (vedi Rossi, op. cit.; Cabotto e Legò, Carte di Tortona). 4. Anche la via che da Sestri saliva alle Cento Croci per scendere in Val di Taro, pare avesse lo stesso nome, cosa naturalissima perchè le nostre popolazioni avevano lo stesso modo di esprimersi; «Patrania e Petronia» chiamavano la via nei fossati, «ban e banno» chiamavano la via sul monte (ba via, an in su). Tutta la Liguria è piena di monti detti Ao ban; cito l’ «Ao ban» in Genova, cioè il monte Castelletto menzionato nelle antiche carte come monte Albano, cito «monte Ban» sulla, via di Montoggio, «monte Banno» sulla via che dalla Piotta saliva alla Corina per venire in costiera al mercato di Mercuieù. I monti erano molte volte delle lunghe costiere, propaggini allungate verso il piano, che nel linguaggio del nostro Appennino si chiamavano «Coeùxue». Ricordo le capanne di Coeùxua in Val Borbera, la Coeuscia di Sampierdarena, la quale non è altro che la costiera che finisce al capo della lanterna. Chi da Torino guarda verso le Alpi vede le antichissime Coeùxue che i Romani tradussero in Cottine, come chiamarono Cottius il loro re. Chi dal piano di Alessandria guarda al sud vede le belle coeùxue ossia le propaggini dell’ Appennino che nel secolo sesto formavano la provincia delle Alpi Cozzie. Da tutti questi rilievi fatti studiando la montagna in relazione ai suoi nomi siamo venuti a comprendere quanto sono distanti dalla realtà coloro, che studiando la topografia sui libri, andarono fantasticando dei Petronii, degli Albi, dei Cottii per ogni dove. Non parlo dei Carimi, dei Cornelii, dei Sergii, degli Aruntii, dei Vettii, dei Pabii, dei Copioni che furono regalati ai nostri monti, senza mai fare un’inchiesta semplicissima e vedere se l’apparente romanità dei nomi liguri non era lo scherzo di un notaio antico, o di un segretario comunale moderno, o di un compilatore di orarii di ferrovie, o di un geometra che redigeva le carte dello stato maggiore. Qualche rara volta costoro hanno dato nel segno applicando la vera forma glottologica latina, che corrispondeva al nome agreste che avevano per le mani. E so di uno studioso che si propone di dimostrare come si riattaccano al latino molti di quei nomi che io ho raccolto come liguri primitivi. La cosa non è difficile, ma s’ingannano gli studiosi che credono di provare con ciò la preesistenza del latino. Si proverà invece sempre meglio che sul linguaggio ligure italico primitivo si è formata la lingua latina, e che le forme tipiche primitive non sono scomparse come si è creduto finora.
- —————————————- (II) È la via più breve e doveva essere la via naturale e diretta per la Valle del Po, prima che fosse costrutta la via Postumia. Essa camminava sulla «seta o cheta» ossia sull’altipiano formato dalla costiera che va da Monte Poggio a Fiaccone, alla Castagnola, alla Bancheta, al Poà, a Costapelata ossia Borlasca. La Bancheta accenna al «ban in cheta» cioè alla via sull’altipiano, il Poà accenna «al passo». Nel Medio evo tutto l’esteso altipiano formava la «plebs de seta», il convento di S. Grigheù era in seta, come era in seta il convento del Poà. I frati del Poà che vivevano esercitando l’ospitalità su quella strada tenevano in Arquata una cappella, precisamente all’imbocco della strada di «Carrea» per cui si saliva alla costiera. (I documenti relativi sono pubblicati dallo Spadini nelle memorie relative all’Ospedale di Arquata) L’ing. Navone, avendo rilevato i vantaggi che aveva questa bella strada per costiera, opinò che dovesse essere la Postumia, ossia la via romana fra Genova e Libarna. A questo riguardo si deve fare a mio avviso una distinzione. Non è inverosimile che la via Postumia passasse in origine completamente per costiera da monte Poggio a Fiaccone, alla Banchetta, al Porale, a Borlasca, a Sottovalle, Montaldo, Badmei e Libarna, formando così la prima direttissima Genova-Arquata. Finché le gole dell’Appennino non furono definitivamente sicure i Romani dovevano preferire passare in alto, tanto più che si accorciava cammino. Ma questa strada sui monti non poteva essere che mulattiera, e perciò deve molto per tempo essere stata sostituita dalla via di Valle Scrivia, il cui tracciato, che si vede tuttora, permetteva il funzionamento dei rotabili. Il fatto che l’antica Plebs de Seta (Borgo Fornari) si collocò sulla via di Valle Scrivia nè è la prova più convincente. Certamente la via antichissima del Porale non fu mai abbandonata dai Genovesi cho volevano andare speditamente colle carovane da Genova a Libarna, e tornò ad essere la via più frequentata nell’alto medio evo, quando la via di Valle Serivia cadde in rovina. Quanto all’abbandono della via di Valle Serivia, ho rilevato delle vaghe tradizioni che all’epoca delle invasioni longobardiche i Genovesi abbiano rotto la strada per mettere ostacoli agli invasori. Se il fatto è vero, esso probabilmente avvenne nel tempo che precedette la tanto temuta occupazione longobardica, e dopo l’aggressione dei Franchi. Del resto, anche senza l’opera dell’uomo, la rottura doveva avvenire da se dopo qualche secolo di abbandono, se si considera il percorso della strada fra Isola e Pietrabissara dove la montagna si presenta di pessima composizione ed essenzialmenta franosa. A queste cause di distruzione si deve aggiungere l’opera nefasta dei feudatari, i quali rompevano le strade a scopo di concorrenza. I documenti per la storia di Gavi pubblicati dal Desimoni ci fanno vedere il Marchese di Gavi che per far passare le carovane per la Crena e per Gavi rompeva la «Sfrata Vallis Scripiae» nei pressi di Libarna. Gli Spinola, che nel medio evo ebbero interesse a mantenere le comunicazioni fra i loro possedimenti di valle Scrivia, ripararono alle interruzioni trasportando in parte la strada nella destra sponda e facendo tre bei ponti medioevali, uno a Mareta, l’altro a Isola, il terzo a Ronco.
- ———————————– (III) Ma se il racconto si presta al ridicolo, ha sotto un altro aspetto un lato serio, che merita di essere rilevato. È l’interesse che pongono gli scrittori romani nel giustificare coll’intervento di una volontà soprannaturale le batoste che i Romani ebbero a subire, come tutti i popoli che vanno incontro alle eventualità delle guerre. Il Console C. Ostilio Mancino, con un esercito di 30.000 uomini, era stato colto di sorpresa e ignominiosamente sconfitto da 4.000 Numnntini in Spagna. L’effetto morale poteva essere disastroso; ed ecco gli scrittori che si accordano nel divulgare che la sconfitta era spiegabilissima, perchè gli dei avevano preavvisato. A Lanuvio i polli erano fuggiti mentre il Console Mancino tentava gli auspici, a Monaco una voce misteriosa aveva gridato: «Mancin, Mancin, non partire», a Genova era comparso l’ «anguis mirae magnitudinis». La cosa era chiara! Avventurarsi dopo questi presagi era cosa da matti! Si può sorridere pensando che bastava così poco per ingannare il volgo, ma nello stesso tempo dobbiamo riconoscere che esisteva nelle classi dirigenti uno spirito pubblico, che spesse volte fa difetto ne’tempi nostri. Nel medio evo lo spirito pubblico generale risente talmente della tradizione romana, che, ad ogni contrarietà, ad ogni disastro, si trova subito il suo perchè nei fenomeni soprannaturali. Quando i Saraceni nel X secolo riescono a sorprendere Genova e saccheggiarla si sparge subito la voce, la quale restò nelle cronache, che la fontana del molo avesse gettato sangue per tre giorni. Chi fece questa bella scoperta aveva certamente letto in Livio del fiume Amiterno, che aveva portato sangue, (XXIV-44) e della fontana d’Ercole, che aveva dato acqua macchiata di sangue (XXII-1). Tutti i fenomeni tramandati da Livio sono utilizzati nelle cronache di Genova e riferiti dal Giustiniani. Nè si può dire che la tradizione delle superstizioni sia del tutto spenta. Vige in molte parti d’Italia il pregiudizio della iettatura, e dei giorni nefasti, si crede agli indovini e allo spiritismo, mentre si ostenta come segno di superiorità il materialismo scientifico e la negazione di ogni idealità religiosa.
- ———————————— (VI) Il Rossello «sulla condizione giuridica di Genova nell’ epoca romana» ritiene che non risulta in che anno preciso fosse costrutta e da chi, e dove finisse. Ma non si può dire questo, finché esiste il testo di Strabone, il quale cita il nome di Emilio Scauro ed aggiunge «Is est Scaurus, qui viam Aemiliam stravit, quae per Pisam et Lunam ducit ad Sabbatos, indeque per Derthonam». Il Rossello ha confuso ciò che il Mommsen scrive a riguardo della Aurelia vetus da Roma a Volterra» colla aggiunta fatta da Emilio Scauro da Volterra a Vado. A riguardo di questa il Mommsen scrive: «Haec igitur Aemilia Scauri a Volterris ad Vado Sabatia usque strata est anno a. C. 645». L’Ab. Oderico e l’Ab. Sanguineti hanno esaurientemente spiegato il testo e l’andamento della strada. Io l’ho descritta nelle «Due Riviere». Ora mi occupo più specialmente di chiarire le ragioni storiche che la determinarono.
- ——————– (V) Il console Silano battuto nel 109 — il console Cassio Longino preso in un’imboscata e ucciso colla maggior parte dell’ esercito — il comandante Caio Popilio obbligato a passar sotto il giogo (107) — la città di Tolosa che fa prigioniero il presidio romano (107) — Marco Aurelio Scauro ucciso (105) — il Console Cepione sconfitto a Orange e perduto interamente un esercito di 120.000 uomini. (Mommsen, Storia di Roma, lib. IV Cap. V). È il periodo più sconfortante della storia di Roma, conseguenza dell’anarchia in cui aveva gettato la repubblica la lotta interna. È pure il tempo dei processi scandalosi di corruzione, intentati contro i molti consolari e tribuni della plebe, che si erano lasciati corrompere dall’oro dell’africano Giugurta — contro il console Cepione, che era accusato d’aver tolto gli immensi tesori del tempio di Apollo Beleno a Tolosa e di esserseli appropriati sotto pretesto di esserne stato derubato, ed inoltre di aver cagionato la perdita di 120.000 uomini per le sue rivalità col collega Gn. Manlio Massimo — contro M. Emilio Scauro. Presidente del Senato, accusato di aver preso denaro da Giugurta e di aver malversato il denaro pubblico quando costruiva le strade della Liguria. Al solito fu nominata una commissione inquirente e Scauro riuscì a farsi eleggere come uno dei componenti. Molti furono condannati, molti altri, forti o di denaro o di aderenze, furono assolti. E Scauro rimase presidente del Senato; Roma repubblicana era già profondamente corrotta, e non è a maravigliarsi se presto comparirà l’impero.
- * * *
- 202 a. C.
- IL CAMPO ROMANO NELLA VALLE DI SOZIGLIA
- * * *
- 117 a. C.
- L’ARBITRATO DI ROMA FRA GENOVESI E VETURII
- ———————— (I) È interessante il confronto di queste due forme linguistiche: «de-ctun » dice la tavola di bronzo, « der thon » dice Strabene. La tavola era scritta secondo la pronunzia genovese, Strabone invece riferiva la pronunzia che aveva sentito nella valle del Po, ove domina l’articolo er, der. A Pozzuolo per dire che uno è di Tortona, si dice che è der ton, facendo comprendere che «der» è un articolo al genitivo. Il nome si declina così: er ton, der ton, ar ton, o il dialetto conserva le traccie di questa declinazione. Nella pronunzia genovese, come nella pronunzia francese predomina invece la forma o, du, au, O-ton A-o-tun, An-ton, D’-an-ton. Ton è il Xton greco, il gton sassone, (Well-in-gton, Was-in- gton) che diventa ton, don, zon in Italia Cor-ton-a, Grun don-a, Va en-zon a corrispondente a Was in-gton, Bel-in-zon a corrispondente e Well in-gton, e diventa tun e dun e zon in Francia (Au-tun, corrispondente a o ton ligure, D-eu-ton, Du-r-an-ton, Al zon, L-an-don e simili che Giulio Cesare tradusse in dunum. I glottologici hanno inutilmente cercato di spiegare come il Dertona e Dectuna abbia potuto produrre il Terdona medioevale, e il Tortona moderno. La spiegazione si trova soltanto quando si pensa che in linguaggio tortonese ter vuol dire nel e don è la stessa parola di ton. Terdon vuol diro «nel paese» come Der ton vuol dire «del paese». Il prefisso «Tur» accenna alla città che si è venuta formando nel piano intorno al ton primitivo che era sul colle; è la città che vediamo attualmente. I Greci l’avrebbero chiamata la nea-poli, in altri luoghi si sarebbe detto «breo» in altri luoghi «borgo» come era infatti la Tortona attuale nel medio ovo. Intanto ci apparisce per la centesima volta il famoso binomio, che è uno dei fenomeni più caratteristici delle antiche città italiche, la città antica in alto, la città nuova in basso.
- * * *
- II – I secolo a.C.
- GENOVA NELLA ROMA REPUBBLICANA
- [ulteriori immagini saranno inserite appena verranno pronte]
- * * *
- * * *
- CITTADINANZA ROMANA – POMPEO E CESARE
- ——————– (I) Un aneddoto riferito da Plinio (XXXIII, 24) ci dà un’ idea del modo con cui si saccheggiavano le città dei regni d’Oriente. Augusto, invitato a pranzo a Bologna da un veterano, il quale aveva fatta la campagna d’oriente con Antonio succeduto a Pompeo, chiese al vecchio soldato se era vera la diceria che il soldato, che nel grande saccheggio del tempio della dea Anaitide aveva messo per primo le mani sul simulacro d’oro della dea, fosse in quell’ istante medesimo acciecato. Il veterano sorrise; l’audace sacrilego era proprio lui. Anzi egli aggiunse che Augusto stava allora mangiando «la coscia della dea». Il soldato aveva nel parapiglia arraffata una gamba d’oro massiccio del simulacro infranto ; l’aveva portata in Italia e venduta, comperando poi la casa di Bologna, probabilmente delle terre e degli schiavi, e vivendo coi redditi di quel piccolo patrimonio. Anche i Genovesi, così portati alla vita avventurosa d’oltre mare, obbligati per i trattati a concorrere a queste imprese, avranno fatto la loro parte. E se erano presenti all’operazione di Anaitide, avran cercato anch’essi di avere un pezzo di quelle gambe così divine. Il medio evo ci è buon testimonio che i Genovesi avevano imparato a perfezione il sistema di spogliare l’oriente per rivestire l’occidente. Venezia adornò il suo S. Marco colla quadriglia di bronzo presa a Costantinopoli, Genova pigliava il sacro catino, e qualche cos’altro; Pisa, Amalfi non furono da meno nel seguire l’esempio degli avi. Son tutti fatti che rivelano la continuità della stirpe e della storia.
II e I secolo
03.1 GENOVA NELLA ROMA REPUBBLICANA
* * *
LA LIGURIA DOPO LE GUERRE DEI ROMANI
Girolamo Serra, La Storia della Liguria e di Genova scritta dal
marchese Girolamo Serra, Torino, presso Pomba, 1834.
La Liguria dopo le guerre de’ Romani
Assicurata con nodi indissolubili l’unione, restava ad eseguirsi la strada, lungamente proposta, fra l’Àppennino ligure e il mare. Emilio Scauro la fece non più da consolo probabilmente, ma da censore, com’ era de’ Romani costume quando imprendevano opere pubbliche nell’antico lor territorio, e ne’ paesi incorporati alla lor repubblica. Ebbevi però due Emilie, la prima fatta da Emilio Lepido fra Rimini e Piacenza, l’altra da Emilio Scauro. Questa fu quasi il prolungamento della via Aurelia, la quale da una parte di Roma metterà per la maremma in Toscana; sicché parecchi storici la chiamarono Aurelia e Cassia ancora. Ma de’ suoi nomi non più. Quanto alla sua direzione, ella ebbe principio nel territorio di Pisa e termine nel golfo di Vado; donde spiccavasi un braccio obliquo e retrogrado il quale riusciva per Acqui a Tortona, quivi incontrandosi con la Postumia.
Il tronco principale e diretto non s’allontanò dal lido se non in pochissimi luoghi a cagione di qualche promontorio o padule. La brevità fu sempre anteposta all’agevolezza, e scendere da una vetta di monte per risalire direttamente ad un’altra, non si recò a difetto. Come nell’altre grandi vie romane, così s’indicarono in questa le distanze e le stazioni militari. La seconda Emilia si congiunse alla prima mediante la via Postumia; l’Emilia fu parallela al lido Ligustico, e la Postumia perpendicolare.
L’esecuzione di quest’opera romana non produsse la minima irritazione ne’ Liguri uniti, quando il solo disegno l’aveva prodotta grandissima ne’ medesimi popoli avanti l’unione; tanto egli è vero che ogni cosa ha un dato tempo. E questa non fu sì tosto compiuta, che il loro paese venne sgravato dalla presenza delle legioni, bastando a guardarlo e tenerlo in fede il cerchio delle colonie postevi intorno coi popoli confederati e i municipi tramezzo. Laonde. premetteremo allo scarso numero di avvenimenti che ci restano ancora, l’indicazione delle colonie romane, e una notizia breve sì, ma quanto l’antichità il comporta, distinta delle qualità e prerogative competenti tanto alle colonie che a’ municipi e a’ popoli confederati. In tal guisa ci sembrerà aver soddisfatto a’ diversi ufficj dello storico, il quale non dee tanto curare la successione de’ fatti, quanto i cambiamenti delle istituzioni e de’ governi.
Il cerchio delle colonie romane cominciava a levante. La più orientale era Lucca con una parte della Garfagnana, indi il territorio da’ Pisani ceduto l’anno 575 (179 a.C.), poi Modena e Parma dotate di terreni tolti a Friniati; Cremona sulla ripa sinistra del Po, sulla destra Piacenza. Eravi a settentrione Tortona popolatissima, e come Strabone l’appella, insigne colonia, (Ab. Bottazzi, antichità di Tortona), poi Hasta od Asti oltre il Tanaro, Eporedia o Ivrea oltre Po, e a ponente infine fra i Liguri transalpini e i monti Pirenei le Acque Sestie or Aix, e Narbona. Alle quali si possono arrogere nell’ isola di Corsica Mariana ed Aleria, colonie fondate da due grandi Romani, Mario e Siila (Vell. Patercul. I. 14).
Il territorio delle colonie era composto delle possessioni tolte a’ nimici, donate da’ socj, o compre da’ vicini. La loro utilità, come sopra dicemmo, consisteva principalmente in due cose, sgravar Roma ed il Lazio delle famiglie impoverite e perciò turbolente; invigilare sopra i movimenti de’ vicini e de’ nimici, sulla fedeltà de’ sudditi e de’ confederati. Delle colonie con regolare autorità fondate qui trattasi, non delle militari, che furono negli ultimi tempi della Romana repubblica frutti delle guerre civili, e premj della fazion vittoriosa.
Ogni colonia aveva il governo somigliantissimo a quello di Roma, con più o men privilegi, secondo che di romani nativi e possidenti, o di proletari e di soli latini era composta. Il diritto più eminente stava in votar ne’ comizi della repubblica e concorrere a’ suoi onori. Or gli abitanti delle colonie-aventi il diritto della città potevano ciò fare senz’ altra condizione che di andare a Roma, e nella tribù assegnata trovarsi; laddove coloro che avevano il solo diritto del Lazio, dovevano aver prima coperto una dignità principale nella lor terra, eleggere quindi il domicilio a Roma, ed aggregarsi ad una tribù. Lucca, Modena, Parma, Veleja, Libarna e Tortona sembrano essere state delle colonie romane; (Liv. lib. XXXIX; Ascon. Pedian., in Pison., p. 121) delle latine Piacenza, Cremona, e il territorio donato da’ Pisani. Sulle qualità del l’altre colonie che la Liguria cingevano, non abbiamo pur conghietture.
Come delle colonie, così de’ popoli confederati vi aveva due specie ; chi godeva del diritto italico, e chi no. I primi erano generalmente tenuti ad onorare la maestà del popolo romano, ma non riconoscevano altra autorità, che i decreti del senato e de’ suoi delegati, nè dovevano annualmente contribuire roba o danaro. I secondi, quali erano la maggior parte de’ Socj transalpini, non che dal senato, dipendevano altresì negli avvenimenti straordinari e nell’ultime appellazioni da’ pretori o proconsoli delle provincie; contribuivano annualmente una certa somma in danaro, o una determinata quantità di grano a un prezzo molto minore de’ prezzi correnti. Tanto gli uni che gli altri conservavano i costumi, i magistrati, le leggi antiche; armavano con proprio nome e bandiere un numero fermo di coorti distinte dalle legioni; dovevano prendere tutte le guerre, e tutte le paci osservare, che piacevano a Roma.
Finché i Liguri non furono ammessi alla sua cittadinanza, ebbero la prima qualità di confederati: se ne hanno da’ Genovesi, Vitturj, e altri popoli vicini le prove evidenti (Atti dell’ Istit. Lig. T. II. 43); per gli altri sta il silenzio di prove contrarie, e l’induzione tratta da’ privilegj generalmente acconsentiti a’ popoli italiani. Veramente non mancano autori, i quali dall’uno e l’altro grado gli escludono, credendo che in pena dell’animosa e ostinata lor resistenza fossero ridotti alla condizione di sudditi e provinciali, aggravati di tributi, governati da un pretore o proconsole, e in ogni lor fatto soggetti a’ suoi editti. Ma costoro non intesero bene il detto di qualche antico, e niente sentirono della magnanimità romana. Certa cosa si è, che ver un magistrato di ordinaria giurisdizione non andò mai in Liguria, come ne andavano ogni anno in Sardegna, in Sicilia, o in altri paesi ridotti a forma di provincia; e ciò che è argomento diretto, non fu sì tosto pacificato il paese, che i Liguri costituirono negli eserciti romani un corpo distinto e nazionale (Post hoc temporis Ligurum ut sociorum in bellis romanis fieri mentionem invenio. Cosi Samuele PitiscoAntiq. Rom. II. 464; aderendo al PanvinioImp. Rom. IV e al Sigoniode ant. jureIt. I. 23); laddove i provinciali non si ammettevano in quel tempo a militare nè uniti nè separati. Narrano gli storici un fatto che torna qui molto in acconcio.
(A.M. 3878) Assediava il consolo Mario l’alto castel di Muluca, dove Giugurta rè de’ Numidi, dopo diverse fazioni contro i Romani, aveva riposto gli accumulati tesori. Provveduto era il castello sì d’arni e di gente, come di vettovaglie e d’acqua. Terrapieni, torri, e ogni altro ingegno d’assedio il luogo non ammetteva; angustissima la via del salirvi, e quinci e quindi precipitosa. Consumati già in vano assai giorni, e molta gente perduta, incominciò fra se stesso a dibattere Mario, se abbandonerebbe al tutto l’impresa, o se aspetterebbe qualche favorevole congiuntura. Ondeggiante dì e notte si stava fra questi pensieri, quando un fantaccino delle coorti ausiliarie liguri, uscito a caso del campo per provveder acqua, non lontano dal fianco del castello dalla parte opposta all’attacco, alcune chiocciole fra sassi osservando, e di passo in passo cogliendone, sì fattamente inoltrassi, che a poco a poco venne a riuscire quasi in sulla cima del monte. Quivi vedendosi solo, da naturale curiosità spinto, si diede a indagare l’incognito luogo. Una grand’elce fra i greppi cresciutavi, pria d’innalzarsi come ogni altra pianta all’insù, il suo tronco alquanto pendente incurvava sul basso. A’ di lei rami sporgenti in fuori inerpicatosi il Ligure, quindi aggrappato agli addentellati massi, si portò orizzontalmente con gli occhi al piano del castello, inosservato da’ Numidi tutt’intenti a difendersi verso l’opposta parte. Esplora egli quivi ogni cosa che potrebbe fra breve giovargli; e per la stessa via ritorna al campo, non più inconsideratamente come all’andata, ma tutto con attenzione spiando e notando. Affrettatosi poi di pienamente informarne il consolo, lo esorta a tentar la fortuna per quella parte; gli si offre scorta al cammino, e al pericolo duce. Mario spedì col Ligure alcuni de’ suoi più confidenti per esaminare in sul luogo la proposta. Ciascuno, secondo ch’egli era più o meno animoso, la giudicò più o meno difficile. Ma il consolo pure ne concepì qualche speranza: onde trascelti dalle trombette cinque sveltissimi, e quattro centurioni con essi, li sottopose tutti al fantaccino, assegnando il dì seguente all’ impresa. Giunta l’ora opportuna, disposta ogni cosa , il Ligure si mise in cammino. A’ quattro centurioni avea fatto prendere arme e veslimenta leggieri; denudare oltrecciò il capo, affinchè più libera rimanendo loro la vista e la persona, più facilmente si aggrappassero a’ massi. I brandi se li portavano appesi da tergo, come pure gli scudi fatti alla numida di cuojo, o perchè riuscissero così più agevoli, o perchè urtando ne’ sassi, tintinnissero meno. Precedeva il Ligure a tutti; ove macigni o vecchi tronconi in fuori sporgenti gli occorrevano, a quelli accomodava delle funi per agevolare a’ seguaci la strada. Spesso i più scoraggiti dall’asprezza del colle andava con la mano ajutando egli stesso. Dov’ era il salire più scabro, disarmatili affatto, li mandava innanzi, seguendo esso poi col grave carico dell’armi: dove impossibile a primo aspetto il varco pareva, animosamente spingevasi primo; e salendo e scendendo, e mostrando poi libero agli altri il vinto passo, raddoppiava in tutti l’ardire. Con lunga e grave fatica finalmente pervennero al castello da quella parte sguernito come ne’ giorni antecedenti per cagione dell’opposto assalto. Mario avuta notizia, che giunti erano in cima, benché avesse già lungamente travagliato i Numidi, allora vieppiù inanimiti i suoi, formò la testuggine, e secondato alla lontana dalle macchine, dagli arcieri, e da’ frombolieri, tentò di far breccia nel baluardo, rimuoverne i difensori e salirvi sopra con quelli che lo seguivano. Gli assediati che già più volte avevano guasti o inceneriti i graticci de’ Romani, vedendoli cimentarsi di nuovo, avvent tavano dagli alti lor merli con le freccie, le pietre e il fuoco ogni sorta di contumelie, insuperbiti dalla fortezza del luogo. In tal modo i Romani e i Numidi aspramente pugnando, quelli per la gloria e l’imperio, questi per la libertà e la vita, di repente gli assaliti si sentono il nemico alle spalle. A vederlo e fuggire stati erano primi alcune donne e ragazzi: da poi quanti altri si trovavano più dappresso al muro, onde il Ligure era entrato, armati o no che si fossero, tutti egualmente fuggirono. Tanto più il Ligure allora a inseguirli, romperli, calpestarli, feriti o morti lasciandoli addietro, di gloria soltanto, non di preda avido; e di là corse verso la parte assalita da Mario per cogliere da tergo i difensori. E ottenne piena vittoria. Così l’inespugnabile castello fu preso, Mario salvato dall’ ignominia (Flor. rer. Rom. III. 1; Sallust. de bello Jugurt. XCII; conforme all’ottimo volgarizzamento di Vittorio Alfieri); e nondimeno l’invidia o la trascuranza romana involò a’ posteri il nome del benemerito confederato.
Le coorti liguri s’illustrarono ancora contro i Teutoni, Cimbri, Ambroni, nazioni settentrionali, cacciate al mezzogiorno dalla fame, dalla cupidigia, o da altri Barbari. Avevano costoro rotto tre eserciti, trucidati più consoli, occupata la Gallia Narbonese, e minacciavano di soggiogare l’Italia (Plutarch. Vit. C. Marii) C. Mario, vincitor di Giugurta, loro s’oppose (A.M. 3883), ma prima d’impegnarsi in una battaglia volle i suoi rincorare dalle passate disgrazie. Seguitò a questo fine di distanza in distanza i Barbari: nell’antiguardo collocò le coorti liguri; e se non impedì i progressi nimici, li ritardò almeno. Giunti all’acque Sestie gli Ambroni fanno alto. Mario prende a rimpetto un posto fortissimo per gli alloggiamenti, ma povero d’ acqua ; giudicando che la scarsità di qualche tempo farebbe sospirare a’ suoi soldati la zuffa. I Saccomanni intanto non avendo essi, nè le bestie loro da bere, s’ armano segretamente di accette, e nell’ora più calda del giorno con botti e brocche muovono a un fìumicello non lungi dal campo nimico. Quivi parecchi Ambroni, che stavano bagnandosi nell’acqua, sono uccisi da’ Saccomanni. Accorrono altri al romore e cominciano ad azzuffarsi. I soldati di Mario veggendo i servi loro in pericolo, vogliono andare a soccorrerli: Mario dà il segno della battaglia. La maggior parte de’ Barbari, finito il desinare nel campo, corre a pigliar l’armi e a riunirsi co’ compagni. Ma non andavano però in disordine, nè a furia, nè mettevano grida incerte; anzi battendo l’arme a tempo con una certa misura, e camminando tutti insieme, gridavano: Ambroni, Ambroni, o per animar se medesimi, o per isbigottire i Romani con un nome tante volte vittorioso. I primi a incontrarli furono i Liguri, i quali poiché intesero una tal voce, ripeterono quella ferocemente e con giubilo, perch’ era un antico lor nome (Il Guarini e il Domenichi anticamente, e a’ dì nostri il celebre Schweighäuser intesero questo passo di Plutarco diversamente, ciò è che i Liguri sentendo gli Ambroni gridare il lor nome, rispondessero gridando il proprio. Ma noi seguitiamo Xylander, Amyot, Rualdo, Dacier, Bardetti, Pompei, non solamente perchè sono i più, ma perchè nell’altrui spiegazione, un membro di periodo, quello che dà ragione del gridare de’ Liguri, ci sembra inesplicabile o vano). E l’impeto de’Liguri riuscì così bene, che le legioni romane ebbero agio di spiegarsi lateralmente. I nimici colti in fianco dopo lunga resistenza andarono in rotta, ma nessuno gl’inseguì, perchè era già buio. Alla nuova luce rifecero testa con peggior fortuna, e tra prigioni e morti ne rimasero d’intorno a cento cinquantamila. Quindi una coorte ligure fu stanziata a Fregius, come alla vedetta della Gallia meridionale (C. Corn. Tacit. Annal. XI. Hist. II Le belliche navi dell’imperio romano erano tripartite al capo di Miseno, nel porto di Ravenna e nel seno di Fregius); e i latini scrittori confessarono ingenuamente, che la repubblica rinvigorì, quando soldati così fatti si mescolarono alle stracche legioni.
La sconfitta de’ Cimbri e degli Ambroni lasciò tale ribrezzo in cuore de’ Barbari, che fino alla totale decadenza di Roma non osarono mai più assalirla dal lato dell’Alpi occidentali.
Trovasi nuovamente memoria della coorte posta a Fregius nell’anno 822 (69 d.C.) di Roma, di un’ altra per numero seconda che teneva guarnigione in Sardegna nel 849 (96 d.C.) (Sig. Cav. Buille, Lezione di una demissione milit. e prof. Gazzera notizia di alcuni dipl. imperiali nel T. XXXV. delle M. della R. A. di Torino), e della medesima anche da poi in una guerra contro i Parti (Tacito fa cenno della coorte stanziala a Fregius sotto l’imperio di Ottone. Oltre che in Modena è un’inscrizione a L. Fajano tribuno della prima coorte de’ Liguri, e in Roma un’altra a Ceriale prefetto della seconda. V. Odoardo Ganducio discorso p. 88. in Gen. presso il Pavoni 1614); onde appare, nè questo è unico esempio, che alquanti Comuni della Liguria rifiutarono lungamente il dono della cittadinanza romana, contenti alle proprie leggi. Ma qualche eccezione non deroga al generale. Però gli scrittori greci e latini ci dicono a una voce, che i Liguri furono incorporati a’Romani (A.M. 3918), che le leggi della repubblica obbligavano la Liguria sino al Varo, come l’Istria sino a Pola; e l’uno dà alla penisola tutta il titolo antico di Roma, delle cose Signora; e l’altro conchiudendo la sua descrizione con l’Alpi e co’ Liguri abitatori di quelle, esclama: questa è l’Italia sacra agli Dei ! (Diodor. Sic. V. 315; Strab. V. 215; Plin. H. N. III. 20; Rutil. Itinerar, lib. II).
Durante la guerra e più dopo l’unione, i Romani pigliarono qualche usanza de’ Liguri. Riputatissima era quella degli scudi militari tondi, ricurvi, onde i soldati riuscivan più fermi in battaglia e più svelti in cammino, che non coverti degli scudi romani quadrangolari. Ma siccome la novità non piaceva al popolo, così il senato diè voce, che uno scudo ligustico era un tratto caduto dal cielo nel tempio di Giunone. Vi fu gara allora a provvederne di simili, (Jul Obsequen., De prodigiia) e se ne armarono principalmente i Veliti. Reciprocamente i Liguri imitarono i Romani nella disposizion regolare delle coorti; presero inoltre a radersi la barba e a scortarsi i capegli (Lucan., Pharsal. Et nuno tonte Ligur). Solo ritennero il patrio costume i Voconzi e i Vedianzi, detti perciò Capillati o Comati, e novellamente Barbetti.
Intorno alle fogge dell’abbigliamento, alcuni popoli della Liguria s’attennero all’antico rozzo giubbone di pelli lanose, e camminarono uomini e donne a piè nudi; laddove parecchi altri le forme imitarono che videro prime a’ legionarj romani, e che opportune riuscivano per l’aspre loro montagne; ciò è un vestito tondo di lana con piccole falde su i fianchi, detto in latino sagum e anche sagulum quando era più fino; inoltre una calzatura pur da soldati, chiamata caliga, con chiodi di legno sotto le piante, e stivaletti di cuojo fin sovra il ginocchio. Del che il presente dialetto del paese serba l’analogia nelle voci Saaghetta, e Caegà, l’una dinotante un vestimento consimile, adoperato dal popolo minuto e da’ cacciatori; l’altro un artigiano che altrove si appella calzolajo.
Quanto all’antico dialetto ligure, Erodoto ci ha conservata la voce Sigynes, per significare i commessarj delle navi mercantili, e Plinio la parola Bodinco, per dinotare il fiume re dell’Italia. Molti altri vocaboli dedurre si possono dalla storia e geografia primitiva della Liguria (Istit. Ligure II); donde resulta una favella simile in gran parie agl’idiomi settentrionali. Ma i Liguri a poco a poco se ne divezzarono per usare la lingua della nuova loro Metropoli. Di Osca, di Etrusca s’hanno frammenti, di Ligure no.
Egli è incerto se l’ uso delle terre attribuite fosse più antico fra Liguri o fra Romani. Attribuite erano minori castella verso più grandi, che senza privarle di propria amministrazione aveano sopra di quelle la custodia de’ carcerati, la colletta de’ dazj, la pubblica cassa, e la cognizione o l’appello delle liti gravi. Queste terre privilegiate in Liguria assunsero poscia il nome romano e i privilegi de’ municipj. Fu allora che molte famiglie liguri allettate da quelle prerogative si diramarono a Roma, e molte Romane in Liguria. Vedemmo già un consolo Elio ligure; si legge in Marco Tullio d’uno Staleno fervido oratore, e la serie degl’imperadori rammenta, come a suo luogo diremo, i Pertinaci e i Prodi. Più ancora le iscrizioni scoperte alle falde del ligure Appennino intornò a persone graduate e possidenti in Liguria, son piene di romani cognomi, (vedi Annotazione V) gran parte de’ quali si conservano ancora da’ tempi della romana repubblica fino a’ di nostri, a dispetto de’ Barbari é dell’età voraci.
Annotazione V.
Di antichi nomi e cognomi romani simili a’ cognomi e casati oggi esistenti in Liguria.
Aproniani o Aproni, Asprenate o Asplanati, Balbi, Bassi, Bibuli o Bibolini, Bolani, Cammilli o de’Cammilli, Casa o della Casa, Calvini, Carboni, Cattii o Gatti, Cerchii, Clemente, Costa, Cossi, Crassi o Grassi, Erminii, Fabiani, Forti, Galerii o Galera, Galli, Gallieni, Gavi, Gemelli, Giusti, Graziani, Laberii, Lenas o Lena, Longhi, Lupi, Marii o Mari, Marini, Marciani, Massa, Massoni, Montani, Mutii o Muzj, Natta, Nigri o De Negri, Ottoni, Palma, Pansa, Persici, Persii, Pisani, Pondi, Ruffini, Sabini, Salvi, Septimii o Settmi, Serrani o Serra, Sertorj, Silvani, Stahleni o Staglieni, Stella, Valenti, Veri, Viviani, Ursi o Orsini. Havvene certo moltri altri, ma non ci vengono in mente. V. le storie romane, Paolo Manuzio ne’ suoi comenti alle opere di Cicerone ep. 21, lib. V. ad fam., inoltre le iscrizioni riferite da Odoardo Ganduccio; quell’altre frescamente scoperte a Tortona, a Serravalle e a Veleja, la descrizione de’ vasi sigillati, trovati pure a Veleja, e la celebre Tavola alimentaria.
Havvi ancora de’ casati, i quali sembrano originarj della Grecia, a cagion d’esempio i Macarj, i Medoni, i Partenopei, i Cybo che in alcuni luoghi son detti Cub, i tanto numerosi Parodi, i Bisio, e i Grilli. Fu Grillo figlinolo di Senofonte che mori a Mantinea.
V. intorno agli ultimi due cognomi Plutarco nel convito de’ sette Savj, e Quintiliano Instit. Orai. 11. 17.
Come le colonie e le città confederate, cosi i municipj erano anticamente di due qualità, privilegiati quanto i Romani, o solamente quanto i Latini. Ma dopo le leggi Lucia e Pompea si tolsero queste disuguaglianze, e per gl’inconvenienti che indi nascevano, si aggiunsero dieci tribù alle 35 originarie in che Roma era divisa. Ogni municipio fu scritto in una di quelle, e ogni cittadino novello dava il suo voto, come gli antichi e nativi, ne’ pubblici comizj circa le paci, le guerre, l’elezioni de’ magistrati, le leggi e le supreme appellazioni. Nel rimanente i municipi non meno che le colonie romane riverberavano una chiara immagine della grande città loro capo. Imperciocché a Roma la distinzione principale degli ordini era Senato e Popolo, come ne’ municipi Decurioni e Plebe. I primi, detti eziandio senatori, si consigliavano da prima insieme, quindi stendevano il decreto, e se il negozio era grave, lo proponevano all’assemblea della plebe, la quale potea rifiutarlo o confermarlo co’ suoi voti senza farvi alterazione. Dovevano i decurioni avere l’età di venticinque anni e il censo di centomila danari equivalenti a ventimila lire nostre. L’ ordinario lor numero era d’un centinajo, non compresi i Patroni, spezie di decurioni onorarj, promossi alle dignità della repubblica madre, e i Praetextati figliuoli di Decurioni, aventi l’abito de’ giovinetti nobili, chiamato Praetexta, ma privi tuttavia di voto, perchè non ancora in età, o non mancante il numero legale. Adunque i figli succedevano a’ padri, e in difetto di successore ereditario, si procedeva alla elezione di un altro. Dall’ordine stesso si traevano i magistrati, cioè i Duumviri juri dicundo, che erano due presidenti della curia e amministratori della giustizia; i Quinquennali o cinque curatori de’ pùbblici lavori, de’ beni e introiti municipali, gli Edili deputati alla salubrità e agli spettacoli, i Flamini o sacerdoti particolari. Di tali ufizj non mancano illustri memorie in Liguria. (Ganducio p. 7, 45, 53; Paganini St. eccl. della Lig.; Ab. Oderico Lettere lig.; e il barone Vernazza in varie memorie intorno alla costituzione de’ municipi romani; leggasi F. E. von Savigny Geschicht des Römischen Recht secc.).
Una quiete sicura e un amorevole uniforme governo ristorarono i danni delle guerre antecedenti. Plinio autore gravissimo e di una sola età posteriore afferma (H.N. III, 7, XXI), che la Liguria transappennina fioriva molto a’ suoi tempi, e tutta quanta brillava di nobili città e cospicue. Queste erano Asti e Tortona già nominate fra le colonie, Iria o Voghera, Barderate, Industria, Alba, Pollenza, il foro di Valentino, il castel de’ Vagienni, l’Acque statielle famose per bagni sulfurei, e Libarna patria adottiva degli Atilj Serrani (Pietro De Lama, iscr. Antiche, p. 48; Tavola aliment. Velejate, p 25; Vasi sigillati p. 72; Cav. Giulio Cordero di S Quintino osserv. intorno ad alcune iscrizioni di Libarnna p. 23). Aggiungasi fra il Taro e la Nura Veleja città abitata da’ Romani Sabini i quali ne avevano il patrocinio, stanza di molti vecchi decrepiti, e al tempo de’ Barbari distrutta come Libarna; ma i vestigj rimangono, dell’antico splendore.
Verrebbe qui a taglio di dare la geografia della Liguria marittima dopo le guerre con Roma, siccome la demmo innanzi. Ma gl’itinerarj romani ne trattano così minutamente, che gioverà serbarla a una separata annotazione (vedi Annotazione VI). Limitiamoci qui dunque a’ paesi che prosperarono maggiormente. Appare da Strabone e da Tacito, che Ventimiglia divenne una delle grandi città italiche. Di Albenga lo provano tante latine iscrizioni e tante memorie di opulenza e dignità. Un dubbio proposto dall’antico giureconsulto Scevola (L. 38. Digest., de auro et argento legato) dà a divedere, che lavoravansi a Tabia, or Taggia, covertine, mantellette e grembiuli molto stimati in Roma. Il nome di Polupece, sia oggi Loano o Finale, è tolto dalla quantità di lane colà scardassate fino da’ tempi che vi approdarono i Focesi. Vado fiorì non solo per navigazione, ma per fornaci di calcina e di mattoni che vi durano ancora. Di Genova qui appresso diremo. Nella Liguria orientale, quantunque non sia chi descriva la prosperità de’ Tigulj, pure gravissimi indizj s’accordano a provarla; in prima la lontananza de’ Cartaginesi, e l’amicizia non interrotta mai co’ Romani; appresso la via Emilia la quale passava, tanto al monte che al mare, nel lor territorio, e soprattutto lo spaccio grandissimo delle ardesie, o lavagne utili all’arte del disegno, a’ pilastri degli edifizj, al riparo dell’umidità, e principalmente alla copertura de’ tetti, secondo un costante e generale costume fra l’appennino ligure e il mare. Quindi i Romani Tegolata chiamarono il luogo, ove quella specie di tegole si trasportava dall’erte lor cave al lido; e probabilmente il nome stesso de’ Tigulj non deriva d’ altronde.
Annotaziopne VI.
L’itinerario di Antonio o Antonino, e la tavola Teodosiana pubblicata dal Peutinger sono i due avanzi di antichità, che minutamente descrivono le stazioni militari, e per conseguente i luoghi principali delle strade romane dentro e fuori d’Italia. Havvi qualche differenza fra loro perchè non sono della medesima età ; e i naturali accidenti o l’esperienza fanno bene spesso mutare in qualche parte la direzione delle strade. Le distanze segnate in miglia romane, perchè troppo sconciamente alterate da chi le trascrisse, saranno da noi tralasciale.
I paesi della Liguria marittima nominati nell’itinerario di Antonino con molti errori di amanuensi, son questi.
Lunae, oggi Luni, città distrutta, probabilmente posta nel fondo del golfo di Luni, oggidì della Spezia.
Boaceas e Bodetia. Luoghi incerti, sopra la Vara e il Pignone.
Tegolata, il borgo di Lavagna, vicino al lido del mare, e al fiume Entella, e tre sole miglia lontano dalle sovrapposte pendici di Cogorno e S. Giulia, ove si cava l’ardesia in chiappe o lastre tenere, che induransi all’ aria aperta.
Delphinis , Portofino.
Genua
Libanum, o Libarnum; città fra Serravalle e Arquata, distrutta da lungo tempo. Egli è qui manifesto, che la strada marittima da Genova al golfo di Vado, qualunque ne fossero le cagioni, era interrotta, e che si prendeva in quella vece la via Postumia coll’annesso braccio di strada fra Tortona e Acqui chiamato oggi Levata, e che da Acqui si volgeva per monti al lido de’ Sabazj.
Dertona, Tortona.
Acquis, Acqui.
Crixia e Canalico. Luoghi incerti.
Vadis Sabbatts, Vado.
Polucipe, o Polupece; probabilmente Loano, secondo altri Finale.
Albinganno, Albenga.
Loco Bormani e Costa Balenae. Luoghi incerti.
Albintimilio, Ventimiglia.
Lumone, luogo incerto.
Alfe summa; il monte della Torbia o Trobia.
Cemenelo, Cimies.
Varum Flumen, Varo.
Al tempo della tavola Teodosiana la strada marittima, ch’era stata interrotta, fu aperta. I luoghi ivi indicati sono i seguenti.
Luno, di sopra Lunae.
Boron, Vara, o luogo posto su questo torrente.
In Alpe Pennino, oggi il Bracco, da Brac, nome anteriore alla romana potenza, che significava luogo aspro e deserto.
Ad Monilia, Moneglia.
Ad Solaria; Solaro, piccolo luogo sopra Chiavari, che ritiene anch’oggi tal nome.
Ricina, Recco, grosso borgo sul mare, 12 miglia a levante di Genova, e stazione postale.
Genua.
Ad Figlinas. Alle fabbriche di argilla, or Feggino, ov’è tuttavia un avanzo di strada a ponente. Salivasi dunque da Genova al monte, ove son oggi le porte degli Angeli, e scendevasi quindi in val di Polcevera rimpetto a Feggino, il che fanno anche al presente le condotte delle bestie da soma.
HàstA ad Navlia. È verisimile che qualche copista, greco di patria, notasse nel margine della tavola … (in greco Aoru) città; e che indi, com’è tante volte accaduto, l’annotazione entrasse nel testo di copie successive, raffazzonando quel nome alla latina, e apponendovi un’ arbitraria distanza. Ommessa dunque la voce intrusa Hasta, rimane che dopo la stazione ad Figlinas, s’andasse ad un’altra, ad Navalia, cioè presso la piaggia, ove dentro a procinti di tavole si fabbricano navilj. I Genovesi chiamano cotali piagge in lor dialetto scàro, scào, certo da … (in greco), che Ateneo usò in tal senso (Deipnosoph. V. 204. Apud Hier. Commelinum. Il dotto Casaubono interpretò quella voce, quasi fosse il nome proprio del costruttore). Havvi al presente un ricco borgo di semila abitanti, detto Varazze, o Varagine, da varare, tirar di terra in acqua i navilj. E tuttodì ne fanno ivi un gran numero.
Alba Docilia, Albissola. Probabilmente le stazioni militari erano cosi frequenti per dividerne il peso.
Vico Virginis. Luogo montuoso sopra Savona, forse sulla stessa falda di monte, ove al presente si venera un rinomato Santuario.
Vadis Sabbatis , come sopra.
Albinganno , Albenga.
Luco Boramni o Bormani e Costa Balenae. Luogi incerti, forse Costa Rainera presso S.Remo.
Albintimilio, Ventimiglia.
In Alpe maritima, la Torbia.
Gemenello , o Cemenlo.
Varum , Varo.
Finalmente a’ luoghi suddetti l’antico itinerario di mare aggiugne il fiume Entella o Lavagna, il Feritore o Bisagno, e la Procobera o Polcevera; come pure l’itinerario de’ porti nomina Portum Moricii, oggi Porto Maurizio e l’Olivella presso di Villafranca. Plinio rammenta Tigulia, ch’ è verisimilmente la Tegolata dell’itinerario, e Segesta Tiguliorum ch’ era secondo lui dentro terra.
Intorno alla geografia della Liguria antica, media e moderna, vedi il Bracelli nell’ elegante sua descrizione del lido Ligustico, la dissertazione corografica dell’Italia nel tomo decimo della gran collezione del Muratori, quella delle vie militari nel decimo altresì della raccolta del Grevio; quindi l’ab. Gaspare Oderico patrizio Genovese nell’erudite sue Lettere ligustiche stampate in Bassano, e l’avvocato sig. Leopoldo Bisio in un lodatissimo ristretto che pubblicò questi anni passati l’Antologia di Firenze.
Di preziose notizie ancora si trovano nell’Osservazioni di un coltivator di Diano sopra la Liguria marittima (sig. Agostino Bianchi), nella storia letteraria della Liguria scritta dal chiar. P. Spotorno, e nelle dotte opere di storia naturale pubblicate da’ celebri professori Viviani e Bertoloni, l’una intitolata Viaggi in alcune parti della Liguria orientale, e l’altra Specimen Zoophytorum Portus Lunae. Da ultimo vedi la statistica del dipartimento di Montenotte con un’appendice sopra il golfo della Spezia, opera del C. Chabrol antico prefetto.
Spinti da emulazione o tirati dal caso gli Apuani scavarono l’Anido con altri monti d’intorno, e trovarono in quelli verso i tempi di Augusto un marmo candido e terso, attissimo per la finezza e la mole, così alle statue più dilicate come alle fabbriche più maestose di Roma, dove un sol pezzo bastava sovente a un’intera colonna. Più ancora giovò alla vendita delle loro derrate il vicin golfo di Luni coronato di monti, coll’isola Palmaria per argine che gli forma due bocche, e con varj seni e ricetti di placido mare a dispetto de’ venti più tempestosi. Il primo maestro delle bellezze poetiche in Roma diceva: Giova conoscere il porto di Luni, o cittadini! Lunai porturn operae est cognoscere, cives (Q. Ennii, Fragment.). La pace e l’unione avvalorarono i consigli di Ennio, e navilj e mercatanti romani vi si ripararono a gara co’ nazionali. Quando vi si scuoprisse il bel marmo nero di Porto Venere tutto screziato di un giallo simile all’ oro, noi non sappiamo. Certo i Romani l’avranno come noi acquistato per incrostarne colonne, e ricoprirne tavolini o forzieri. Insieme col trafico fiorì l’agricoltura, e i vini del golfo rinvigoriti probabilmente coll’ uve delle balze vicine, or Cinque terre, furono stimati migliori de’ vini toscani. La popolazione ne crebbe talmente, che il piccolo castello di Luni dopo varj casi era una città ragguardevole ne’ bassi tempi; ma fu per suo danno.
I Genovesi ancora si diedero a una coltivazione più diligente, e per migliorare il loro vino, usarono quest’ arte. Seccavano l’uve al sole sopra fasci di giunchi, riponevanle poi in vasi turati con gesso. Spruzzavano eziandio di pece i mosti (Plinii, XV. 17. Con pece o catrame ai governano anche oggidì i vini della Morea, di Cipri e di Malega) quando bollon da prima, il che dura nove dì; altri adoperavano il fior crudo della ragia. Un’altra industria essi avevano che oggi hanno smarrita, quella di fondere e lavorare l’argilla per farne stoviglie e altri vasi di varie specie e dimensioni, con sigilli, colori e figure molto eleganti; manifattura stimata assai dagli antichi, come al presente quelle di cristallo e di porcellana. Nessuno infino ad ora lo avvertì; ma n’ è indizio sicuro la prima stazion militare a ponente di Genova, la quale secondo itinerario della via Emilia era posta ad Figlinas. Figline si chiamavano in latino le fabbriche de’ vasellaj; e ovunque tal nome s’incontra, certo è che finissima argilla vi si ritrovava e lavoravasi in tal foggia (Tavola alimentaria 36). Ora il bel luogo ne porta il nome consimile di Feggino.
Poche notizie ci dà la storia intorno allo stato politico di Genova dopo la sua riedificazione, perchè le storie poco ci dicono delle città che viver amano in pace. Ma nell’ anno 1506 fu scavata in val diPolcevera un’insigne tavola di bronzo, monumento antichissimo nella sua specie fra quanti si serbano ancora in Italia. Or questa è che dimostra, (Gruter. Thesaur. inscription. I. 204. Atti dell’Instiluto Ligure tom. II. in Genova. Tipografia Pagano. Chi ama vederla nell’originaria sua forma il può conducendosi nell’antiche stanze de’ Padri del Comune; chi ama meglio leggerla e intenderla senza fatica, scorra gli atti suddetti), come Genova era città confederata; come i Vitturj e i Langansi, popoli coltivatori dell’alta Polcevera, erano a lei attribuiti, e come insorte fra essi interminabili gare a cagion di confini, la sentenza da lei pronunziata passò in ultimo appello a Roma. Per sostenerla i Genovesi inviarono a loro legato Moco Meticanio figliuolo di Meticone, e per impugnarla i Vitturj mandarono Plauco Pe- liani di Peliani. Fu ammesso il ricorso; e il romano senato delegò con solenne decreto due nobilissimi fratelli della gente Minuzia, della famiglia Rufa, a esaminare sul luogo la contesa, fermare i confini, piantare i termini, e ricomporre quell’ importante parte della Liguria in quiete. L’inscrizione scolpita sulla tavola di bronzo è appunto la decisione de’ deputati romani. L’ anno ch’ella fu proferita è il 687 di Roma (66 a.C.?) (A.M. 3868), l’anno medesimo in cui sopra dicemmo, che Quinto Marzio proconsole fondò la colonia di Narbona tra i Liguri transalpini, i Galli meridionali e gli Iberi.
Dall’essere di confederata Genova passò allo stato di municipio; e i suoi cittadini furono ascritti co’ Velejati nell’ antica tribù Galeria di Roma; (vedi Annotazione VII) ond’ è probabile che a tal grado giugnessero prima della legge Pompea. Dopo questo ottennero una zecca che stampò danari d’oro chiamati Genuarii (Cicer., VI. 1. Ad Atticum; Venet., apud Aldum T. VII. 149) correnti molto nelle due Gallie e in Grecia. Forse ancora ne vennero diverse monete d’argento novellamente scoperte in val di Scrivia, raffiguranti prore di navi, solite a imprimersi nelle romane monete, e ben confacenti a una zecca posta sul mare. (Siam debitori di questa notizia alla erudizione e cortesia del sig. Intendente Francesco Leucisa).
Genova non ha cosa di maggior momento che il suo porto, onde i Romani tenevano grandissimo conto di quello, non solo per cagioni di traffico, ma per militari, potendo quindi girare alle spalle degli assalitori settentrionali d’Italia, e quivi far centro per allargarsi nelle regioni occidentali fino all’oceano. I fatti surriferiti di Publio Scipione nelle guerre di Annibaie, e di Minuzio Rufo in quella de’ Transappennini provano ciò molto bene; e confermalo il prodigio accaduto al consolo Cajo Ostilio Mancino nell’ anno 617 di Roma (136 a.C.). Scelto costui a proseguire la guerra contro il generoso popolo di Numanzia in Ispagna, volle innoltrarsi per terra fino a Monaco (Valer. Max., lib. I. de prodig. Il porto di Monaco, che oggi riceve soltanto i legni minori, era allora capace delle romane triremi e chiamavasi portus Herculis Monaci). Ma nel punto, medesimo che montava là in nave, udir gli parve dall’alto una voce: Fermati o Mancino ! Or come i Romani confondevano spesso la superstizione con la religione, così il Consolo diè addietro: e avvisando non piacere agli Iddii, ch’ ei cominciasse il suo viaggio marittimo ove gli altri capitani non erano usati, centoventi miglia rifece per imbarcarsi nel porto di Genova. Allora uno smisurato serpente, quale rappresentarsi poteva alla fantasia colpita da una guerra ingiusta e infelice, fischiogli incontro e disparve. Il consolo non sapendo più che si fare, mise alla vela; e giunto in Ispagna fu sconfitto con trentamila uomini da quattromila. (Il Senato romano non avendo’ ratificato l’accordo fatto dal consolo Mancino dopo la sua aconfitta, mandò in Ispagna il secondo Scipione distnittor di Cartagine, il quale distrusse similmente Numansia.
Non occorre altra memoria del porto di Genova fino all’anno 687 di Roma (66 a.C.) (A.M. 3918). Una moltitudine incredibile di pirati uscì in quel tempo dalla Cilicia, istigata da Mitridate re dei Ponto, a bloccare tutte le coste, onde venivano viveri a Roma. Perciò Gneo Pompeo, anzi esperto capitano che uomo maturo, ottenuta un’ampissima facoltà sopra i mari e le riviere della Repubblica, affidò la custodia del seno di Genova a Marco Pomponio (Liv., epit. lib. I c.; Appian., in bello Mitrid.; Floro, lib. III, il quale nomina a legato un Gratilio), e posti altri legati nel mar Tosco, nel Siculo, nel Gallico, nel Balearico, nel Gaditano, nell’Asia minore e nel Ponto, così strinse d’ogni intorno i pirati, che dove non sembrava possibile in molti anni, tolse di mezzo in quaranta dì quel flagello, rendè a’ naviganti pacifici l’uso del mare, e fino agli abitanti fra terra l’agricoltura. Perciò i Romani gli attribuirono il titolo di Magno; e godrebbe a noi l’animo di poter dire senza dubbiezza, che i Genovesi diedero allora principio a una rinomatissima loro consuetudine, facendo in marmo scolpire l’effigie del benemerito eroe. Uno scrittore del secolo XVI (Odoardo Ganducio c. 76) lo affermò indicandone il luogo; ma quel marmo oggidì non si trova.
Nella riviera de’ Liguri occidentali il nome di Pompejana, ch’ è una terra vicina a Taggia, ricorda ancora quel grande.
I benefizj de’ Romani, i comodi della situazione, l’industria de’ cittadini e la saviezza de’ lor magistrati, comprovata da molti secoli di pace, furono verisimilmente cagione, che Genova estendesse le sue prerogative e il suo territorio oltre a’ confini indicati nella tavola di bronzo.
L’ antica storia de’ Liguri ha qui fine. La moderna incomincia appena dopo undici secoli; e in tanto intervallo non resta di loro che poche e spicciolate notizie. Abbiamo perciò in animo di queste commettere in una generale abbozzatura della storia romana, proseguendo da’ tempi a cui siam pervenuti infino a tanto che i Liguri cessarono di essere Romani, per diventare, com’erano prima, un popolo separato e independente.
Annotazione VII.
Sulla fine dell’anno 1796 si scavò a Roma una inscrizion sepolcrale, dalla quale risulta giusta le regole epigrafiche ciò che per l’addietro s’ignorava affatto, i cittadini di Genova essere stati ascritti nella tribù Galeria di Roma. Siccome non è molto nota, cosi ne giova trascrìverla, quale l’ab. Gaetano Marini di Roma mandolla all’ ab. Gaspare Oderico di Genova; rara copia d’uomini ottimi e dottissimi.
D. M.
m. CAtto. m. F.
SECVnDO. gALER.
genua, mil. Chor. (sic)
X. URB. 7. NIGRI.
VIXIT. ANN. XL.
……………….
Vedi il Giornale Ligustico, anno 2, fascicolo 3.
[ulteriori immagini saranno inserite appena verranno pronte]
* * *
LA STORIA DI GENOVA NELL’EPOCA ROMANA
L’IMPIANTO ROMANO
Poggi G., Genova preromana, romana e medievale, in Genova, Giovanni Ricci editore, Libreria Moderna, Galleria Mazzini, 1914
SOMMARIO: Le fonti e gli altri elementi di ricostruzione storica — Le guerre puniche — Lo sbarco del console P. Cornelio Scipione (218) — Genova distrutta dai Cartaginesi (205) — L’ impianto romano diretto da Spurio Lucrezio (202) — Il campo romano di Genova base di operazioni contro i Liguri — I consoli Minucio Termo e Aulo Postu- mio Albino (192-182) — La costruzione della via Postumia (182) — Descrizione della via Postumia — Sorge Liburna come stazione sulla via Postumia — (181) Sottomissione di quei di Sascè (Statielli) e di quei di Albenga (Ingauni) — (170) Il console A. Postumio Albino in ispezione — (147) Il consolo C. Ostilio Mancino soffre il mare — (109-102) La costruzione della via littoranea. La guerra dei Cimbri. Gli eserciti romani a Genova. I Liguri è Mario — La sistemazione di Genova è compiuta.
Si ebbero finora idee molto confuse sulla storia di Genova nell’ epoca romana, non tanto per mancanza di fonti, quanto perchè non si è mai fatto uno studio coordinato di tutti gli elementi storici che possediamo, specialmente di quelli retrospettivi che ci fornisce il medio evo; non si è mai cercato di mettere i documenti al confronto dei luoghi e delle scoperte archeologiche, nè di metterli in armonia coll’ambiente storico, e colle evoluzioni politiche subite dall’ Italia.
Si è spesso errato nell’ interpretazione dei testi, che parevano contradditori e non erano. Nella mia Luni ho avuto occasione di mettere in chiaro come tante pretese contraddizioni che furono attribuite agli scrittori antichi non esistono, e che esse provenivano dal non aver tenuto conto della diversità dei tempi in cui scrivevano Polibio, Livio, Plinio, Tolomeo (1). Si è dimenticato che intercede un abisso fra i Romani dei tempi della repubblica e i Romani dei tempi dell’ impero, che il mercato di Genova descritto da Strabone non poteva essere quello dell’epoca costantiniana.
Non si è mai fatta una distinzione, la quale è indispensabile, fra i Liguri descritti da Livio, che resistettero per ottant’anni ai Romani, i Liguri cioè della montagna, Apuani, Friniati, Statielli e Velleiati, che conservarono tutta la fierezza e la rozzezza dei popoli primitivi, e i Liguri del littorale, perfettamente civilizzati dal contatto degli Etruschi, dei Cartaginesi e degli altri popoli marinari.
E così si è sempre trascurato di distinguere nello studio di Genova romana l’oppidum dal campo e dall’ emporium «come vogliono le fonti» e come consiglia un criterio, da me più volte discusso, di archeologia romana.
È uno dei fenomeni più caratteristici dell’ epoca romana il formarsi di una città nuova presso l’antica, la «nea-poli» presso il castello primitivo. Quando questa verità storica sarà entrata nella coscienza degli studiosi, quando si sarà ben chiarito il binomio delle due Luni, delle due Pisa, delle due Tortona, delle due Ventimiglia, delle due Napoli, di Fiesole-Firenze, di Savona-Vado, scompariranno molti altri equivoci che son nati a riguardo delle città italiche antiche (2).
Per esempio, si è sempre criticato Polibio perchè al libro II cap. XXXII ha scritto che i Romani nel 224 a C. entrarono nel paese degli Anani presso Massalia. Povero Polibio, dissero i critici; egli è da compatire, perchè non aveva come noi una cultura geografica, e perciò confondeva Massalia con Piacenza, ignorando che Massalia era nella valle del Rodano e non in quella del Po. Poveri noi, soggiungo io, che non abbiamo la cultura necessaria per intendere Polibio. Piacenza ancora non esisteva nel 224; esisteva invece più in alto l’astu degli Anani il quale si chiamava «massaia», che era il nome comunissimo che si dava allora agli abitati recinti. Questi si chiamavano «massaia» precisamente come in oggi, con una continuità maravigliosa, chiamiamo massaia l’insieme di case rustiche e civili che formano un tenimento. Il linguaggio primitivo era ricchissimo e svariatissimo; gli abitati oltre a chiamarsi Massa e Massaia e Masseia che il Ligure pronunziava Marsaia e Marseia (Marsegia e Marsagia) si dicevano pure Astu, e Poli e Noli, tutti nomi che i Romani trovarono e tradussero in Massalia, Hasta, Pola, Nola, ecc.
Fra gli scrittori liguri che si occuparono dell’epoca romana vuol essere segnalato l’Oderico, che sul finire del secolo XVIII fu il primo ad affrontare con buona critica le questioni relative ai Liguri e all’epoca romana. Diligente romanista fu il Sanguineti, che illustrò le iscrizioni della Liguria. Vennero poi il Desimoni e il Grassi, che si dedicarono allo studio della tavola di bronzo. Notevoli gli scritti del Desimoni, in quanto rilevò per il primo l’importanza dello studio dialettale per le nostre ricostruzioni storiche. Il Serra, lo Spotorno, il Rocca, il Cevasco, e il Celesia tentarono di riannodare le fila della nostra storia romana. Ma il poco felice risultato disanimò quelli che vennero dopo, per cui parve più saggio al Belgrano di trarsene fuori e di cominciare la storia di Genova dal 1000. Altri più moderni, avendo in uggia questo problema della romanità, che incombe come il dubbio di Amleto sulla nostra storia, sentenziarono che erano poeti tutti coloro che di Genova romana si occupavano. E con ciò credettero di aver eliminato per sempre gli importuni indagatori.
Ma intanto lo studio della romanità irrompe da tutte le parti. Le scoperte archeologiche si moltiplicano nelle regioni d’Italia. Torino, Aosta, Libarna, Luni, Acqui, Vado offrono di giorno in giorno nuove rivelazioni (3). A Genova la scoperta delle tombe di via XX Settembre, e la scoperta del palazzo di Agrippa hanno fatto intendere che è tempo di lasciare da parte lo scetticismo che è figlio dell’ignoranza, e studiare seriamente le nostre origini, e la nostra organizzazione romana, alla quale fanno capo tutti i nostri problemi storici. La struttura edilizia della nostra città non si spiega se non si conosce la piattaforma iniziale; e così non si spiega la vita organica, il diritto pubblico esterno ed interno di Genova medioevale se non si conosce la costituzione che Genova ebbe ai tempi dell’ impero.
Nella monografia «Sulla condizione giuridica di Genova di fronte al diritto pubblico romano» (4) il prof. Rossello scriveva nel 1906: «limitatissime sono le notizie storiche riferentisi ai rapporti di Genova coi Romani, e però gli scrittori volendo colmare le lacune sono invece indotti a considerare come accertato quanto invece è forse induzione personale». Il prof. Rossello ripete le poche notizie di Genova romana riferite dal Mommsen e conclude: «non credo opportuno seguire alcuni scrittori, che di Genova si occuparono, accennando ad altri fatti che «possono» essere avvenuti, ma non hanno nessun fondamento nelle fonti, e nemmeno stimo necessario accettare o discutere le deduzioui che da essi sono tratte».
Io credo invece che vi sieno molti fatti che non solo possono ma devono essere avvenuti, credo che le fonti esistano e bisogna studiarle con maggiore ampiezza e profondità di quello che si è fatto finora.
Anzitutto procediamo con ordine e distinguiamo la storia della dominazione romana in cinque epoche — epoca repubblicana — epoca augustea — impero — epoca costantiniana e teodosiana — epoca bizantina. Sono 843 anni di storia che si confusero finora insieme con un semplicismo inaudito.
Nell’epoca repubblicana abbiamo una continuità di fatti importanti, che si cerca invano nelle epoche posteriori. Egli è che Roma aveva bisogno di stabilirsi saldamente nell’alta Italia, e nulla trascurò per renderla un organismo forte e rispondente alle sue vaste mire di dominazione.
L’impianto di Genova romana è quello che maggiormente interessa i nostri studi. Abbiamo a questo riguardo quattro notizie storiche importanti.
Nel 218 a. C. sbarca a Genova il Console P. Cornelio Scipione. Nel 205 Genova è distrutta dai Cartaginesi. Nel 202 è rifatta dal senatore Spurio Lucrezio. Nel 197 troviamo il campo romano di Genova in funzione colle legioni del Console Minucio Termo. Sono quattro notizie scheletriche, a cui, secondo il prof. Rossello, nulla si può aggiungere senza incorrere nella taccia di sostituire delle supposizioni alla storia. Io credo invece che l’arte della storia, sia qualche cosa di diverso dalla rassegna delle fonti, come lo ha dimostrato il Mommsen colla sua storia ragionata di Roma, che illustrando a dovere i quattro fatti narrati da Livio si può ricomporre un interessantissimo capitolo di storia genovese da soddisfare alle più severe esigenze della critica.
Abbiamo già accennato alla gran lotta che si combatteva nel sec IV a. C. fra Cartaginesi e Greci di Sicilia per il dominio del Mediterraneo.
I Greci avevano avuto un’ epoca culminante di potenza e di ricchezza col tiranno Gerone, che aveva fatto di Siracusa la rivale di Cartagine. Ma sul principio del III secolo a. C. i Cartaginesi stavano per prendere il sopravvento e miravano non soltanto alla Sicilia ma tendevano ad abbattere Roma e ad impadronirsi di tutte le coste italiche. Di qui la grande sfida fra Roma e Cartagine, che dette luogo alle tre guerre puniche e finì colla distruzione della capitale africana. In tali condizioni Genova si sposa definitivamente alle sorti di Roma.
Sicilia e Sardegna, i due paesi con cui Genova ebbe sempre il maggior traffico, erano cadute nel dominio dei Romani, e Genova, anche non lo avesse voluto, era attratta nell’ orbita della nuova dominazione. Il primo indizio di questo fatto si ha nello sbarco di P. Cornelio Scipione a Genova nel 218 a. C.
Egli si trovava coll’ esercito sulla sinistra del Rodano e si apparecchiava a combattere l’invasione di Annibaie, quando venne a conoscere che questi aveva risalito il Rodano e si accingeva a passare le Alpi. Non restava altro che ritornare in Italia e prepararsi alla difesa sulla linea del Po, ove di recente era stato impiantato un gran campo trincerato a Piacenza. La via naturale per andare da Marsiglia a Piacenza era quella che vediamo sempre battuta in seguito: Nizza, Ventimiglia, Albenga, Vado, Acqui, Tortona. Ma la riviera di ponente parteggiava per i Cartaginesi, ed il console preferì salire sopra una nave e sbarcare a Genova.
Andò solo colla scorta che aveva con sè, od ebbe un aiuto dai Genovesi? Il cammino attraverso all’Appennino era lungo e non scevro di pericolo, perchè il versante nord era ribelle anche vent’anni dopo. Quindi è probabile che egli abbia fatto quel cammino molto in incognito e tenendosi ben cara la compagnia, dei nostri, che potevano insegnargli la strada e coprirgli le spalle.
Certo è che i Cartaginesi trovarono, o in questo o in altri fatti successivi che noi ignoriamo, motivo di considerare i Genovesi come alleati dei loro nemici, e, venuto il momento opportuno, si vendicarono, come si vedrà fra poco.
Non esisteva ancora una via militare, onde si può ritenere, anche se una lapide noi dice, che il Console avrà percorso la via mulattiera che la natura avea segnato fra Genova e Piacenza. Gli studiosi difficilmente possono averne notizia, ma le genti del nostro Appennino insegnano che la via antichissima delle carovane fra Genova e Piacenza è quella che per il Peado va a S. Olcese e Casella, Crocefleschi e Mongiardino, Cantalupo e S. Sebastiano Curone, Varzi e Savatarello. Probabilmente i Romani sentirono in quella circostanza la grande utilità di una buona strada fra Genova e la Valle del Po, e non tardarono a idearla ed eseguirla.
Nel 205 Genova è distrutta da una flotta cartaginese sbarcata improvvisamente sulla sua marina. Giova riferire per intero il racconto di Livio (5), perchè si tratta di un fatto che rappresenta per così dire la fine di un ciclo storico e il principio di un’ era nuova. «Mago ex minore Baliarum insula, ubi hibernabat, iuventute lecta in classem imposita, in Italiani triginta ferein rostratis navibus et multis onerariis, duodecim millia peditum, duo fere equitum traiecit; Genuamque nullis praesidiis marittiinain oram tutantibus, repentino adventu coepit. Inde ad oram Ligurum Alpinorum, si quos ibi motus facere posset, classem adpulit. Inganni (Ligurum ea gens est) bellum ea tempestate gerebant cum Epauteriis montanis (6); igitnr Poenus, Savone oppido Alpino praeda deposita, et decem longis navibus in stallone ad praesidium relictis, ceteris Cartaginem missis ad tuendam inari- timam oram, ipse etc.» Prosegue narrando l’alleanza fatta con quei di Albenga, e il tentativo di invadere coll’aiuto dei Liguri e dei Galli la valle del Po.
Questo ricordo della distruzione di Genova ha il suo valore nelle odierne discussioni sulla questione africana.
La costa africana sarà più o meno fertile, più o meno desiderabile, ma purtroppo è la sponda da cui tre volte partì la distruzione d’Italia. Dal 218 al 202 av. C. l’Italia visse sotto l’incubo della invasione di Annibale, e la distruzione di Genova provò ciò che sia il pericolo della costa Africana in mano nemica. Nel 455 d. C. è la volta di Roma posta a ferro e fuoco dai Vandali, venuti dall’Africa. Dall’ 800 al 1000 è tutto il littorale italico che diventa preda dei Saraceni, padroni del mare, perchè padroni dell’Africa. Dal 1500 al 1600 son di nuovo i barbareschi di Tunisi e di Tripoli che corseggiano sulle nostre sponde (7). Son questi i fatti che bisogna aver presenti, quando si tratta di giudicare se fu un bene o un male per l’Italia l’aver occupato buona parte della costa africana, prima che altri vi si estendesse ai suoi danni.
Nell’anno 202 Genova è ricostrutta per opera del Senatore Spurio Lucrezio, ed è probabilmente in quell’anno che si impianta la stazione militare in Soziglia. Nell’estate dello stesso anno arrivava in Genova la notizia che il console Scipione aveva sconfitto Annibale a Zama ed abbattuta per sempre la potenza di Cartagine.
L’Italia respirava; Genova era vendicata, e si trovava ad un tratto ad aver conquistato una splendida posizione nell’impero mondiale che si delineava colla vittoria di Zama. Genova fa un gran salto in avanti, mentre la riviera di ponente resta gravemente colpita, perchè, avendo parteggiato per i Cartaginesi (12.000 liguri erano a Zama, per testimonianza di Polibio) dovette subire la vendetta di Roma. Quei d’Albenga furono deportati (8).
L’assalto e la distruzione di Genova per parte di Magone insegnarono molte cose — che Genova era un punto strategico importante, e che voleva essere presidiata — che era inoltre necessaria una difesa navale, ossia delle navi «oram maritimam tutantibus». E questo fu il programma che fu subito intuito dai Romani e fedelmente eseguito coll’impiantare, accanto all’ oppidum rifatto, un campo militare, e sulla marina un «portus classis».
Abbiamo rilevato i caratteri del campo militare, ed abbiamo visto come fosse essenzialmente fortificato dalla parte di ponente e dalla parte del monte. A quale scopo tutte queste fortificazioni? Lo spiegano molto bene i fatti che veniamo ad esporre.
197 a. C. Genova diventò subito la base d’operazione degli eserciti Romani, incaricati di soggiogare definitivamente i Liguri del nostro Appennino. Come per combattere Friniati ed Apuani si erano stabiliti due corpi d’esercito uno a Modena l’altro a Pisa, che agivano di concerto; così per combattere i Liguri del nostro Appennino si fece base di operazioni Genova e Piacenza. Il rilievo è del Mommsen e scaturisce dal racconto di Livio, il quale nel 197 ci fa vedere il console Minucio Termo che muove da Genova per guerreggiare contro i Liguri di Casteggio e di Ritorbio, due castelli tenacemente ribelli alla occupazione romana. E si capisce che da Genova per le vie di Varazze e della Steia si dovettero compiere le imprese di Popilio Lenate contro i Liguri Statielli, e quelle altre a noi ignote, perchè mancano i libri di Livio, le quali condussero alla sottomissione dei Sabazii, degli Jngauni, e degli Intemelii.
182 a. C. Dirige la guerra contro i Liguri il console Aulo Postumio Albino (9), al quale dobbiamo logicamente attribuire la strada Genova, Libarna, Tortona, Piacenza. Molti hanno discusso su tale strada, attribuendola ora all’uno ora all’altro dei consoli Postumi. Il Mommsen ritenne che sia stata costrutta dal Console Spurio Postumio Albino nel
148 a. C. Ma il Mommsen non ha mai trattato ex professo la questione, ed ha adottato questa data, basandosi unicamente sul cippo che fu trovato nella Postumia transpadana, il quale accenna a Spurio Postumio Albino, console nel 148 a. C. Io ragiono diversamente.
La Postumia era divisa in Cispadana e Traspadana; la prima arrivava fino a Piacenza, la seconda andava da Piacenza a Verona, più tardi ad Aquileia ed oltre. Naturalmente deve essere stata costrutta in più tempi, come l’Aurelia e tante altre strade romane. Un console deve aver costrutto la Genova-Piacenza-Cremona, e un altro la Cremona-Verona, come un terzo deve aver fatto la Verona-Aquilea.
Non vi sono documenti certi, ma appunto per questo la ragione storica deve avere la prevalenza nelle nostre supposizioni. Se si ammette che nell’anno 197 «i Romani stabilirono le basi della guerra da un lato a Genova e dall’altro a Piacenza» non si può a meno di ritenere che la strada Genova-Piacenza sia stata compiuta nel tempo in cui si guerreggiava nell’Appennino intermedio, e non nel 148 a guerra finita. Una azione collegata tra Genova e Piacenza senza una via militare che le congiunga e metta gli eserciti in condizione di funzionare attraverso l’Appennino, è una ipotesi assolutamente inconciliabile colla previdenza e colla meravigliosa attività militare che ebbero i Romani in ogni tempo, ma specialmente nell’epoca repubblicana (10).
E poiché siamo a ragionare della via Postumia credo opportuno riassumere qui il risultato delle mie constatazioni topografiche, fatte in questi ultimi dieci anni. La scoperta del ponte romano a Cornigliano, di cui ho fatto cenno nel capo V [TEMPLI E DIVINITA’ …] mi ha portato a stabilire che la Postumia correva tutta sul lato destro della Polcevera. Nel piano di Fegino era probabilmente la mansione «ad Figlinas» ove pernottavano gli eserciti che da Piacenza andavano alle Gallie e viceversa. Ivi era un bel piano, prima dell’arginamento della Polcevera, ed ivi doveva essere la stazione, perchè era il naturale punto d’incontro della strada che veniva dalla valle del Po, e di quella delle Gallie che veniva per S. Giambattista e Borzoli. Quando, finite le guerre dei Liguri, cominciò la minaccia di invasione di Teutoni e di Cimbri dalla parte della Gallia, si vide la necessità di una via che portasse più direttamente al confine, ed allora si sostituì alla Piacenza-Fegino, la Piacenza-Vado, di cui parleremo fra poco. Nello stesso tempo si costruì la via litoranea Genova-Vado. Allora la Postumia perdette la sua importanza militare e restò una strada commerciale fra Genova e la valle del Po. Questo spiega perchè la strada non fu più munita e perciò non conserva manufatti dell’epoca romana. Dopo questo mutamento si capisce che la stazione «ad Figlinas» sia stata spostata alquanto verso il mare ed abbia preso stanza nella pianura di Campi, molto più spaziosa e più adatta per il collegamento alla Genova-Vado.
A Campi i Genovesi andavano ad ossequiare Luigi XII e Carlo V, come nell’ epoca romana avranno ossequiato nello stesso accampamento, Giulio Cesare ed Augusto. Oltre ad essere più comoda, la pianura di Campi era ben difesa dal colle di Coronata e di Erzelle.
Ricostruendo la toponomastica antica io suppongo che «cen» si chiamassero i campi sotto Coronata — corn-i-cen, l’abitato in capo ai piani — co-nà, la regione nel cò, nel colle. Tutta la Liguria è piena di questi bellissimi «cornizen, cornize, cornigia» (11), che si spiegano molto bene studiando la conformazione dei luoghi, mentre è un assurdo inverosimile quello di trovare per ogni cornizen, cornize e cornigia il nobile «Cornelianus» che secondo le pretese leggi di glottologia avrebbe dato il nome a tutti questi luoghi. Resteranno famose negli annali delle aberrazioni scientifiche queste leggi glottologiche del secolo scorso, quando i glottologi affermavano che Arenzano è nato da Aruntius, Corneliano da Cornelius, senza pensare che Arenzano e Cornegliano non sono mai esistiti se non che nella penna degli scrittori, perchè in Liguria tutti sappiamo che ciò che negli elenchi ufficiali si scrive Arenzano è « A en cen » e ciò che si dice Cornigliano è « Cor n i cen ».
Intanto è bene prendere atto dell’ antichità di tutti questi paesi che sono sulla destra della Polcevera. L’esistenza del campo e della via romana ci avverte che si tratta di una zona archeologica importantissima. Come abbiamo trovato recentemente costruzioni romane sotto Fegino dove fa costrutta la fabbrica di birra, così si devono trovare vestigia romane al Boschetto, che pare sia stato in ogni tempo il luogo di una stabile mansione, a Campi, a Cornicen, e sull’altura di Coronata e di Erzelle, ove probabilmente era qualche specula a servizio del campo. Sono pure da segnalarsi come punti archeologici importanti sulla via Postumia la regione in fondo al Traste, ove doveva essere un ponte romano, e la regione in fondo al rivo di S. Biagio, ove era un altro ponte e dove troviamo un palazzo detto «in ra maion» parola che potrebbe accennare ad una importante magione antica. Proseguendo per la via Postumia troviamo «Iso corte e Ponte d’Edo» a piè della salita dell’Appennino. Non è giustificata l’opinione in cui siamo rimasti finora, che il nome di Pontedecimo rappresentasse nella terminologia romana il decimo ponte, o il ponte al decimo miglio, perchè si hanno sette miglia da Genova al Boschetto, e molto più di tre miglia dal Boschetto a Pontedecimo. Io sono pertanto propenso a credere che Pontedecimo voglia significare «Ponte d’ Edo», dal momento che la tavola di bronzo dà il nome di Edo al fiume Verde. Iso corte era probabilmente l’abitato antico, il coltivo (iso) più importante; un altro iso era più in alto sull’Edo e si chiamava Iso-Ede acconciato poi in Isoverde. Ponte d’Edo si chiamava probabilmente l’abitato «dal ponte» sorto come è naturale coll’apertura della via romana; e si capisce come da Ponte d’Edo possa essere nata la forma aggettivale Ponte dedemo e Ponte desemo, che sono le due forme fra le quali oscilla il dialetto.
Da Pontedecimo, passando sotto Cesino in vicinanza della villa Millo, si saliva a Pietra Lavezzara la « convallis Ceptiema » della tavola di bronzo. Il valico era a destra del Monte Poggio, sul quale sorgeva un castello per segnalazioni, il «Castelus Alianus» della tavola di bronzo. Dal monte Poggio la via andava all’antichissimo Fiaccone passando per la costiera di S. Grigheù. Ci richiamano a questo tracciato l’antichissimo convento di S. Grigheù, le tradizioni di Fiaccone relative ad una stragrande quantità di forni che esistevano in paese nei tempi antichi, quelle relative ai banditi che si erano annidiati nel medio evo sulla costiera, le memorie antichissime relative all’abitato della Traversa (12) e di Borgo dei Fornè. Da borgo dei Fornè la via scendeva a Libarna costeggiando la sinistra della Scrivia, seguendo un tracciato che si rileva ancora tratto tratto sulla costa della montagna poco discosto dalla via nazionale. Alla Pieve di Borgo Fornari, a Ronco Scrivia, ad Isola del Cantone, a Pietrabissara, a Rigoroso si può segnare il punto preciso ove passava la strada. Notiamo ancora che da Libarna a Borgo Fornari la strada serviva a doppio uso, perchè la popolazioni di Libarna, Asti, Acqui, Alba, che volevano andare direttamente a Roma, risalivano tutta la valle Scrivia e scendevano in val Lavagna per risalire il Bracco e scendere a Luni ove, per l’Aurelia, raggiungevano la capitale. Per questo la via di Valle Scrivia prese nel medio evo il nome di strada romea (I).
———————————-
(I) La via romea per valle Scrivia e val Lavagna non è segnata negli itinerari, perchè era essenzialmente una via di servizio locale, o come si direbbe al giorno d’ oggi, provinciale, la strada cioè di cui si servivano per andare direttamente a Roma le popolazioni del Tortonese, del Libarnese, dell’Astigiano e dell’Acquese. Nel 1906 fra Savignone e Casella si scoprì lungo la via delle tombe che contenevano fra l’altro una bella moneta d’oro di Antonino Pio. Altre tombe furono trovate a Ronco. Questa via si chiamava con molti nomi, di Valle Scrivia, di Fontan-a Bon-a, di Paderna, di Patrania, ed anche Petrania e Petronia. L’egregio Gerolamo Rossi (Atti Società Ligure di Storia Patria XXXIX) ha raccolto molti elementi storici a riguardo di questa strada, ma ciò che mi sembra importante a rilevare è questo :
1° Che era la via romea di cui si servivano i paesi d’oltre giogo, e perciò restò in attività nel medio evo per i continui pellegrinaggi a Roma, e perciò vi fiorirono più che altrove i castelli feudali, Pietrabissara, Borgo Fornari, Busalla, Savignone, Montoggio, Roccatagliata, S. Salvatore di Lavagna, e perciò diventò la base del dominio dei conti di Lavagna, che la custodirono gelosamente da Savignone a S. Salvatore, e perciò la troviamo nel medio evo frequentatissima dai Tortonesi, i quali hanno case commerciali e rappresentanze a Sestri, che per mezzo di questa strada fa commercio colla valle del Po (V. Cabotto e Legò, Carte di Tortona).
2. Che il nome di Petronia le è venuto non già da un Petronio romano, ma dalla natura dei luoghi. Dalle osservazioni fatte sui luoghi su vasta scala ho potuto convincermi che si chiamavano «Arni, Erni» i fiumi, i torrenti, (come ernia, e cav-erna la grotta fatta a cunicoli tortuosi). L’abitato fra gli arni od erni è «T-erni, Tr-arni o Trani, è N-arni è D-erna», e la via che segue la tortuosità dei torrenti è «pa d’ erna, pa t’ erna, pa trani-a» tre forme che corrispondono a Derna, Terni e Trani. Il pa-trani-a (tutta fra gli arni) è la stessa cosa che pe-trani-a, (per in mezzo agli arni). Chi sa come si pronunzia l’a nel versante nord dell’appennino, sa che il Petrania si pronunzia Petronia. La oscillazione fra patronia e petronia fu notata dal Fabretti in alcune lapidi (Corp. Inscr. ital., p. 1336). La oscillazione fra petrania e petronia è pure comunissima come avviene per Ferania e Feronia; il confronto è del Rossi ed è giustissimo. La via di cui parliamo si chiamava e si chiama ancora di Paderna verso il Tortonese, si chiamava invece Patrania in val Trebbia e val Lavagna. Bisogna conoscere bene l’Appennino ligure per capire la naturalezza di questa frase applicata a tale strada. Nulla di più accidentato di tutti quei torrenti e torrentelli tortuosi che formano l’alta val Trebbia e l’alta val Scrivia.
3. La via che era unica da Lavagna alla Scoffera si divideva in due a questo punto (crux patrania); una la (Paderna) andava per Valle Scrivia, l’altra la (Patrania) andava per Val Trebbia a Piacenza. Sulla Patrania di Piacenza erano nel medio evo due impianti benedettini, uno a To-ri-gia, l’altro a Monte Bruno, i quali, essendo riuniti sotto un solo Abate, formavano l’Abbazia di Patrania (vedi Rossi, op. cit.; Cabotto e Legò, Carte di Tortona).
4. Anche la via che da Sestri saliva alle Cento Croci per scendere in Val di Taro, pare avesse lo stesso nome, cosa naturalissima perchè le nostre popolazioni avevano lo stesso modo di esprimersi; «Patrania e Petronia» chiamavano la via nei fossati, «ban e banno» chiamavano la via sul monte (ba via, an in su). Tutta la Liguria è piena di monti detti Ao ban; cito l’ «Ao ban» in Genova, cioè il monte Castelletto menzionato nelle antiche carte come monte Albano, cito «monte Ban» sulla, via di Montoggio, «monte Banno» sulla via che dalla Piotta saliva alla Corina per venire in costiera al mercato di Mercuieù. I monti erano molte volte delle lunghe costiere, propaggini allungate verso il piano, che nel linguaggio del nostro Appennino si chiamavano «Coeùxue». Ricordo le capanne di Coeùxua in Val Borbera, la Coeuscia di Sampierdarena, la quale non è altro che la costiera che finisce al capo della lanterna. Chi da Torino guarda verso le Alpi vede le antichissime Coeùxue che i Romani tradussero in Cottine, come chiamarono Cottius il loro re. Chi dal piano di Alessandria guarda al sud vede le belle coeùxue ossia le propaggini dell’ Appennino che nel secolo sesto formavano la provincia delle Alpi Cozzie.
Da tutti questi rilievi fatti studiando la montagna in relazione ai suoi nomi siamo venuti a comprendere quanto sono distanti dalla realtà coloro, che studiando la topografia sui libri, andarono fantasticando dei Petronii, degli Albi, dei Cottii per ogni dove. Non parlo dei Carimi, dei Cornelii, dei Sergii, degli Aruntii, dei Vettii, dei Pabii, dei Copioni che furono regalati ai nostri monti, senza mai fare un’inchiesta semplicissima e vedere se l’apparente romanità dei nomi liguri non era lo scherzo di un notaio antico, o di un segretario comunale moderno, o di un compilatore di orarii di ferrovie, o di un geometra che redigeva le carte dello stato maggiore. Qualche rara volta costoro hanno dato nel segno applicando la vera forma glottologica latina, che corrispondeva al nome agreste che avevano per le mani. E so di uno studioso che si propone di dimostrare come si riattaccano al latino molti di quei nomi che io ho raccolto come liguri primitivi. La cosa non è difficile, ma s’ingannano gli studiosi che credono di provare con ciò la preesistenza del latino. Si proverà invece sempre meglio che sul linguaggio ligure italico primitivo si è formata la lingua latina, e che le forme tipiche primitive non sono scomparse come si è creduto finora.
————————
Nel medio evo, divenuta impraticabile la via di Valle Scrivia fu ripreso l’antico «ban» per Ciaccone, Porale, Pinovi, Borlasca, Monte Sucao, Sottovalle, Montaldo, Arquata (II), e contemporaneamente si attivò la strada Serravalle, Gavi, Voltaggio, Fiaccone. Poi nel sec. XVI venne la strada Gavi-Bocclietta, che fece dimenticare tutti questi tracciati antichi e determinò per molti secoli l’abbandono di Valle Scrivia.
—————————————-
(II) È la via più breve e doveva essere la via naturale e diretta per la Valle del Po, prima che fosse costrutta la via Postumia. Essa camminava sulla «seta o cheta» ossia sull’altipiano formato dalla costiera che va da Monte Poggio a Fiaccone, alla Castagnola, alla Bancheta, al Poà, a Costapelata ossia Borlasca. La Bancheta accenna al «ban in cheta» cioè alla via sull’altipiano, il Poà accenna «al passo». Nel Medio evo tutto l’esteso altipiano formava la «plebs de seta», il convento di S. Grigheù era in seta, come era in seta il convento del Poà. I frati del Poà che vivevano esercitando l’ospitalità su quella strada tenevano in Arquata una cappella, precisamente all’imbocco della strada di «Carrea» per cui si saliva alla costiera. (I documenti relativi sono pubblicati dallo Spadini nelle memorie relative all’Ospedale di Arquata)
L’ing. Navone, avendo rilevato i vantaggi che aveva questa bella strada per costiera, opinò che dovesse essere la Postumia, ossia la via romana fra Genova e Libarna. A questo riguardo si deve fare a mio avviso una distinzione.
Non è inverosimile che la via Postumia passasse in origine completamente per costiera da monte Poggio a Fiaccone, alla Banchetta, al Porale, a Borlasca, a Sottovalle, Montaldo, Badmei e Libarna, formando così la prima direttissima Genova-Arquata. Finché le gole dell’Appennino non furono definitivamente sicure i Romani dovevano preferire passare in alto, tanto più che si accorciava cammino. Ma questa strada sui monti non poteva essere che mulattiera, e perciò deve molto per tempo essere stata sostituita dalla via di Valle Scrivia, il cui tracciato, che si vede tuttora, permetteva il funzionamento dei rotabili. Il fatto che l’antica Plebs de Seta (Borgo Fornari) si collocò sulla via di Valle Scrivia nè è la prova più convincente. Certamente la via antichissima del Porale non fu mai abbandonata dai Genovesi cho volevano andare speditamente colle carovane da Genova a Libarna, e tornò ad essere la via più frequentata nell’alto medio evo, quando la via di Valle Serivia cadde in rovina.
Quanto all’abbandono della via di Valle Serivia, ho rilevato delle vaghe tradizioni che all’epoca delle invasioni longobardiche i Genovesi abbiano rotto la strada per mettere ostacoli agli invasori. Se il fatto è vero, esso probabilmente avvenne nel tempo che precedette la tanto temuta occupazione longobardica, e dopo l’aggressione dei Franchi. Del resto, anche senza l’opera dell’uomo, la rottura doveva avvenire da se dopo qualche secolo di abbandono, se si considera il percorso della strada fra Isola e Pietrabissara dove la montagna si presenta di pessima composizione ed essenzialmenta franosa.
A queste cause di distruzione si deve aggiungere l’opera nefasta dei feudatari, i quali rompevano le strade a scopo di concorrenza. I documenti per la storia di Gavi pubblicati dal Desimoni ci fanno vedere il Marchese di Gavi che per far passare le carovane per la Crena e per Gavi rompeva la «Sfrata Vallis Scripiae» nei pressi di Libarna.
Gli Spinola, che nel medio evo ebbero interesse a mantenere le comunicazioni fra i loro possedimenti di valle Scrivia, ripararono alle interruzioni trasportando in parte la strada nella destra sponda e facendo tre bei ponti medioevali, uno a Mareta, l’altro a Isola, il terzo a Ronco.
—————————-
La costruzione di una via militare fra Genova e Piacenza die’ luogo a diverse stazioni descritte negli itinerarii fra le quali noto Libarna e Der-thon-a. Questa era un oppidum antico, a pie’ del quale venne a collocarsi il campo, ossia la stazione romana, formando quel binomio che abbiamo rilevato in tanti altri paesi liguri, a Ventimiglia, a Luni, a Pisa, come a Genova. Libarna invece fu, a quanto si può arguire, un impianto esclusivamente romano fatto nell’agro dei Liborni, ossia dei Liguri montani, che avevano probabilmente il loro castello Ao coò (13). In un libro su Libarna dimostreremo come essa avesse acquistato importanza appunto come stazione, ove pernottavano coloro che venivano o andavano a Genova da Piacenza e Tortona, da Pavia, da Milano, da Vercelli, da Asti.
181 a. C. In quest’anno avviene la definitiva conquista del territorio di Albenga. Ho riferito nelle «Due riviere» le vicende della guerra fatta agli Ingauni dal Console Paulo Emilio, l’assedio posto dagli Ingauni al campo romano, e la caduta della città ligure. Nel campo di Genova sostarono certamente le legioni romane già combattenti in Albenga, e con esse gli sventurati Ingauni che Paulo Emilio portò incatenati a Roma per arricchire il suo trionfo.
173 a.C. È la volta dei «Sascelin» (14) che gli scrittori romani chiamarono «Statielli e Statiellates». Furono brutalmente aggrediti nelle loro valli dal Console M. Popilio Lenate ed assediati in Cairo (Carystum) (15) ove si erano fortificati. Gran parte di essi furono uccisi, gli altri si arresero a discrezione. M. Popilio infierì contro i vinti che domandavano pietà. Distrusse Cairo, vendette i vinti e i loro beni. La cosa parve enorme al Senato, il quale rilevava, dice Livio, XLII. 8, che gli Statielli erano gli unici «uni ex Ligurum gente» che non avessero preso le armi contro i Romani. Ed ordinò che ai Sascelin fosse data una riparazione, restituita la libertà, i beni e le armi.
È notevole il passo di Livio, perchè fa pensare che anche i Genovesi avessero in antico rivolto le armi contro Roma. Probabilmente nel sec. III, quando i Cartaginesi avevano preso il sopravvento e facevano grandi leve in Liguria, anche i Genovesi avranno dato a nolo le loro navi e le loro ciurme ai Cartaginesi. Poi, vedendo come si mettevano le cose, avranno preso definitivamente le parti dei Romani.
172 a. C. Avviene un fatto che merita tutta la nostra attenzione. Essendo il popolo e il Senato, irritati per il contegno di M. Popilio Lenate, che non obbediva agli ordini del Senato, e volendo dare una soddisfazione ai Liguri, si elegge per la prima volta un console di origine ligure, Publius Aelius Ligus (16). Ma la famiglia dei Popilii era riuscita a mettergli a fianco come collega C. Popilio Lenate fratello di Marco. Per cui alla fine del 172 si discuteva ancora sull’affare di quei di Sascè, senza che i consoli nulla avessero fatto, senza che nemmeno si fossero recati in Liguria (17). Il pretore C. Licinio fu incaricato di un inchiesta a carico di M. Popilio Lenate ma furono ritardate tanto le cose che non se ne fece più nulla. Soltanto sulla fine del 172 i consoli vennero in Liguria a prendere da Popilio Lenate la consegna dell’esercito che operava in val Bormida (18). Intanto costui si vantava di aver ucciso nel frattempo altri 10.000 Sascellini. Ed il Senato era irritatissimo perchè il fatto aveva sollevato e messo in armi tutti gli altri Liguri (19).
Per andare da val Bormida a Poma e viceversa si passava per Genova, e Livio (XLII, 9) ci fa vedere il console Popilio Lenate che conduce le legioni da val Bormida a Pisa. Questi fatti rendono sempre più manifesto come dovesse funzionare in Genova un campo romano.
Ai Sascellin restituiti in libertà fu assegnata della terra «trans Padum» (20). Non sappiamo precisamente in qual punto, ma quando si riflette che Lib-or-ni significa Liguri nei monti (or), io sono propenso a ritenere che la regione da essi occupata fu quella di Liborno vercellese. Allo stesso modo un nucleo di Liguri Apuani deve essere stato trasportato oltre l’Arno, ed aver dato origine a Livorno toscano (21).
Quanta storia scaturisce da queste fonti inesplorate finora! Volendo limitare le nostre considerazioni a ciò che riguarda semplicemente Genova, non possiamo a meno di segnalare questi riavvicinamenti: Publius Aelius Ligus è console in Roma nel 172 — C. Aelius Ligus è questore, avvocato, grande affarista in Roma ai tempi di Cicerone, ed i Genovesi, come vedremo fra poco — un Aelianus è poi decurione in Genova come risulta dalla lapide sopra ricordata. Si delinea dunque un grande casato che aveva le sue origini in Genova, che aveva fatta la sua fortuna in Roma fin dal 172 a. C., ciò che dimostra la rapidità con cui i nostri profittarono dell’alleanza con Roma. Il nome di Elio conferma l’origine ligure perchè abbiamo già constatato quanto fosse divulgata fra i Liguri la divinità solare che si denominava Elio, Abelio, Beleno e Belieno. Questo nome era tanto radicato in Genova che sopravvisse anche nel medio evo. Infatti troviamo il nome personale di Eliano per i maschi ed Eliana per le femmine, che si ripete in molte famiglie medioevali. Ma ciò che è veramente singolare è il fatto che il ligure P. Elio arriva nel 171 al supremo comando in Roma. Genova non aveva ancora avuta la cittadinanza collettiva, quindi si deve ritenere che il P. Elio abbia ottenuto l’onore grandissimo a quel tempo, di essere fatto cittadino romano per legge speciale, come Roma soleva fare per ingraziarsi uomini influenti delle varie regioni che a lei interessava di cattivare (22). A quel tempo la conquista dei Liguri era ancora uno spinoso problema per la repubblica, e si capisce che questa cercasse di accaparrare quà e là ilei Liguri influenti per giovarsene al momento opportuno come elemento di pacificazione. P. Elio ligure dovette probabilmente il consolato a quella sua qualità di «Ligure», come negli usi moderni deve sovente un ministro la sua nomina al fatto di appartenere ad una più che ad un’altra regione d’Italia.
170 a. C. La guerra proseguiva ancora nelle regioni Apuane. E Livio ci fa vedere il console A. Postumio Albino che, dopo aver sbrigata la guerra, si mette in giro d’ispezione «ad visendam oram Ingaunorum Intemeliorumque». Si navigava lungo la riva e la piazza forte di Genova non era certo pretermessa in queste ispezioni.
137 a. C. In quest’anno abbiamo ancora una notizia su Genova da Valerio Massimo. Egli ricorda che il Console C. Ostilio Mancino, recatosi a Porto d’Ercole (Monaco) per imbarcarsi per la Spagna, fu trattenuto da sinistri presagi. Venne per imbarcarsi a Genova, ma, appena messo piede, in una barca, vide un gran serpente di mare e tornò indietro. I Genovesi, che assistevano dalla riva, dovevano sorridere, vedendo il console romano che faceva la parte del «milanes in mar» e si spaventava del guizzo di qualche delfino (III).
———————————–
(III) Ma se il racconto si presta al ridicolo, ha sotto un altro aspetto un lato serio, che merita di essere rilevato. È l’interesse che pongono gli scrittori romani nel giustificare coll’intervento di una volontà soprannaturale le batoste che i Romani ebbero a subire, come tutti i popoli che vanno incontro alle eventualità delle guerre. Il Console C. Ostilio Mancino, con un esercito di 30.000 uomini, era stato colto di sorpresa e ignominiosamente sconfitto da 4.000 Numnntini in Spagna. L’effetto morale poteva essere disastroso; ed ecco gli scrittori che si accordano nel divulgare che la sconfitta era spiegabilissima, perchè gli dei avevano preavvisato. A Lanuvio i polli erano fuggiti mentre il Console Mancino tentava gli auspici, a Monaco una voce misteriosa aveva gridato: «Mancin, Mancin, non partire», a Genova era comparso l’ «anguis mirae magnitudinis». La cosa era chiara! Avventurarsi dopo questi presagi era cosa da matti! Si può sorridere pensando che bastava così poco per ingannare il volgo, ma nello stesso tempo dobbiamo riconoscere che esisteva nelle classi dirigenti uno spirito pubblico, che spesse volte fa difetto ne’tempi nostri.
Nel medio evo lo spirito pubblico generale risente talmente della tradizione romana, che, ad ogni contrarietà, ad ogni disastro, si trova subito il suo perchè nei fenomeni soprannaturali. Quando i Saraceni nel X secolo riescono a sorprendere Genova e saccheggiarla si sparge subito la voce, la quale restò nelle cronache, che la fontana del molo avesse gettato sangue per tre giorni. Chi fece questa bella scoperta aveva certamente letto in Livio del fiume Amiterno, che aveva portato sangue, (XXIV-44) e della fontana d’Ercole, che aveva dato acqua macchiata di sangue (XXII-1). Tutti i fenomeni tramandati da Livio sono utilizzati nelle cronache di Genova e riferiti dal Giustiniani.
Nè si può dire che la tradizione delle superstizioni sia del tutto spenta. Vige in molte parti d’Italia il pregiudizio della iettatura, e dei giorni nefasti, si crede agli indovini e allo spiritismo, mentre si ostenta come segno di superiorità il materialismo scientifico e la negazione di ogni idealità religiosa.
————————–
109. Si compie in quest’anno la sistemazione stradale della nostra Liguria. Da Luni a Genova, da Genova a Vado erano dei sentieri di montagna, quasi impraticabili ai grossi eserciti. Venne a proposito la guerra coi Cimbri, la quale rese necessaria una strada littoranea la quale doveva portare direttamente gli eserciti alla regione invasa, la Provenza. Ed ecco Emilio Scauro, che costruisce la via littoranea Pisa, Genova, Vado, allacciandosi coll’antica via d’Ercole, che conduceva da Vado a Monaco e alla Provenza. Si costrusse pure il tronco Tortona, Acqui, Vado (IV).
————————————
(VI) Il Rossello «sulla condizione giuridica di Genova nell’ epoca romana» ritiene che non risulta in che anno preciso fosse costrutta e da chi, e dove finisse. Ma non si può dire questo, finché esiste il testo di Strabone, il quale cita il nome di Emilio Scauro ed aggiunge «Is est Scaurus, qui viam Aemiliam stravit, quae per Pisam et Lunam ducit ad Sabbatos, indeque per Derthonam». Il Rossello ha confuso ciò che il Mommsen scrive a riguardo della Aurelia vetus da Roma a Volterra» colla aggiunta fatta da Emilio Scauro da Volterra a Vado. A riguardo di questa il Mommsen scrive: «Haec igitur Aemilia Scauri a Volterris ad Vado Sabatia usque strata est anno a. C. 645». L’Ab. Oderico e l’Ab. Sanguineti hanno esaurientemente spiegato il testo e l’andamento della strada. Io l’ho descritta nelle «Due Riviere». Ora mi occupo più specialmente di chiarire le ragioni storiche che la determinarono.
—————————
E poiché le basi militari erano diventate Genova e Piacenza, si capisce molto bene il concetto di Emilio Scauro; far convergere a Vado gli eserciti mediante due strade una da Piacenza «per Derthonam» l’altra da Pisa «per Gènuam». La Pisa-Vado non ebbe forse mai tanta importanza come in quel periodo che corre dal 109 al 102. Quante legioni destinate a soccombere passarono allora da Genova e pernottarono in Soziglia per riprendere silenziose la via di Vado!
Fu una vera ecatombe di eserciti (V),
——————–
(V) Il console Silano battuto nel 109 — il console Cassio Longino preso in un’imboscata e ucciso colla maggior parte dell’ esercito — il comandante Caio Popilio obbligato a passar sotto il giogo (107) — la città di Tolosa che fa prigioniero il presidio romano (107) — Marco Aurelio Scauro ucciso (105) — il Console Cepione sconfitto a Orange e perduto interamente un esercito di 120.000 uomini. (Mommsen, Storia di Roma, lib. IV Cap. V).
È il periodo più sconfortante della storia di Roma, conseguenza dell’anarchia in cui aveva gettato la repubblica la lotta interna. È pure il tempo dei processi scandalosi di corruzione, intentati contro i molti consolari e tribuni della plebe, che si erano lasciati corrompere dall’oro dell’africano Giugurta — contro il console Cepione, che era accusato d’aver tolto gli immensi tesori del tempio di Apollo Beleno a Tolosa e di esserseli appropriati sotto pretesto di esserne stato derubato, ed inoltre di aver cagionato la perdita di 120.000 uomini per le sue rivalità col collega Gn. Manlio Massimo — contro M. Emilio Scauro. Presidente del Senato, accusato di aver preso denaro da Giugurta e di aver malversato il denaro pubblico quando costruiva le strade della Liguria. Al solito fu nominata una commissione inquirente e Scauro riuscì a farsi eleggere come uno dei componenti. Molti furono condannati, molti altri, forti o di denaro o di aderenze, furono assolti. E Scauro rimase presidente del Senato; Roma repubblicana era già profondamente corrotta, e non è a maravigliarsi se presto comparirà l’impero.
————————–
finche Roma non trovò il suo salvatore in Mario, il vincitore della battaglia di Aix (Aquae Sextiae), in cui 200.000 barbari furono di strutti. In quella circostanza divenne proverbiale la resistenza ed il coraggio dei Liguri; giacché, mentre a Roma la gioventù spaventata si sottraeva alla chiamata della leva, i Liguri accorsero in gran numero, e costituirono quei soldati d’acciaio, che furon detti i «muli di Mario», e furono i primi ad avventarsi sul nemico alla battaglia di Aix, sollevando quello storico grido: «Ambro, Ambro», che essi stessi confessarono essere il nome della loro nazione (23).
Non abbiamo una iscrizione che dica che in quei tempi fortunosi le legioni romane abbiano pernottato nel campo di Genova, ma se la strada fu fatta in fretta e furia per questa guerra, se era la più breve fra Roma e la Provenza, è logico il ritenere che molte di quelle sventurate legioni abbiano traversato la Liguria. Non si tratta di fatti i quali «possono» ma che «devono» essere avvenuti. E così scrivendo ci pare di assolvere il delicato compito della storia che consiste nello scrutare i fatti e dedurne le conseguenze, e non già nell’assistere indifferenti allo svolgersi dei fatti, come al passaggio di una gran fiumana, senza nulla discernere.
Colla costruzione della via Aurelia la Liguria è sistemata, e Genova si appresta a godere i frutti della nuova sistemazione. Come la via Postumia fu l’inizio dei grandi commerci colla valle del Po, così la via littoranea aprì le comunicazioni fra la Liguria e la Provenza. Vedremo in seguito quanta influenza abbiano avuto questi due grandi centri, Milano e Provenza, sullo sviluppo civile, religioso ed artistico della nostra città.
Note. (1) G. Poggi, Luni p. 11 o segg. (2) Sul binomio delle città romane vedi la mia nota in fine. (3) Vedi «Notizie degli Scavi» degli ultimi vent’anni, e i miei appunti su «Libarna».
(4) Negli «Studi in onore di Carlo Fadda». (5) Liv. XXVIII. 46. (6) Quei di Val Tanaro. (7) G. Poggi, La spedizione di Tripoli nel 1578. (8) G. Poggi, Le due riviere. (9) Liv., Libro XL. (10) È tempo che gli Italiani studino a fondo le questioni archeologiche del loro paese senza mettere come pregiudiziale l’opinione del Mommsen. Questi fu un gigante dell’ epigrafia latina, ma non tutti i problemi storici e topografici furono da lui risolti. Come dobbiamo rettificare il tracciato della via Tortona-Asti, che egli fa passare a Valenza mentre passava al Foro di Alessandria, così dobbiamo rettificare l’erronea interpretazione che egli seguendo il Rudorff ha dato alla tavola di bronzo. Mommsen del resto non ha mai preteso di aver detto l’ultima parola sulla condizione dei nostri paesi nell’epoca romana. Egli mirava ad illustrare le iscrizioni riassumendo per ogni città le notizie che si avevano al tempo in cui egli scriveva. Ma fece ben intendere, specialmente per quanto riguarda Genova, che molte oscurità rimanevano a chiarire: e non avrebbe certamente sdegnato, essendo mente elevata ed amante delle ricerche, che si iniziassero al riguardo nuovi studi. (11) A Marsiglia la splendida passeggiata de la «Corniche», in riviera di Ponente «la Cornice», in riviera di Levante Corniglia, e qui Corniscén. (12) L’ espressione «via transversa» è propria della terminologia romana. La Traversa a cui accenniamo è la via che da Fiaccone si dirige a Borgo Fornari. Essa diede il nome di «Traversi» a molte famiglie di quella località. (13) Arquata è nome fittizio. La parola vera è coò, colle, capo, promontorio, come si rileva dal dialetto, il quale declina il nome così: O coò, du coò, to coò, ao coò, e coll’articolo er: er coò, der coò, ter coò, ar coò. (14) Prendendo per norma il linguaggio dialettale che dice «Sascè» uno dei centri più antichi della regione, opino che la parola «Statielli» sia traduzione di «quei di Sascè». La parola non mi vien nuova perchè in tutta la Liguria trovo l’ «asca» che significa valle, canale, «Ascile» gli abitanti dell’Asca. Coll’articolo ta (nella) noi abbiamo Tasca e Taschè e col prefisso sa abbiamo Sasco, Sasca, Saschè e Sachè. Di qui il borgo Sasco, Tascherio o Sacherio nei documenti, che raddolcito divenne «borgo sacco». (15) Ecco un bell’esempio dell’Astu primitivo: l’astu di Cairo è «Cary-stu ». (16) Liv. – XLII, 9. (17) Liv. – Xt.II, 10-21. (18) Liv. – XLII, 22. (19) Liv. – XLII, 21. (20) Liv. – XLII, 22. (21) Così è probabile che abbiano avuto origine da altre deportazioni di Liguri il Ligornetto di Mendrisio, il Ligurno di Varese. (22) Vedi sulla cittadinanza accordata «viritim» per legge speciale Livio, XXXIII, 31. (23) Plutarco, Vita di Mario. Dimostreremo in una nota come vi siano molti elementi storici, i quali confermano che veramente Ambroni, Ombroni, Ombrichi, Obrichi fosse il nome che avevano i Liguri in casa loro.
* * *
202 a. C.
IL CAMPO ROMANO NELLA VALLE DI SOZIGLIA
Poggi G., Genova preromana, romana e medievale, in Genova, Giovanni Ricci editore, Libreria Moderna, Galleria Mazzini, 1914
SOMMARIO: Elementi raccolti per la ricostruzione e criteri seguiti — I documenti medioevali — Gli insegnamenti della gromatica romana — Il muro da Castelletto a Castello — Descrizione del campo in Soziglia — Fortezza a Castelletto — Il fossato — Programma strategico e politico dei Romani — Il pretorio — I postriboli — I fabbri — Il sepolcreto fra la città e il campo — Il campo di Marte.
A identificazione della «Statio» ossia del campo romano ha una capitale importanza per chi vuole formarsi un’ idea concreta sulle origini di Genova. ìfon esistono documenti al riguardo. Ma esistono però molti dati storici, molti fenomeni locali, che non furono mai studiati sotto questo punto di vista, e possono contenere il segreto di ciò che andiamo cercando.
Si ricava da Livio che Spurio Lucrezio fu pretore nella Gallia Cisalpina (alta Italia) nel 505 e 501 a C. Sappiamo che l’ufficio di pretore nelle provincie era essenzialmente quello di provvedere all’ordinamento militare ed amministrativo. Sappiamo che nel 503 furono prorogati a Spurio Lucrezio i poteri « ut Genuam oppidum a Magone Poeno dirutum exaedificaret » (1).
Per decretare una proroga di poteri bisogna che i lavori avessero un grande interesse politico, ed è facile immaginare che le istruzioni affidate a Lucrezio andassero più in là del semplice desiderio di aiutare i Genovesi nel ricostrurre le loro case, che dovevano essere in gran parte di legno.
Roma era solita a prendere più di quello che dava. Probabilmente la generosa offerta, che si faceva ai Genovesi, era accompagnata dalla proposta di impiantare un campo militare che avrebbe servito a difendere la città da nuovi assalti. Ed i Genovesi, diffidenti e cauti per natura, avranno discusso a lungo il prò ed il contro. Non era tanto la riedificazione della città che loro stava a cuore, quanto la preoccupazione della guerra coi Cartaginesi, nemici implacabili e forti. Gli interessi di Genova coincidevano oramai con quelli di Roma; bisognava intendersi con essa per non restar soli. D’altra parte i Romani avranno fatto intravedere ai mercanti Genovesi nuovi e grandi orizzonti; distrutta Cartagine, essi ne avrebbero preso il posto sul mare, protetti dalla forza di Roma. A calcoli fatti i vantaggi sperati, e più di tutto il salvarsi da ulteriori vendette meritavano il sacrifizio della propria autonomia, e la proposta sarà stata accettala dai Genovesi, pur sapendo che si mettevano un padrone in casa, e non sarebbero più stati i soci ma i sudditi di Roma.
La ricostruzione storica del campo romano che sottopongo al lettore, risulta da un complesso di elementi da me raccolti, 1° dalla tavola peutingeriana e dal calcolo delle distanze, 2° dall’osservazione dei luoghi, 3° dalle notizie del medio in quanto esso rivela uno stato di cose più antico. Utilizzai come criteri direttivi le cognizioni archeologiche raccolte dagli scrittori a riguardo dei campi militari, e le osservazioni dirette da me attinte sui campi romani di Liburna, Luni, Aosta e Torino.
È noto come gli itinerari romani segnano indistintamente col nome di «stazioni» i luoghi ove gli eserciti avevano un vero campo stabile, come i luoghi che erano destinati ad offrire un momentaneo riposo e un po’ di rifocillamento agli eserciti in marcia. Genova, Vado, Albenga, Ventimiglia, sulla via littoranea erano veri campi militari, come Libarna e Tortona sulla Postumia. Ivi gli eserciti pernottavano, ivi si rifornivano, senza parlare delle truppe, che dove più dove meno vi risiedevano. Erano invece stazioni di momentaneo riposo per gli eserciti, ed erano sopratutto mansioni ad uso delle corriere e della posta imperiale, quelle che esistevano fra un campo e l’altro, per esempio Pra, Arenzano e Albissola (Hasta, ad Navalia, Alba Docilia) fra Genova e Vado (2).
A Genova capo linea della via Postumia, punto di sbarco e di imbarco importantissimo, non poteva mancare un campo, una stazione militare in tutta regola. Dalla tavola peutin- geriana risulta che la stazione di Genova era a sette miglia da quella «ad Figlinas» che abbiamo identificato con Fegino in Polcevera, o meglio con quel terreno pianeggiante che esisteva sotto il convento del Boschetto e che, per meglio precisare io identificherei col piano di Campi (3). Le sette miglia ci portano vicino a S. Siro. Un altro dato ci viene dal paese di Quarto, perchè essendo i nomi di Quarto e Quinto un avanzo di nomenclatura romana, in quanto significano il quarto e quinto miglio «a Genua» è facile riscontrare che le quattro miglia ci portano al colle di Piccapietra (4). Un altro elemento ci è fornito dalla tavola peutingeriana in quanto assegna alla stazione di Genova due depositi di rifornimento. Questi depositi, che erano destinati essenzialmente a custodire le provviste del grano, ci fanno intendere che il campo doveva essere vicino al mare, dal quale venivano le vettovaglie.
Un’altra osservazione che si presenta ovvia è che la stazione per gli eserciti non poteva essere nell’oppidum, troppo ristretto per albergare cittadini e milizie ad un tempo. Del resto i Romani non fecero mai di questi accoppiamenti essendo troppo gelosi del carattere militare, della disciplina, dell’ordine che doveva esistere nei loro campi.
Con questi criteri preliminari ci siamo spinti innanzi nelle indagini per vedere quale poteva essere il luogo più adatto per un campo romano in Genova, ed abbiamo constatato che ogni probabilità è per la valle di Soziglia per le seguenti ragioni: 1° perchè vicino all’oppidum e al mare, onde venivano le vettovaglie e i materiali di rifornimento; 2° perchè la valle di Soziglia unicamente presentava il vantaggio di essere ben protetta dai venti di tramontana, molesti in Genova più che altrove; 3° perchè la valle di Soziglia aveva un requisito di valore inestimabile per un campo militare, l’abbondanza dell’acqua, e ciò in grazia di quelle fontane marose, che scaturivano in fondo al rivo di Bachernia, le quali erano così copiose da alimentare uno speciale acquedotto, come risulta dallo Statuto dei Padri del Comune pubblicato dal De Simoni (5); 4° perchè gli scavi del 1901 ci hanno fatto vedere un acquedotto romano, fatto più tardi, il quale scendendo da piazza Manin camminava lungo il colle di Piccapietra fino a Ravecca, ed è logico il ritenere che il campo fosse il primo a godere di quest’opera di carattere essenzialmente romano. Il campo doveva necessariamente trovarsi nella regione sottostante.
I documenti e le notizie ricavate dal medio evo confermano l’ipotesi del campo romano in Soziglia. Cito prima di tutto il fatto che era rimasto sinora senza spiegazione, per quanto risultasse da documenti, che prima della cinta del 1154 esisteva nella valle di Soziglia una «porta nova» che dava il nome alla Compagna localizzata nella regione della Posta vecchia e di Pelliceria — che un’altra porta esisteva sull’altura di Piccapietra presso la quale aveva sede nel 1130 la «Compagna di Porta», ed un’altra porta ancora era nell’altura di Luculi che si chiamava «porta fico» nome che sopravive in un vicolo laterale a via Carlo Felice — 2° il fatto che prima della cinta del 1154 la valle di Soziglia faceva parte della «civitas» e il «borgo» cominciava al Fossatello (Vedi in seguito la descrizione delle Compagne) ; 3° il fatto che quando i Milanesi vengono ad abitare in Genova, nel secolo VI, pullulano le Chiese da S. Siro a S. Pancrazio, a S. Marcellino, a S. Fede, a S. Sabina, ma non una chiesa sorge nella valle di Soziglia, ciò che vuol dire che quello spazio era diversamente impegnato, e che in esso stanziavano le milizie bizantine destinate alla difesa di Genova; 4° il fatto che nell’epoca carolingia il Vescovo diventa padrone della valle di Soziglia, che la dà a censo a quelli che ne fanno richiesta. Questo fatto, che risulta dal «Registrum curie» (6) è della massima importanza, perchè viene a confermare la demanialità antica. Infatti si è constatato che in tutte le nostre città romane, a Luni, a Libarna, a Tortona, ad Albenga è sempre la Chiesa che subentra nei beni che costituivano nell’epoca romana il demanio pubbico, campi, fori, basiliche; 5° il Castelletto soprastante alla valle di Soziglia diventò pur esso un possesso del vescovo, ciò che vuol dire che era demaniale in antico. Il nome carolingio di chàtelet, significa fortezza, e se la fortezza esisteva prima del 1000 era verosimilmente cosa romana. Una fortezza o castello in quel punto integra il concetto dell’impianto romano perchè anche a Luni, ove erano le montagne sovrastanti al campo, noi vediamo che questo era presidiato da un castello detto l’«acron Lunae» (7).
Sono tutti fatti che, isolatamente presi, non valgono come dimostrazione decisiva, ma una volta messi a confronto gli uni cogli altri si fortificano a vicenda, e formano non un filo ma una vera catena che allaccia il mondo medioevale all’antico.
L’alto medio evo non è che un pallido riflesso della romanità spenta. Una grande storia alita fra gli avanzi scheletrici di quel tempo. Bisogna interrogarli con pazienza e con discernimento archeologico, e presto o tardi ne vien fuori l’immagine ricomposta dell’epoca romana.
Altre coincidenze balzeranno fuori studiando la disposizione interna del campo.
Per ricomporre un campo romano abbiamo preziosi elementi nei trattati di gromatica e negli splendidi lavori del Mommsen, del Nissen e del Marquardt (8). Il campo era di regola orientato da levante a ponente. Quando si poteva avere il vantaggio di collocare il campo sopra un pendio, il pretorio era sempre in alto e il corpo delle milizie in basso, perchè queste potessero vedere da ogni parte il padiglione del duce. La valle di Soziglia pareva creata appositamente per adattarsi a questi scopi. Ho esaminati tutti i campi romani della Liguria, Luni, Vado, Albenga, Ventimiglia, Libarna, e posso affermare che nessun altro raggiungeva una così felice combinazione di requisiti tutti confacenti alla regolarità, alla bellezza, alla salubrità dell’accampamento. Se il campo si fosse collocato tra Fossatello e il rivo di S. Fede, come altra volta ebbi a supporre, restava orientato a tramontana ed esposto ai venti; se si fosse collocato fra S. Stefano e il Bisogno, che è la terza ipotesi discutibile, il campo sarebbe rimasto orientato a ponente e fuori del contatto del porto.
Il campo romano formava un quadrato che era tagliato in mezzo da una strada che si chiamava il decumano. Altre due strade equidistanti a destra e sinistra del « decumanus maior» costituivano i «decumani minores». Il decumanus maior portava direttamente al pretorio. In cima al decumano, dietro il pretorio era una porta detta «porta pretoria», e in fondo al decumano era un’altra porta detta la «decumana». Il campo era inoltre traversato a circa 2/3 od 1/4 da un’altra strada in senso traversale la quale si chiamava il «carda maior» o la «via principalis». Essa tagliava il decumano ad angolo retto passando dinanzi al pretorio, ed aveva alle sue estremità due porte, che erano dette la «dextera» e la «sinistra» del campo. Vi erano poi altri «cardines minores» che finivano per dare al campo la figura di uno scacchiere perfetto.
Il problema si riduce quindi a stabilire il «decumanus maior» e il «cardo maior» su cui tutto il campo si imperniava.
Istintivamente si comprende che il decumano, che correva da levante a ponente, doveva partire da Porta d’Oria ossia dalla porta di Piccapietra e scendere verso il mare. Ma qual era la sua precisa direzione?
Se noi riusciremo a stabilire almeno un lato qualsiasi del campo il problema sarà risolto, perchè, essendo la figura del campo un rettangolo perfetto, basterà tracciare una linea che da porta Piccapietra corra perpendicolare o parallela al lato scoperto per avere il decumano.
Ed è questo il sistema che abbiamo seguito o meglio che ci fu dato di seguire, avendo potuto identificare un muro che costituiva il lato di ponente del campo.
Esiste un’antica tradizione che anche il Belgrano raccolse (9), senza averne potuto dare una spiegazione soddisfacente, che esistevano mura in vico del Fornaro. La tradizione è seria e attendibile perchè è appoggiata a documenti. Infatti gli annali di Caffaro al 1130 parlano della Compagna di «Porta nova» la quale si trovava precisamente in questa regione. Il muro poteva essere una fantasia ma la porta ne conferma l’esistenza. Io volli fare indagini al riguardo, e trovai nei fondi di palazzo bianco, sotto le sale del museo, un grosso muro romano, tuttora esistente. He rilevai la direzione e constatai che esso camminava precisamente in direzione di vico del Fornaro. Feci altri assaggi, e il grosso muro, sempre sulla stessa linea, ricomparve in piazza della posta vecchia nella cisterna che è sotto la bottega segnata coi n. 5 rosso, casa Bolasco. Avevo finalmente il punto «ubi consistam» e potevo tentare la ricostruzione del quadrato, tenendo questa linea per uno dei lati.
Ed il campo romano m’apparve con una regolarità meravigliosa. Tracciando una perpendicolare da porta Piccapietra ottenni una linea che veniva diretta alla piazzetta di San Sepolcro dalle Vigne. Sarebbe il decumanus maior, che avrebbe avuto la sua porta pretoria in Piccapietra, dove ancora attualmente è il valico che conduce in Portoria, e la sua porta decumana in piazzetta S. Sepolcro, ove ogni Genovese sa esservi uno dei passaggi più frequentati, per cui si entra nella valle di Soziglia.
In senso trasversale trovo l’antica strada di S. Sebastiano, l’unica che si presenta perfettamente parallela al muro teste accertato. Essa va a tagliare ad angolo retto il decumano in fondo a via Roma, precisamente davanti a quella domoculta che ci è descritta come una costruzione forte e sopraelevata nei documenti medioevali, e che probabilmente
era formata dai muri dell’antico pretorio. E così vengo a capire come la via S. Sebastiano, che sarebbe stata la gran via del campo, portasse in antico quel nome caratteristico di «Pa-via» che risponde al concetto di via maestra, di contrada principale, essendo il «pa» un prefisso che significa «affatto, del tutto». E comprendo come in capo a questa contrada dalla parte verso tramontana vi dovesse essere una porta, probabilmente detta di Luculi, per cui si andava al monte passando per i bei luculi della Villetta Dinegro e dei Cappuccini. Non era ancora stata scavata via S. Catterina, e perciò da via S. Sebastiano si andava al monte con regolare pendenza. All’altra estremità verso piazza De Ferrari era la porta sinistra, che metteva all’oppidum dei Genovesi.
Il campo aveva probabilmente non una ma tre porte a levante, e tre porte a ponente. Ce lo suggerisce lo studio della città medioevale ed anche della città attuale la quale, strano ma vero, conserva ancora nei suoi passaggi a monte e a mare i punti fissi della castramentazione romana. A Porta pretoria (Piccapietra) si aggiungano due porte equidistanti corrispondenti ai due decumani minores, e ne vien fuori Porta Fico in cima a vico di Porta Fico, ed un’altra porta corrispondente all’antichissimo valico che si apriva sopra la salita di S. Matteo da una parte e la via del Vento, poi via Giulia, poi via XX Settembre, dall’altra. Queste due porte trovano una perfetta corrispondenza nei passaggi verso il mare, che sono frequentatissimi oggi come in antico, Banchi e via della Maddalena. La porta nova di cui parlano gli annali al 1130 sarebbe la porta che era in capo a via della Maddalena e che si apriva sopra la via di «Manusola» che portava in Castelletto.
Oltre alla porta dextera della via principalis doveva esistere un’altra porta verso il monte corrispondente alla via così detta «quintana» quella per cui abitualmente uscivano i soldati. Essa doveva trovarsi in corrispondenza del vicolo che è dietro il coro della Maddalena.
Tutti questi fenomeni si comprenderanno meglio esaminandoli nel loro insieme nella carta topografica che va unita al volume.
Tutta la valle di Soziglia cambiò d’aspetto quando, cessato il campo, fu fabbricata fra il 1000 e il 1200, ma le porte del campo romano continuarono a segnare gl’ingressi alla valle perchè servirono di barriere daziarie intorno al mercato. Di questo fatto importantissimo parleremo a suo tempo, e sarà una conferma decisiva di quanto siamo venuti esponendo.
Era questo campo cinto di mura ? Probabilmente non lo era dalla parte verso la città, e nemmeno dalla parte del colle di Piccapietra perchè bastava la difesa naturale dell’altura. Forse aveva delle torri, e lo vedremo quando si demolirà il colle di Piccapietra. Aveva probabilmente un fossato nella direzione di via Garibaldi, ed altre difese di cui parleremo fra poco. Aveva un solido muro dalla parte di ponente.
Dalla parte di Castelletto nulla ho potuto rilevare di concreto. Ma il nome di Castelletto, risalendo ad epoca anteriore al 1000 fa ritenere che un castello romano ivi esistesse allacciato al campo per mezzo del gran muro di difesa a ponente.Questa circostanza richiama alla mente un’altra ipotesi che cioè l’antichissima torre di Luculi (villetta Dinegro) facesse parte del sistema romano, e che un altro muro partisse dall’angolo Nord est del campo e andasse alla torre di Luculi, di qui al Portello e dal Portello a Castelletto, opponendo così una valida difesa a chi volesse invadere il campo e la città dai monti che sovrastano dalla parte di tramontana. Era infatti il lato che insieme a quello di ponente presentava maggior pericolo in caso di assalto.
Lungo il lato nord del campo doveva pure trovarsi, come si disse, un fossato; 1° perchè ragioni strategiche lo consigliavano; 2° perchè bisognava dare uno sbocco fuori del campo al rivo di Bachernia; 3° perchè i documenti ci attestano che questo deviamento deve essere avvenuto, come dimostreremo parlando della domoculta delle Vigne; 4° Perchè abbiamo riscontrato un fatto identico a Liburna, ove il rivo della Pieve fu obbligato a correre lungo il vallo, e servire da fossato, ed a circuire uno degli angoli del campo. Si capisce che mancando quella mano di ferro che comandava alla natura, le acque abbiano ripreso il loro andamento abituale e che il rivo di Genova si sia di nuovo aperto il varco in mezzo della valle scegliendosi un letto a suo piacimento. A Libarna il rivo portò via un angolo della città, a Torino fece lo stesso la Dora (10). A Genova il rivo di Bachernia, molto impetuoso in tempo di grandi pioggie camminò prima in direzione della chiesa della Vigne, come ricorda lo Stella, poi si sistemò nei Macelli e in Soziglia. Ma questo girovagare ci conferma che era stato trattenuto fuori del campo in tempo antico.
Sono tutti fatti che portano in sè stessi una sanzione di veridicità, perchè rispondono ad un sistema organico così logico, così romano, che si sente la difficoltà non a credere che sia esistito, ma a credere il contrario. Sarebbe troppo abile chi sapesse inventare tutto questo.
Ognuno comprende che il campo di Genova aveva un importanza eccezionale, perchè costituì fin da principio, anzi più da principio che in seguito, un punto strategico di prim’ordine. Si trattava di difendere la città da un assalto dei Cartaginesi accampati in riviera di ponente e dai Liguri della montagna sempre indomiti e minacciosi, che potevano essere da un momento all’altro, come furono, gli alleati dei Cartaginesi. Cogli impianti di Piacenza, Tortona, Libarna, Acqui, Pollenzo, i Romani chiusero i Liguri della montagna in una cerchia di ferro dalla parte del Po. Ma questi Liguri potevano piombare su Genova e trucidare i Romani nel campo, come fecero nel 181 quelli d’Albenga (11). Di qui l’idea di un muro a ponente, e di un castello sul monte, per difendersi dai due lati che erano esposti al nemico.
È una cosa soddisfacente il rilevare come nella nostra ipotesi si afferma la continuità della storia. Nel medio evo, in diverse epoche vediamo la dominazione straniera preoccupata di fortificare Castelletto. E vediamo a un certo momento Gian Galeazzo Visconti che vuole condurre un muro da Castelletto al mare (12). Si credevano invenzioni della tirannide nuova, ed invece non erano che un ritorno al sistema romano, che gli ingegneri del Visconti avran rilevato dagli avanzi dei muri antichi. Il merito fu tutto di Spurio Lucrezio e degli abili gromatici dell’ impero.
Il sistema da loro ideato fu certamente grandioso e geniale, e non può a meno di interessare gli studiosi dell’organizzazione romana, come quelli che si occupano della storia dell’arte militare.
Sotto il punto di vista politico è molto utile l’aver compreso quale era in pratica la vera condizione che i Romani fecero ai popoli che con soavità di linguaggio chiamavano «socii et in amicitia populi romani». Se erano città marinare, che si dedicavano alla difesa del mare, fossero pure esenti da tasse e prestazioni, libere di trafficare e di arricchirsi, ma tenute alla fedeltà verso l’impero — e, perchè fosse garantita la fedeltà, un campo trincerato, un castello ed uno sbarramento dal monte al mare — il castello per vigilare sui nemici di Genova, ed intanto sorvegliare la città ed il porto — lo sbarramento per proteggere dagli invasori il campo, ed impedire occorrendo ai Genovesi di ponente di congiungersi con quei di levante. Divide et impera.
È interessante lo studio di un campo romano, perchè essendo governato da norme geometriche, è sempre possibile ricomporlo in tutte le sue parti e segnarlo sul terreno. Se un’ ipotesi è vera essa viene ad essere confermata splendidamente dallo studio dei particolari, se è falsa arriva presto il momento che lo studio dei particolari la distrugge.
Il pretorio, che noi ponemmo in fondo a via Roma, era generalmente un quadrato di 200 piedi di lato. Nei campi stabili «castra stativa» come era quello di Genova, era elegantemente costrutto a modo di tempio. Da G. Cesare in poi i comandanti posero ogni cura nel dare solennità al pretorio. Sappiamo che G. Cesare, ambizioso di queste forme portava dietro a sè dei pavimenti di mosaico, ogni volta che moveva il suo campo (13), e se questo avveniva per i campi mobili è facile argomentare ciò che dovevano essere i pretorii nei campi stabili.
Qualcuno potrà dubitare della importanza che io do al campo di Genova, considerandolo come castra stativa. A questo riguardo giova ricordare che i campi romani erano più o meno stabili, secondo la loro destinazione. Vi erano i campi improvvisati durante le guerre, che si contentavano di precarie difese, ed erano rapidamente fatti con materiale d’accampamento. Vi erano i campi d’inverno, ove le truppe dimoravano durante la cattiva stagione, anche questi provvisori, ma fortificati con maggior cura. Vi erano i campi delle «mutationes» ossia luoghi di fermata lungo le vie militari ove erano stabiliti dei servizii di rifornimento e di posta, ed abbondavano le «tabernae» il cui nome comparisce ad ogni poco negli itinerarii. Vi erano infine le stazioni stabili, dette «castra stativa» solidamente impiantate con edifizii in muratura per il pretorio, per i magazzeni di rifornimento, per le officine.
Si impiantavano queste nei luoghi che avevano un’importanza strategica, nei punti d’incontro di due o più strade, nei luoghi di approdo (14), Genova e Vado erano indubbiamente due castra stativa perchè Genova era capo linea di una gran via che metteva alla Valle del Po, era un punto importante della via littoranea, era un punto di sbarco e di imbarco per le milizie, una posizione strategica di primo ordine avuto riguardo all’epoca in cui fu occupata; aveva insomma tutti i requisiti per esigere l’impianto di un campo stabile. Lo stesso si dica di Vado.
Il pretorio aveva la fronte sulla via principalis. Nel caso nostro la fronte del pretorio si avrebbe prolungando la via S. Sebastiano in direzione del teatro Carlo Felice. Dinanzi al pretorio l’ara dei sacriflzii che si compievano dal duce alla presenza di tutte le milizie allineate sui decumani. L’ara in Genova avrebbe dovuto trovarsi all’ angolo nord-ovest del portico del Carlo Felice, punto d’incontro del decumano colla via principale. A sinistra del pretorio era il «tribunal» dall’alto del quale il duce rendeva giustizia, ed arringava i soldati, raccolti nel «foro». Il tribunale nel campo di Genova doveva corrispondere al pronao marmoreo del teatro Carlo Felice, e doveva essere qualche cosa di simile per maestà architettonica. Il foro corrispondeva all’attuale piazza Deferrari sopraelevata di quattro metri. Quante volte su questa piazza i Genovesi avranno acclamato a Pompeo liberatore dei mari, a Cesare futuro dittatore di Roma! Par di vedere in mezzo alla folla un giovane ardente, rumoroso, pieno di ingegno, che nelle ambizioni di Cesare insegue il proprio avvenire di ricchezza e di gloria; è il genovese Elio Staglieno (15).
A destra del pretorio erano gli uffici amministrativi sotto la direzione del questore. Alle spalle erano le tende dello stato maggiore, che nell’epoca imperiale era rappresentato dalla coorte dei pretoriani.
Dinanzi al pretorio correva la gran via maestra del campo, larga da 15 a 20 metri, che come si è detto doveva coincidere colla linea di S. Sebastiano.
È difficile immaginare il movimento, la vita, l’ordine meraviglioso, la magnificenza di un campo romano ai tempi di G. Cesare e di Augusto; il fasto orientale, il lusso dei pretoriani ai tempi di Diocleziano, di Costantino e di Teodosio ; i ricevimenti imperiali al pretorio, le feste militari sulla bella piazza, che forse come tante altre dell’alta Italia portava in principio il nome di Forum Juli, poi alterato in piazza «friulana». Lo argomento dal nome di «Friulante» che aveva una torre medioevale in quel punto.
I soldati, divisi in centurie, alloggiavano nella parte bassa del campo. Per le porte di Banchi, di piazzetta S. Sepolcro, della Maddalena (il lettore comprende che uso i nomi moderni) uscivano a godere il magnifico spettacolo della marina e la scena sempre interessante del commercio marittimo in azione.
I documenti medioevali ci attestano che nel luogo ove è attualmente via Garibaldi esistettero i postriboli fino al 1500. Anche questa è una delle tante coincidenze che confermano l’esistenza dell’antico campo, perchè i postriboli vicino al vallo erano in ogni campo romano.
Un’ altra coincidenza non meno interessante è quella dei fabbri. Ricorda Vegezio che ogni legione aveva «fabros tignarios, structores, carpentarios, ferrarios, pictores reliquosque artifices ad hibernorum aedificia fabricanda, ad machinas, turres ligneas caeteraque, quibus vel expugnantur adversariorum civitates vel defenduntur propriae, praeparatos, qui arma, vheicula, caeteraque genera tormentorum vel nova facerent, vel quassata repararent. Habebant etiam fabricas scutarias, loricarias, arcuarias, in quibus sagittae missibilia, cassides omniaque armorum genera formabantur. Haec enim erat cura praecipua, ut quidquid exercitui necessarium videbatur nunquam deesset in castris». I fabbri costituivano un corpo sotto la direzione del «praefectus fabrum», corpo che fu riprodotto negli eserciti di tutti i tempi, e nell’epoca moderna ebbe il nome di artiglieria e genio. I fabbri erano ai lati dell’accampamento.
Nel caso di Genova si verificherebbe questa strana coincidenza che quella zona che si estende da Banchi a S. Matteo si chiamava nell’alto medio evo «campus fabrorum». Perchè il nome di campo? Perchè il nome classico e onnicomprensivo di fabbri e non il nome di ferrai, scudai che sarebbe più consono ai modesti raggruppamenti del medio evo? Queste riflessioni fanno sospettare che il nome di «campus fabrorum» risalga al tempo in cui nelle regioni testè indicate tenevano campo i fabbri, ossia i meccanici degli eserciti romani. Quante volte dalle alture di S. Lorenzo i Genovesi avranno visto comporre catapulte ed arieti, e «turres ligneas», fatte per espugnare le città dei nemici! Nessuna meraviglia quindi, che essi educati dai tempi antichi a questa scuola d’arti e mestieri ne avessero conservato i segreti, ed insegnassero nel 1100 ai baroni e conti crociati l’uso delle torri di legno per espugnare Gerusalemme.
I fabbri dovevano essere pure all’altra estremità del campo, vicino al vallo di tramontana, dove troviamo la regione di «Spaeria» nel medio evo, ossia il luogo dove si vendevano e si aggiustavano le spade. I moderni hanno mal riprodotto il significato antico scrivendo «vico Spada); meglio sarebbe stato come a Firenze e in altri luoghi «vico Spadari» o meglio ancora il nome consacrato da documenti medieovali genovesi «Spaeria».
II campo di Genova misurava circa m. 525 X 525. Era un comodo campo per una legione di 8000 uomini.
Per circa sette secoli Genova sentì echeggiare nella valle le voci dei legionari, che arrivavano ora dal mare, ora dai monti, ora dalle Gallie. Ogni tre ore squillavano nella valle le «buccine» per il cambiamento delle scolte. E la città regolava sul campo le sue ore di sonno e di lavoro.
Il campo era generalmente composto di materiali mobili all’infuori del pretorio, quindi è ragionevole che nella valle di Soziglia non si trovino tracce di ediftzii romani. L’unico edilizio importante era il pretorio che rimase probabilmente come rudere nella domoculta, finché anche questa non fu distrutta e sradicata con successivi abbassamenti del suolo. Presto colla demolizione del colle di Piccapietra scompariranno gli ultimi avanzi della configurazione antica. Resterà il muro nei fondi di palazzo bianco, come ultimo testimonio della dominazione romana di XX secoli or sono.
Ancora un quesito. Come si collegava la città col campo? Un luculo, un boschetto divideva certamente il campo dall’oppidum nella parte alta perchè abbiamo accertato che il sepolcreto che era sul colle di S. Andrea conteneva tombe anche dell’epoca costantiniana. Lo stesso si dica per la regione ove è la chiesa di S. Lorenzo, ove per testimonianza del Rocca molte tombe romane vennero fuori negli scavi praticati per la sistemazione della regione di S. Lorenzo. La permanenza di quel sepolcreto ci fa intendere che il culto dei morti così vivo in antico, vivissimo fra i Liguri, prevalse ad ogni altra considerazione, ed i Romani, usi a non urtare i sentimenti intimi delle popolazioni, riuunziarono ad estendersi su quella zona. Si contentarono di allacciare il campo all’oppidum fabbricando lungo Canneto il curto.
Il luculo da S. Lorenzo a S. Andrea, mentre serviva al riposo dei morti, sarà pure servito a quei conciliaboli notturni, in cui gli emissari di G. Cesare e gli Elio Staglieno e gli altri politicanti di quel tempo «coniurabant» come dice Svetonio, onde preparare il trionfo del partito democratico in Roma.
Il vallo del campo proseguiva probabilmente sulle alture del colle di S. Andrea e di Raveca in modo da formare una sola linea di difesa comprensiva della città e dell’ oppidum. Ed il campo e l’oppidum formavano probabilmente una specie di quadrilatero, nel modo che ho descritto nella mia pianta di Genova antica.
Il colle di Carignano, e la vallata sottostante colla spianata del Bisagno non sarebbero comprese nell’ impianto organico di Genova romana. È però logico il ritenere che specialmente la spianata avesse la sua speciale destinazione come campo di Marte, accessorio indispensabile di ogni città romana, ove era una stazione militare. Come Roma ricorda il suo campo Marzio, così Marsiglia addita ancora il suo campo di Marte. A Genova si chiamava «pròu» perchè era il nome tradizionale che si dava in Liguria ai grandi piazzali destinati a svago dei cittadini e a pubblici comizi.
Sul pròu di Genova i legionari si saranno esercitati nelle «manovre decursiones» e nel tiro a segno, e nell’equitazione e nel montare e smontare macchine da guerra, e in momenti d’ozio al gioco della palla «pila» che fu il gioco favorito dei legionarii e di tutti i grandi uomini, da Catone a Cesare ad Augusto, all’ imperatore Settimio Severo.
Sul «pròu» si affratellavano coi legionari i figli del popolo Genovese, e probabilmente a tale scuola si addestrarono alle armi ed acquistarono quella fama di insuperabili «balestrieri» che li rese famosi nel medio evo.
Sono induzioni è vero, ma logiche e direi quasi necessarie, perchè senza di esse non si spiega la superiorità militare con cui i Genovesi si affermano nei primi movimenti del medio evo. Chi fa astrazione dalla romanità non vedrà mai chiaro nella storia di Genova.
Note. (1) Liv. XXI 1. (2) G. Poggi, Le due Riviere nell’epoca romana. (3) Si parlerà meglio di questa stazione al cap. VI (GENOVA IN EPOCA ROMANA). (4) Passando per la via più breve, quella di S. Francesco d’Albaro, che pare sia stata costrutta nell’ epoca romana come scorciatoia, alla via principale « l’Aurelia » che passava per S. Martino. (5) Per cura del municipio di Genova 1886. (6) Atti della Società Ligure di Storia Patria – vol. III. (7) G. Poggi, Luni. (8) Mommsen, Staatsrecht; Nissen, Das templum; Marqvardt, Organisation militaire chez les Romains; e gli studi di Duchovl, Rettig, Roy, Planer Masqveles in Dictionnaire des antiquités Daremberg e Saglio. (9) Belgrano, Porta Soprana. (10) Vedi pianta di Torino Romana di Alfredo D’Andrade. (11) Liv. – XL. 25.
(12) Giustiniani, Annali 1476. (13) Svetonio, Caesar. 46. (14) Caesar, De bello civili, III. 37; De bello Afric., 26; Sallustio, Giugurta, 44; Tacito, Ann., III. 21; Livio, – I. 59 XXIX. 34. (15) Vedi sopra Elio Staglieno lo studio dello Spotorno. Storia letteraria della Liguria Vol. I.
* * *
117 a. C.
L’ARBITRATO DI ROMA FRA GENOVESI E VETURII
Poggi G., Genova preromana, romana e medievale, in Genova, Giovanni Ricci editore, Libreria Moderna, Galleria Mazzini, 1914
SOMMARIO: La tavola di bronzo del 117 a. C. — Dalla tavola emerge la condizione giuridica dei Genovesi — Il sistema di proprietà — Le liti per i compascui — Popoli e tribù intorno a Genova — Le opinioni del Rudorff e del Mommsen — La tavola è una fotografìa della Polcevera di XX secoli fa — La tavola di bronzo e le teorie glottologiche finora in voga.
Nell’agosto dell’anno 117 a. C. i fratelli Minucii Quinto e Marco della famiglia dei Rufi, delegati dal Senato di Roma, vennero in Genova per giudicare come arbitri delle contese che esistevano per ragioni di territorio fra i Genovesi e i Veturii, che abitavano l’alta Polce- vera ed avevano il loro castello a Langasco. La sentenza da loro pronunziata fu trascritta all’uso romano in tavola di bronzo e depositata nel tabularium al Campidoglio, e copia di essa fu data alle parti. Così alla distanza di 16 secoli potè essere rinvenuta in Polcevera e diventare il più importante documento della nostra storia antica.
Nel mio lavoro «Genoati e Veturi» pubblicato nel 1900 negli Atti della Società Ligure di Storia patria, ho cercato di darne un’ampia illustrazione storica e topografica. Mi limito quindi a trascrivere la mia traduzione dell’ importante documento, per aprirmi la via a discutere della condizione giuridica dei Genovesi nell’epoca romana.
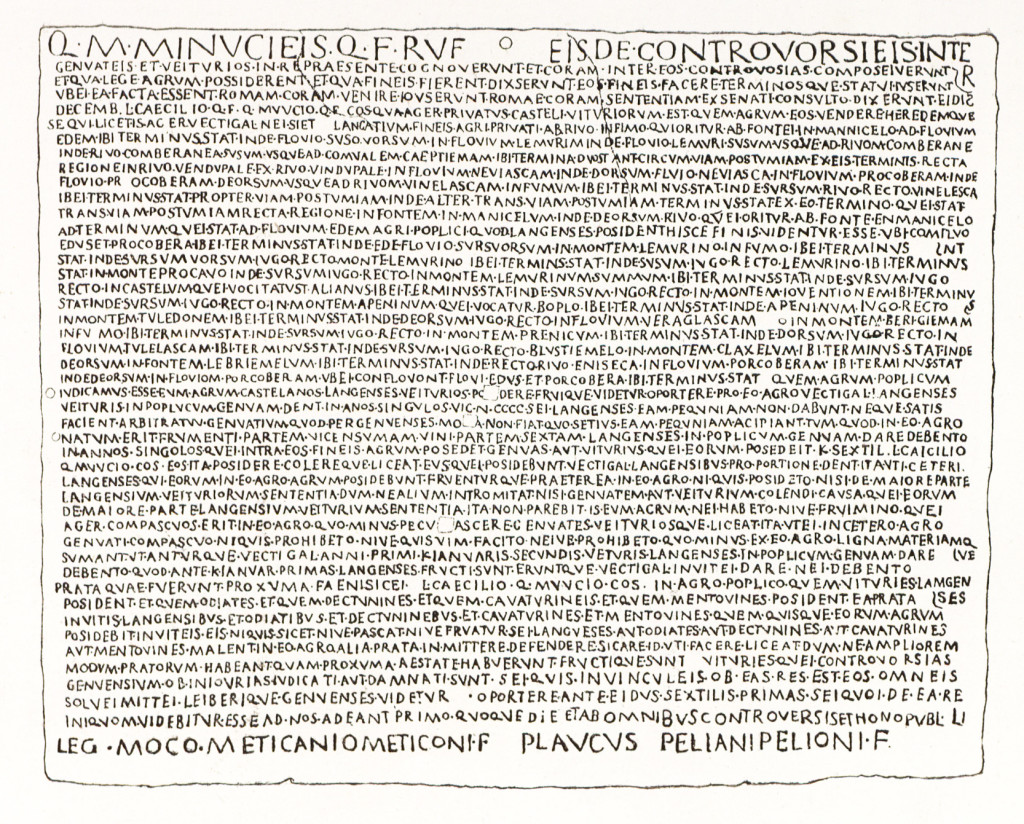 Traduzione. a) Preliminari. — 6) Formalità della sentenza. — e) L’agro privato degli uomini di Langasco. — d) Confini dell’agro privato. — e) Confini dell’agro pubblico. — f) Condizioni giuridiche dell’agro pubblico: è soggetto a canone verso i Genuati. — g) I possessi privati nell’agro pubblico. — h) Norme per il godimento dell’agro pubblico. — i) Decorrenza del canone — j) Regolamento dei prati dei diversi popoli. — k) Liberazione dei prigionieri; per le questioni relative si rinvia la causa — l) Sottoscrizione dei delegati delle due parti.
Traduzione. a) Preliminari. — 6) Formalità della sentenza. — e) L’agro privato degli uomini di Langasco. — d) Confini dell’agro privato. — e) Confini dell’agro pubblico. — f) Condizioni giuridiche dell’agro pubblico: è soggetto a canone verso i Genuati. — g) I possessi privati nell’agro pubblico. — h) Norme per il godimento dell’agro pubblico. — i) Decorrenza del canone — j) Regolamento dei prati dei diversi popoli. — k) Liberazione dei prigionieri; per le questioni relative si rinvia la causa — l) Sottoscrizione dei delegati delle due parti.
a) Quinto e Marco Minucii, figli di Quinto, della famiglia dei Rufi, esaminarono le quistioni fra Genuati e Veturii in questa causa, e di presenza fra loro le composero. Stabilirono le norme dei relativi possessi, ed il modo di fissarne i confini. Fecero segnare questi confini e porre i termini.
b) Esauriti questi incombenti, ordinarono di comparire a Roma, ed in Roma, presenti le parti, pronunziarono sentenza, a ciò autorizzati dal decreto del Senato, nelle Idi di Dicembre (il dì 13), sotto il Consolato di Lucio Cecilio, figlio di Quinto, e di Quinto Muzio, figlio di Quinto (anno 637 di Roma 117 a. l’E. V.) colla qual sentenza fu giudicato:
c) Vi è un agro privato spettante al Castello (Langasco) dei Viturii, che essi possono vendere e trasmettere agli eredi. Questo agro non sarà soggetto a canone.
d) I confini dell’agro privato di quei di Langasco sono i seguenti: Dove finisce il rivo che nasce dalla fontana in Manicelo (Marsen abbreviazione di «Ma-en-i-cen». Per effetto di un avvallamento la fontana scaturisce ora un po’ più in basso nel ripiano detto «a-en-i-cen» ove è la palazzina Razeto) e dove lo stesso s’incontra coll’Ede (Verde), ivi sta un termine. — Quindi si va in su per il fiume fino ad incontrare il fiume Lemori (Lemoin, ora Rio d’Iso). — Quindi su per il fiume Lemori fino al rivo di Cumberanea (Creasi). — Quindi su per il rivo di Cumberanea fino alla convalie Ceptiema (ora convalle di Pietra Lavezzara); ivi sono due termini presso la via Postumia. — Prolungando la linea retta risultante da questi due termini, si va al rivo Vendupale (Pa-vei). — Dal rivo Vendupale nel fiume Neviasca (Gostagua). — Poi giù pel fiume Neviasca fino all’incontro del Procobera (Ricò). — Quindi giù per il Procobera fino al punto ove finisce il rivo Vinelasca (Rio de vigne ora detto «dai Langen») ivi è un termine presso la via Postumia, e un altro al di là della via. — Dal termine che sta al di là della via Postumia, si va in linea retta alla fontana in Manicelo. — Quindi giù per il rivo che nasce dalla fontana in Manicelo sino al termine che sta presso al fiume Ede (Verde).
e) Quanto all’agro pubblico posseduto da quei di Langasco, si ritiene che i suoi confini siano questi: Dove constituiscono l’Ede e la Procobera (il Verde e la Polcevera) sta un termine (I). — Quindi si va su per il fiume Ede fino al pie’ del monte Lemorino (Lemoin); ivi sta un termine (II). — Quindi si va su pel giogo Lemorino, e s’incontra un termine (III). — Poi su per il giogo Lemorino, e si trova un altro termine nel monte Procavo (Ta-cun) (IV). — Quindi su per il giogo si va al sommo del monte Lemorino (Leco): ivi sta un termine (V). — Quindi proseguendo per il giogo si va al Castello che chiamano Aliano (A-lià ora Monte Peuzu); ivi sta un termine (VI). — Quindi camminando pel giogo sul monte Giovenzio (Zuvu) ivi è un termine (VII). — Quindi seguendo il giogo nel monte Apenino, che si chiama Boplo (Ora Capellin); ivi sta un termine (VIII).— Dall’Apenino seguendo il giogo al monte Tuledone (Carmo): ivi è un termine (IX). — Poi giù per costa nel fiume Veraglasca (che sbocca sotto Voié); in fondo al monte Berigiema sta un termine (X). — Quindi per costa si va su al monte Prenico (Pernecco); ivi sta un termine (XI). — Quindi per costa si scende nel fiume Tu-te-l-asca (Seca) (si noti la frase genovese « te l’asca » nell’asca) ivi sta un termine (nel luogo detto Isola) (XII). — Quindi su per la costa di Blustimelo (Costa di Pedemonte) fino al monte Claxelo (oggi Groxevia); ivi sta un termine (XIII). — Quindi si discende al fonte Lebrimelo (oggi Fontana d’asi); ivi sta un termine (XIV). — Quindi giù pel rivo d’Eniseca (En-i-seca) nel fiume Procobera (oggi Rico); ivi sta un termine (XV). — Quindi giù per il fiume Procobera (Ricò). Dove confluiscono l’Ede e la Procobera (Verde e Polcevera) ivi sta il termine (già menzionato al n. I).
f) Di questo agro, che giudichiamo esser pubblico, i Viturii del Castel di Langasco si ritiene che debbano avere il possesso e il godimento. Per questo agro i Veturii Langen daranno 400 vittoriati all’anno all’erario di Genua. Se i Langen non pagheranno questa somma e nemmeno soddisferanno i Genuati in altro modo gradito a questi, beninteso che i Genuati non siano causa del ritardo a riscuotere, saran tenuti i Langen a dare ogni anno all’erario di Genua la ventesima parte del frumento nato in quell’agro e la sesta parte del vino.
g) Chiunque Genuate o Veturio, possiede dell’agro entro quei confini, sia mantenuto nel possesso e nel godimento, purché il suo possesso dati almeno dalle kalende del mese Sestile (Agosto) del Consolato di L. Cecilio Metello, e di Quin-Muzio (637); coloro che godranno di tale possesso pagheranno ai Langen un canone proporzionale come tutti gli altri Langen, che in quell’agro avranno possessi o godimenti. Fuori di questo caso nessuno potrà possedere in quell’agro senza l’approvazione della maggioranza dei Veturii Langen, ed a condizione di non introdurvi altri che Genuati o Veturii come coloni. — E quello di essi che non obbedisse alla maggioranza dei Veturii Langen non potrà continuare ad avere nè godere di tal agro.
h) Quanto all’agro che sarà compascuo, sarà lecito ai Genuati e Veturii pascervi il gregge come nel rimanente agro genuate destinato a pascolo pubblico; nessuno lo impedisca, nessuno ricorra a vie di fatto; così pure non s’impedisca di prendere da quell’agro legna e materiali.
i) La prima annata di canone i Viturii Langen dovran pagarla alle kalende di Gennaio del secondo anno (639), e di ciò che godettero o godranno prima delle prossime kalende di Gennaio (638) non saran tenuti a pagare canone alcuno.
j) Quanto ai prati, che durante il Consolato di L. Cecilio e Q. Mucio (l’anno in corso 637) erano maturi al taglio del fieno (si parla dei prati), siti nell’agro pubblico, sia in quello posseduto dai Viturii Langen, sia in quello posseduto dagli Odiati e dai Dectunini e dai Cavaturini e dai Mentovini, nessuno vi potrà segare, nè condurre bestie a pascolo, nè sfruttarli in altro modo senza il consenso dei Langen, degli Odiati, dei Dectunini, dei Cavaturini e dei Mentovini per quel tratto che ciascun di essi possederà. Se i Langen, o gli Odiati, o i Dectunini, o i Cavaturini, o i Mentovini vorranno in quell’agro stabilire nuovi prati, chiuderli, segarvi il fieno, ciò potranno fare a condizione che non abbiano maggiore estensione di praterie di quel che ebbero e godettero nell’ultima estate.
h) Quanto ai Viturii, che nelle questioni coi Genovesi furono processati e condannati per ingiurie, se qualcuno è ancora in carcere per tal motivo, si ritiene dovere i Genovesi proscioglierli e rimandarli in libertà. Prima delle prossime Idi del mese Sestile (Agosto 638), se al riguardo di tal faccenda sembrasse esservi qualche cosa di ingiusto, compariscano innanzi a noi in qualunque giorno, che non sia destinato nè alle cause nè a pubblici uffici.
l) I delegati – Moco Meticanio figlio di Meticone – e Plauco figlio di Pelion di Pelio.
Questo prezioso documento versa una gran luce sulla personalità storica di Genova romana. Risulta che i Genovesi godevano del diritto di avere tribunali proprii e riscuotevano canoni e decime sul loro territorio, e così resta stabilito che non erano sudditi di Roma ma «confederati».
Risulta pure dalla tavola quale era il sistema di proprietà in uso presso i Liguri di quel tempo. Il territorio era in origine comune a tutti i componenti la comunità «ager poblicus». Con graduali assegnazioni si era venuto a costituire a poco a poco la proprietà individuale, frutto del lavoro che facevano i singoli, riducendo a coltura P appezzamento a ciascuno di essi assegnato. La proprietà individuale che si chiamava « ager privatus » era quella che si poteva « vendere e trasmettere agli eredi ».
Ma la parte alta dei monti rimase sempre d’uso comune e perciò si dissero da noi comunaglie (2) certe zone montuose. La proprietà era della tribù, che nell’ epoca romana formava il pago. Probabilmente fin d’allora la tribù si chiamava «pieve» (3). Gli uomini della tribù erano i padroni delle comunagie «uti universi» e ne disponevano deliberando a maggioranza di voti «de maiore parte sententia».
I Vituri, che pare avessero il loro centro a «Vótri» tenevano pure l’Alta Polcevera ed avevano un castello a Langasco. Io ritengo che avessero l’alta Polcevera per concessione enfiteutica, ma che il territorio spettasse in origine ai Genovesi, e che la controversia sia nata perchè i Langaschi si allargavano eccessivamente e facevano il possibile per non pagare il canone ossia la decima ai Genovesi.
Le comunaglie, che i Romani chiamavano «compascua» avevano di caratteristico la «reciprocità», in quanto che quelli di un versante avevano diritto di pascolare anche sul versante opposto e viceversa. Da questa reciprocità nascevano molte questioni, che strano a dirsi, si perpetuarono fino ai nostri giorni negli stessi termini con cui si presentavano XX secoli fa. Quei del versante meglio esposto avevano la tendenza a restringere il compascuo per farvi dei prati e segarvi del fieno, che aveva molto valore nel tempo in cui i nostri monti erano attraversati dagli eserciti, come nel tempo posteriore in cui il fieno era ricercato dalle carovane. Naturalmente se ne lagnavano quelli del versante opposto, che vedevano sottratto al godimento promiscuo la parte migliore. La sentenza decide su queste lagnanze (lettera j) collo stabilire che quanto ai prati restino quelli che son fatti, ma per l’avvenire non se ne facciano dei nuovi, o se si fanno, si abbandoni al compascuo altrettanto terreno dei prati vecchi (4).
Xel conflitto per il godimento del compascuo la tavola di bronzo chiama in scena i « Langenses » ossia quei di Lan- gasco, gli «Odiates» che ritengo quelli di Odè (Orerò;, i «Dec- tunini » (I) che sono i Tortonesi, i « Cavaturini », che sono quei di Gavi, to ri, cioè nel Leme, i Mentovini, che io ritengo quelli dell’altipiano di Marcarolo.
————————
(I) È interessante il confronto di queste due forme linguistiche: «de-ctun » dice la tavola di bronzo, « der thon » dice Strabene. La tavola era scritta secondo la pronunzia genovese, Strabone invece riferiva la pronunzia che aveva sentito nella valle del Po, ove domina l’articolo er, der. A Pozzuolo per dire che uno è di Tortona, si dice che è der ton, facendo comprendere che «der» è un articolo al genitivo. Il nome si declina così: er ton, der ton, ar ton, o il dialetto conserva le traccie di questa declinazione. Nella pronunzia genovese, come nella pronunzia francese predomina invece la forma o, du, au, O-ton A-o-tun, An-ton, D’-an-ton. Ton è il Xton greco, il gton sassone, (Well-in-gton, Was-in- gton) che diventa ton, don, zon in Italia Cor-ton-a, Grun don-a, Va en-zon a corrispondente a Was in-gton, Bel-in-zon a corrispondente e Well in-gton, e diventa tun e dun e zon in Francia (Au-tun, corrispondente a o ton ligure, D-eu-ton, Du-r-an-ton, Al zon, L-an-don e simili che Giulio Cesare tradusse in dunum.
I glottologici hanno inutilmente cercato di spiegare come il Dertona e Dectuna abbia potuto produrre il Terdona medioevale, e il Tortona moderno. La spiegazione si trova soltanto quando si pensa che in linguaggio tortonese ter vuol dire nel e don è la stessa parola di ton. Terdon vuol diro «nel paese» come Der ton vuol dire «del paese». Il prefisso «Tur» accenna alla città che si è venuta formando nel piano intorno al ton primitivo che era sul colle; è la città che vediamo attualmente. I Greci l’avrebbero chiamata la nea-poli, in altri luoghi si sarebbe detto «breo» in altri luoghi «borgo» come era infatti la Tortona attuale nel medio ovo. Intanto ci apparisce per la centesima volta il famoso binomio, che è uno dei fenomeni più caratteristici delle antiche città italiche, la città antica in alto, la città nuova in basso.
————————
La tavola nomina queste popolazioni in quanto erano interessate nella controversia relativa ai gioghi genovesi, ma non si occupa di stabilire quale fosse la loro entità politica. Alcune delle genti ricordate sono popoli, altre sono semplici tribù. I Dectunini erano un gran popolo alle spalle dei Genovesi, e di esso faceva parte la tribù dei Cavaturini. Erano probabilmente una tribù dei Genovesi gli Odiates, ed una tribù dei Veturii i Mentovini.
Studiando i confini delle diocesi e dei comitati medioevali si conferma ciò che la tavola di bronzo già mette in chiaro, che uno dei confini dei popoli era generalmente il giogo. Ed è per questo che su tutti i gioghi della Liguria si ripetevano da secoli e secoli le stesse identiche questioni di compascuo e di confine.
Errò a mio avviso il Mommsen quando ritenne che i Dectunini e i Veturi fossero popoli «adtributi» dei Genovesi. Quanto ai Tortonesi, tutta la loro storia medioevale vi si oppone. Il comitatus e la diocesi arrivavano fino al giogo e furono sempre in aperta rivalità con Genova. Se i Genovesi riuscirono poi a penetrare coi loro possessi oltre giogo, ciò avvenne per effetto delle donazioni con cui la chiesa subentrò in molte demanialità transappenniniche (5) e per effetto degli acquisti che i ricchi mercanti genovesi fecero dai Marchesi nelle regioni d’oltre giogo. La questione è solo possibile per i Veturii. Ma gli argomenti addotti dal Mommsen e prima di lui dal Rudorff non mi sembrano convincenti, come ho dimostrato nei miei Genoati a. p. 252-15.
La tavola è una fotografia della Polcevera di XX secoli fa, ne riproduce al vivo la splendida coltura, e ci fa vedere come fosse disputato palmo a palmo il terreno. Produceva vino e grano e fieno. La splendida frutta non figura nelle considerazioni della sentenza, ma era certo fin d’allora uno dei cespiti più importanti, come abbiamo già dimostrato.
Metà dei nomi che si trovano in Polcevera attualmente figurano nella tavola di bronzo, ciò che vuol dire che essi esistevano nel 117 a. C. E con ciò resta smentita l’affermazione che tutte le forme linguistiche primitive sieno state sostituite dal latino. Eravamo nel 117, ai primi contatti con Roma e non è possibile il supporre che i Romani, appena fatta la conoscenza dei Genovesi, abbiano estirpato in un giorno il loro dialetto e sostituito nomi nuovi.
Fra le voci di XX secoli fa troviamo il famoso «En i seca», che diventò il punto di partenza dei miei studi glottologici: 1) perchè rivelò l’esistenza di un articolo preromano che ormai abbiamo accertato in mille modi; 2) perchè rivelò una forma greca che poi trovò riscontro in tutto il nostro linguaggio antico; 3) perchè ci fece conoscere che i nomi di toponomastica ligure sono frasi, che una volta decomposte, offrono le forme elementari del dialetto ligure antico. Quando saranno conosciuti i prefissi e suffissi che funzionano in queste composizioni, diventerà a poco a poco meno ostica la verità che vado affermando, a scapito di quella simpatia che forse non sarebbe mancata ai miei studi se avessi rinunciato alle ricerche sul linguaggio. Queste mi procurarono l’anatema di tutti coloro che vorrebbero far della scienza un santo uffìzio. Ma è troppo ferma la mia convinzione e so che è già passata in molti, perchè io rinunci ad un indirizzo di studi che deve dischiudere nuovi orizzonti alla scienza come alla storia.
Note. (1) Mommsen, C. I. L. Genua. (2) In dialetto comuniage e per abbreviazioni «niage». (3) La pieve si chiamava nei dialetti italici ora pieve, ora pieive, ora pive, seive e ceive. Si fa presto a dire che sono tutte corruzioni del latino plebs, plebis. Io ritengo invece che il plebs sia una parola formata sull’antichissimo volgare «pieve» e che nessuna corruzione vi sia nelle altre forme. È quistione di aver presente la mobilità del dialetto antico, perchè non erano ancora venuti i grammatici a mettergli i chiavistelli. La parola accenna ai volghi che abitavano sulle vie – va, be, bi – (via, bea, bia). Per dire «per le vie» altri diceva pei vè, altri p-i-vè, altri per motatesi pie-vè. Altri si esprimeva dicendo «sulle vie, presso le vie» ed allora veniva in campo il prefisso sce (chez) e questo finiva per dare « se-i-vè, e oe-i-vè ». (4) Nel medio evo questi patti non furono più rispettati. Le liti fra quei di Polcevera o quei d’oltre giogo risorsero, o durarono fino al 1904, anno in cui ebbi il piacere di veder definita con una transazione la lite fra Mignanego e Fiaccone, che io patrocinavo per Fiaccone, invocando le norme della tavola di bronzo. Chi si lagna delle lungaggini delle liti si conforti pensando che la lite fra Mignanego e Fiaccone, cominciata nel 117 a. C., era ancora nel 1904 dinanzi la Corte d’Appello di Casale (vedi i miei «Compascui»). (5) Il Tortonese passò ai Romani probabilmente per effetto di conquista; quindi il suo ager publicus divenne demanio imperiale; una gran parte entrò nella circoscrizione della città romana di Liburna, e formò poi oggetto dello famose donazioni delle Alpi Cozie.
* * *
II – I secolo a.C.
GENOVA NELLA ROMA REPUBBLICANA
Barbieri Piero, Forma Genuae, Edizioni del Municipio di Genova, 1938.
GENOVA ROMANA
Alla rovina operata dai Cartaginesi segue subito l’intervento dei Romani nella ricostruzione della città, caratterizzato dalla permanenza planimetrica dei tracciati reticolari attorno alle vie San Bernardo, Canneto il Lungo, e sulla penisola del Molo, oltre che da alcune opere che rientrano perfettamente nell’ambito della loro tecnica di organizzazione delle città: l’acquedotto – la fognatura, di cui è ricordo nella Chiavica – la via romana, di allacciamento colla capitale e colle regioni a occidente e verso l’entroterra.
La scompartizione al Molo con vie parallele a due direzioni pressochè ortogonali fra loro è una testimonianza importante a fissare la posizione esatta del porto: vuol dire cioè che i Romani spianano le estreme pendici di Sarzano sul mare, portando gli scali al Mandraccio e iniziando il perfezionamento della scogliera antistante con quell’opera del Molo che i consoli del Comune riprenderanno più attiva che mai affidandola ad un’apposita istituzione qui stesso risiedente, i salvatores portus et moduli.
Per conto suo la Clavica, che correva da San Donato al mare, dà altre importanti indicazioni col formare il primo tronco di quella strada lungo la quale i Giustiniani erigeranno edifici a loro dimora, e che diventerà luogo di passeggio e di ritrovo della nobiltà fino a che sarà aperta la Strada Nuova a mezzo del secolo XVI: di essa ci da notizia il lodo dei consoli del Novembre 1133, col quale si ordinava che la strada restasse libera da ogni ingombro a partire dal Macello sino alla strada che per piazza Lunga metteva sotto a San Donato (Liber Jurium, T. I, c. 45). La via Giustiniani è la più larga fra tutte quelle che dall’epoca romana hanno sopravvissuto a tutt’oggi; e sul suo prolungamento, in capo alla salita del Prione, sta la Porta di Sant’Andrea, detta Superana in un atto del 999 (Emanuele Celesia, cit.), da cui si partiva la via romana orientale. Altra porta, forse la sottana, doveva aprirsi all’estremo opposto, presso San Giorgio; ad ogni modo qui si innesta, in direzione perpendicolare, la via di Canneto il Curto che si prolunga nella via romana occidentale, accentuando nella piazza di San Giorgio questo punto singolare per il sistema circolatorio.
Sembra possibile perciò concludere coll’attribuire alla via Giustinianî il carattere del decumanus, e allo spiazzo da San Giorgio quello di mercato. Non è raro infatti il caso che le piazze pubbliche, non potendosi costituire al centro dell’abitato, si siano impiantate in una posizione eccentrica, davanti le porte; anzi una tale disposizione secondo il Lavedan, rappresenta una delle grandi leggi dell’urbanistica che per Genova antica trova riscontro in più di un esempio, nella piazza davanti a San Giorgio, nella piazza Banchi. Quest’ultima, in linea con Canneto il Curto all’estremo limite del quartiere romano, sembra anch’essa aver consentito a una funzione pubblica, di foro o altro; se è possibile immaginare una distinzione fra il comando del porto – l’Ammiragliato davanti al Mandraccio -, e quello civile e militare – il pretorio -, la piazza Banchi potrebbe averne contenuto la sede: in luogo vicinissimo Guglielmo Boccanegra immaginava verso il 1260 di costruirvi il Palazzo a residenza dei Capitani del Popolo.
I sepolcreti arcaici sul colle che risale da Serravalle al Brolio e a Piccapietra delimitano chiaramente i confini della città romana verso Luculi, mentre più in basso attorno a Soziglia e verso occidente si stendeva l’agro onde i nomi di «Campetto», «Vigne», «Campo», e «Prè», conservato per la natura e il tipo di coltivazione in quei luoghi.
Solo lungo la riva del porto, in prossimità delle foci dei rivi maggiori, offrendovisi comodità per l’approdo e l’attività dei cantieri, si sarà formato qualche aggruppamento, specie nei nodi dove convergono le piste antiche che risalgono i colli. Questi punti, che hanno anche importanza strategica, sono scritti con tutta evidenza nel tracciato della via Romana attraverso il percorso da Banchi a San Tomaso, condotto, comé si è visto, artificialmente, e pertanto discostandosi in modo sensibile da quello naturale medioevale che gli è seguito nella successiva espansione dell’abitato sulla spiaggia sottostante.
La città a oriente, verso il mare, terminava alle Mura delle Grazie; lo testimonia il fatto che tutta l’area sotto le Mura e la piazza Sarzano era sgombera di case ancora al XVI secolo, dimostrandosi così che la città da questa parte non ha avuto possibilità di risorse efficaci e che il piccolo borgo alla foce e lungo il corso del Rivo Torbido ha stentato parecchio ad assumere una qualche importanza rispetto al complesso politico-economico della città.
L’ubicazione delle uscite dal castelliere di Sarzano verso il Mandraccio e il mercato a San Giorgio, la linea di vetta dei colli volti al mare, e la depressione formante il vallo dalla parte della Chiavica permettono di delineare con facilità il percorso della cinta consolidata dai Romani attorno alla Genua ligure. Questa cinta antichissima iniziava da piazza Cavour vicino ai SS. Nazaro e Gelso del Palazzolo, correva a dove poi la chiesa dei SS. Cosma e Damiano, e di qui alla piazza San Giorgio che nel medioevo faceva tutt’uno con quella de’ Fornetti oggi scomparsa. Quindi girava alle falde di Mascherona presso la via Giustiniani, faceva un angolo a San Donato, risaliva il Prione fino al Poggio o Piano di Sant’ Andrea, seguiva la cresta del Colle – la Coeûlua – correva per la Montagnola a Sarzano, e man mano declinando sul mare andava a congiungersi al punto di partenza, fiancheggiando il clivo di S. Croce che rimaneva compreso fra le mura e la sottoposta scogliera battuta dal mare.
Le nostre cognizioni archeologiche non ci consentono finora di precisare meglio l’andamento esatto di questa cinta ligure-romana dai piedi dell’antico Castello alla Porta Soprana. Quel muro che sostiene la piazza di Sarzano per quanto affiora fuori terra si dimostra di opera medioevale, appartenente cioè alla cinta del Barbarossa che vedremo erigere fra il 1155 ed il 1159 – d’altra parte un lodo dei Consoli del Gennaio 1141 non solo nomina il murus civitatis ma nel concedere a certo prete Ansaldo quattordici tavole di terreno per costruirvi la primitiva chiesa di San Salvatore pone a condizioni che lo stesso debba lasciar liberi desuper, e dalla parte di esso muro, otto piedi di terreno onde al disotto resti salva la via che vi transitava (M.H.P. – Cartarum, T. II. c. 238) : venendo così a dire che il murus civitatis stava superiormente a (love ora è la chiesa di S. Salvatore.
All’esterno delle mura vi è una via e la chiesa al di là di essa – la terra o piazza di Sarzano si dimostra fin da allora all’interno della cinta, e per questa sua particolare posizione si distingue chiaramente da quelle destinate a mercato che eran tutte fuori delle rispettive porte: il mercato di Ponticello sta fuori la Porta Soprana, quello di San Giorgio fuori la porta di San Torpete, e lo spiazzo a Banchi cioè il foro, il luogo di convegno dei mercanti e dei marinai, sta a sua volta fuori la porta di San Pietro. Si ha ragione dunque di immaginare per la piazza di Sarzano funzioni differenti, confermando la tradizione che assegna a questo suolo pubblico il carattere di una piazza politico-cittadina. Essa è luogo di parlamento, di adunata nelle solennità religiose, di ritrovo, di passeggiata; e il decreto dei Consoli del febbraio 1145 ne salvaguarda la conservazione stabilendo che il «»vacuo di Sarzano resti libero ed a disposizione del popolo il quale nelle grandi solennità vadit ibi et exit»(Liber Jurium, T. I. c. 101)•
Qualche anno appresso la cinta del Barbarossa sposta la recinzione della città a mare della chiesa di San Salvatore, ingrandendo da questa parte la piazza che però viene in parte invasa da abitazioni sul lato opposto verso S. Agostino – il nuovo muro separerà così la piazza di Sarzano propriamente detta dall’inferiore Campus Sarzanni, poi chiamato Campo Pisano, ma anche a questo verrà estesa la protezione governativa; l’altro decreto del 20 Gennaio 1258 statuirà che lo spazio di terreno in Sarzano fuori le mura della città sino all’acqua del Rivo Torbido sia tutto di pertinenza pubblica e rimanga costantemente libero a vantaggio e diletto del popolo (Liber Jurium, T. I. c. 1257).
La piazza pubblica viene così a trovarsi all’estremo, levante della città, cioè dalla parte diametralmente opposta a quella del porto, dove invece è la sede del lavoro – ma questi è legato inevitabilmente a necessità contingenti, la possibilità di ricovero delle navi, la facilità dell’approdo e dello sbarco – l’altra ricerca la posizione più elevata e panoramica che è tradizione ben nota delle genti antiche, greche e italiche.
REGISTRO DELLA GENOVA ROMANA
202 a.C. – Genova viene ricostruita dalle legioni romane comandate dal Senatore Spurio Lucrezio: a questi vengono all’uopo prorogati i poteri ut Genuam oppidum a Magone Poeno dirutum exaedificaret. (Livio XXI. I.; Plinio III. 72).
18 a.C. – E’ costruito il Palazzo di Agrippa il grande ammiraglio di Roma, in faccia al Molo. Un avanzo ci ha conservato l’iscrizione Agrippa Tribunicia potest. [ima]
Questo palazzo andò probabilrnente in rovina all’epoca dei Saraceni e viene ricordato dal Federici nel suo dizionario storico: «in Coltelleria sopra la Riva si vede una facciata, o sia una parte di facciata con un finestrone grandissimo oltre l’ordinario rilevato in pietra, e detta facciata è sostenuta da tre colonne di marmo di eccellente lavoro con capitelli bellissimi a fogliami, e questa era la casa di Liutprando re dei Longobardi, come si legge in cartine appo di me, il che si conosce dalli confini enunciati in dette cartine». (Federici, Dizionario, p. 114 tergo, Bibl. Università) Tav. 5 n. 11
Non si hanno date di altri edifici o monumenti dell’epoca greco-romana. Si hanno tuttavia alcuni avanzi dei quali una parte appartengono a monumenti esistiti sul luogo del ritrovamento; altri sono stati rimossi e non se ne conosce la provenienza; di altri ci è poi solo pervenuta la memoria. Sono ancora da aggiungere le indicazioni e le ipotesi formulate dai vari autori senza fondamenta scientifico.
In corrispondenza si rendono utili quattro classazioni:
a) Monumenti storici :
Una necropoli scoperta negli scavi di San Lorenzo produsse resti di sarcofagi ellenistici e romani che sono murati nel fianco sinistro della chiesa stessa, prospiciente la Piazza di San Giovanni il Vecchio. Tav. 5 n. 31
Nel 1843 durante il lavoro di abbassamento allora fatto della antica strada dei Toscani, vennero alla luce molte monete imperiali e consolari, e soprattutto numerosissime urne cinerarie in terracotta. La suppellettile andò dispersa ma valse a dimostrare che ivi era un antico sepolcreto romano. Altre ossa, urne, vasi lacrimatori, strigili e ciste grafite, vennero alla luce allorchè nel 1871 si abbassò il suolo della strada dello Arcivescovado nel tratto che dalla sacristia del Duomo andava alla piazza dei Funghi. Gli sterramenti fatti alcuni anni appresso nel Chiostro di San Lorenzo, accertarono che anche qui vi era un’ustrina [area sacra, predisposta nei pressi di una o più tombe, in cui venivano realizzate le pire per la cremazione dei cadaveri]». Tav. 5 n. 6
La Via Giustiniani prima del ‘600 era chiamata l’antica Via della Ciavega ossia della Chiavica che era ritenuta una ammirata costruzione romana, limitatamente però nel tratto da San Giorgio al mare. Un documento del Liber Jurium ci attesta che nel 1137 il rivo lungo la Via Giustiniani era ancora scoperto e lo si traversava con un ponticello in direzione di Vico Valoria. Tav. 5 n. 9
Un cimitero romano esisteva nei dintorni di S. Maria di Castello dove presso le case di un Simon Vallebona si rinvennero giarre, anfore ed urne, in una delle quali leggevasi Cajo Nemesio. Nel 1441, secondo quanto riferisce il Ganduccio, le tombe di quel cimitero sommavano ancora a non meno di 500. Tav. 5 n. 12
Altre tombe si rinvennero nel 1832 fuori Porta d’Arco nei pressi della chiesa della Pace nell’allargare la vecchia strada della Consolazione. Queste tombe, anzichè sparse a caso come nella necropoli di S. Andrea, sorgevano allineate all’orlo di una strada. Appartenenti ad un sepolcreto dell’epoca barbara, esse erano composte con tegole e contenevano scheletri di guerrieri stativi inumati con la spada di ferro in pugno. Vi si rinvennero anche rozzi unguentari di vetro, qualche piccola scodella ed altri oggetti in bronzo. Tav. 5 n. 17
I resti dell’acquedotto romano ne dimostrano l’origine a Struppa: quindi passava da Staglieno, risaliva il Colle fino allo Zerbino, e discendeva a Piccapietra per poi passare presso la Porta Soprana e dirigersi all’arce di Castello. Tav. 5 lett. A
b) Ritrovamenti :
Stele di Apollonia trovata dal Grosso nel 1910 presso la Porta Soprana.
Il Federici riferisce di molti avanzi romani trovati a San Siro: di una collezione di oggetti antichi raccolti in quella localita si parla anche in un manoscritto del Cicala esistente presso il Municipio di Genova. Tav. 5 n. 2
Avanzi di archi di acquedotto furono trovati interrati in Piazza Giusti. Tav. 5 n. 21
Un sepolcreto si sarebbe rinvenuto alla Foce presso il Sacrario ove si vuole approdassero i SS. Nazaro e Celso: in origine era forse un Fano sacro agli Dei Mani, da una lapide in esso trovata che portava scritto intra consaeptum maceria locus Dei Manibus consacratus. Tav. 5 n. 23
Colonne romane nella Chiesa di San Tomaso poi portate al Museo di Archeologia. Tav. 5 n. 26
Rostro di nave rinvenuto nelle acque del porto. Tav. 5 n. 28
Colonne e capitelli del Monastero di S. Andrea. Tav. 5 n. 35
Il Cerbero e un blocco di granito a Piazza Ponticello durante gli scavi del 1937. Tav. 5 n. 36
c) Posizione attuale di avanzi:
Colonne romane nelle case Veneroso. Tav.5 n.5
Lacunari romani ridotti in capitelli del ‘500 a San Lorenzo Tav. 5 n. 7 bis
Colonna romana in granito con capitello romanico in Piazza Stella. Tav. 5 n. 8
Colonne romane nei sotterranei dell’Ospedale di Pammatone. Tav. 5 n. I5
Tronco di colonna rostrata nel monumento al Ponte dei Mille. Tav 5 n. 27
Colonne e capitelli nelle logge di Piazza Cavour. Tav. 5 n. 29
Colonne nella loggia di Piazza delle Scuole Pie. Tav. 5 n. 30
Cimeli d’arte romana nella Chiesa dei SS. Cosma e Damiano. Tav. 5 n. 32
Marmi romani nella Chiesa di S. Maria di Castello. Tav. 5 n. 33
Avanzi romani nella Chiesa di S. D’onato. Tav. 5 n. 34
Sarcofago ellenistico sotto il Campanile delle Vigne.
Colonne romane nella navata destra della Chiesa delle Vigne.
Colonne antiche nel fondaco del Palazzo Mascardi in piazza Invrea.
d) Indicazioni di autori:
Sepolcreto nella Piana dell’Acquaverde: nelle escavazioni fatte per erigervi il monumento a Colombo si rinvennero due camere con ossa e scheletri umani che il Celesia, avendole visitate, riferisce essere volte ad oriente riportandone il tipo agli ipogei Liguri. Tav. 4 n. 1
Un’altra necropoli che serviva ai villaggi di Val Bisagno era a Staglieno e venne posta in luce da molti reticoli di terracotta di fattura romana e da avanzi di tombe con dentro vasi e monete di origine pagana. Celesia «Delia Topografia primitiva di Genova».
Il Faro romano e diverse torri sovrapposte (la prima illustrazione del Faro di Genova è il disegno che il Podestà ha tratto da un Manuale dei Salvatori del Porto e del Molo dell’anno 1371). Tav. 5. n. 1
Muro romano sotto Palazzo Bianco. Tav. 5 n. 3
Tempio pagano sotto S. Pietro in Banchi. Tav. 5 n. 4
Mura del Castrum di ponente: tracce nei muri del Convento di S: Maria di Castello. Tav. 5 n. 13
Porta del Castrum di tramontana: tracce nell’arco di S. Maria in Passione. Tav. 5 n. 14
Muro romano della decadenza sul lato sinistro di S. Stefano. Tav. 5 n. 16
Sepolcreto romano a Staglieno – ne parla il Celesia reticoli di terracotta di fattura romana. Tav. 5 n. 18
Ponte romano di Paverano o Ponte Rotto.
Tav. 5 n. 19
Ponte di S. Agata. Tav. 5 n. 20
Ponte Pila. Tav. 5 n. 22
Torre ottagonale sotto il Campanile di S. Stefano. Tav. 5 n. 37
Archi romani da San Vincenzo all’Acquasola. Tav. 5 lett. H
Secondo il d’Andrade tracce delle antichissime mura di Genova si dovrebbero trovare nel sottosuolo di vico chiuso degli Eroi.
Avanzi di mura e di torri romane presupposti dal Poggi sul Colle di Piccapietra, nonchè una fortezza romana a Castelletto, ecc. Poggi, Genova romana.
Una tradizione raccolta dal Belgrano farebbe esistere mura antiche in vico del Fornaro. Belgrano, Porta Sopr.
La torre di Luculi, quale parte del sistema romano. Poggi, Genova romana.
[ulteriori immagini saranno inserite appena verranno pronte]
* * *
III – I secolo
AA.VV. a cura di Piera Melli
Estratto da Piera Melli, Genova da comunità federata a municipio di Roma, in Genova dalle origini all’anno mille, SAGEP, 2014.
[ulteriori immagini saranno inserite appena verranno pronte]
* * *
IN CORREZIONE
CITTADINANZA ROMANA – POMPEO E CESARE
Poggi G., Genova preromana, romana e medievale, in Genova, Giovanni Ricci editore, Libreria Moderna, Galleria Mazzini, 1914
SOMMARIO : Quando i Genovesi acquistarono la cittadinanza romana — La guerra piratica — La guerra mitridatica — Giulio Cesare governatore della Gallia Cisalpina
Nell’anno 89 divampava la guerra sociale, provocata dagli Italiani della media e bassa Italia, che reclamavano la cittadinanza romana. Per impedire che la ribellione si estendesse, Roma concedette allora colla legge Plauzia Papiria la cittadinanza a tutte le città alleate, e Genova fu probabilmente fra esse. Una lapide trovata a Roma ci fece conoscere che Genova fu ascritta alla tribù Galeria (1).
Poco dopo il console Pompeo Strabone propose che fosse accordata la cittadinanza iure latino a molte città situate nella Valle del Po. Con quale entusiasmo fossero accolte queste riforme lo dimostra il fatto che le città dell’alta Italia andarono a gara nel prendere il nome di quel console (Alba Pompeia, Hasta Pompeia). Erano i primi passi verso quella rivoluzione, che doveva far diventare gli Italici i padroni di Roma.
Gli avvenimenti successivi stringono sempre più i rapporti fra i Genovesi e Roma. Ma ve ne sono tre che vogliono essere segnalati perchè ebbero certamente molta influenza per Genova: la guerra piratica; la guerra mitridatica; ed il governo di Giulio Cesare come proconsole delle Gallie.
Nella guerra piratica (68-67 a.C.), diretta da Pompeo Magno, i Genovesi cominciarono ad assumere quella missione di «difensori del mare», che diede ad essi una posizione privilegiata nell’impero. Cominciò allora quell’armare in «corsa» che divenne lo sport favorito dei Genovesi da Pompeo a Caffaro, da Caffaro ad Andrea Doria.
Una critica superficiale può dire che mancano le fonti. Ma a parte l’interesse grandissimo che avevano i Genovesi a liberare la navigazione dai pirati, Plutarco (2) ci fa conoscere che ogni zona marittima ebbe la sua flotta. Altri scrittori ci attestano che una flotta fu organizzata «in ligustico sinu» e che fu comandata da P. Attilio (3). Si aggiunga il fatto, che è accertato dalla tavola di bronzo, ed ammesso da tutti i critici, che i Genovesi erano vincolati dal foedus, obbligati quindi a contribuire alle imprese navali decretate da Roma. Si aggiunga che il testo della legge Gabinia riferita dagli autori (4) diceva espressamente che «reges nationesque omnes auxilia petenti mitterent, militum sociorumque navalium delectus suo arbitratu haberet». Si aggiunga la testimonianza di Caffaro il quale ricorda che ab antiquo i Genovesi erano stati incaricati della difesa del mare. E di fronte a tutta questa congerie di fatti si dirà ancora che le nostre vedute storiche non sono discutibili perchè mancano le fonti ?
Il fenomeno dei pirati, quale ci è descritto da Plutarco e da altri scrittori dell’epoca romana, ci suggerisce un interessante parallelo fra i pirati dei tempi di Roma e quelli del medio evo. Si direbbe che questi sono discendenti diretti dei primi per la perfetta riproduzione del modo di organizzarsi, del modo di comportarsi nei loro sbarchi sulle coste d’Italia, di Sicilia, di Sardegna e di Corsica, per la loro abilità marinaresca, per le grandi ricchezze conquistate, per lo spirito rapinatore e avventuriero.
Aggredivano le isole e le città marinare e depredavano a man salva, ripartendo il bottino fra i compartecipi alla impresa, che erano mercanti, e spesse volte nobili d’alto lignaggio. Avevano porti e luoghi di rifornimento e torri di segnalazione, e flotte di galee, velocissime e ben equipaggiate, un lusso orientale nell’ arredamento, poppe dorate, tende di porpora, remi con borchie d’argento, come fossero preparati per grandi feste.
Per le marine si sentivano suoni di tibie, canti e voci di ubbriachi, e ad ogni poco si spargeva la notizia di città depredate o ricattate, di personaggi illustri catturati, e rimessi in libertà per danaro. Giulio Cesare giovanetto fu catturato sul mar di Mileto nel littorale romano, due pretori Settilio e Bellino furono presi coi loro littori, e Baia la figlia di M. Antonio, rapita, fu restituita con grande ricatto. Quando il malcapitato si dichiarava cittadino romano veniva fatto oggetto di grandi inchini, gli si chiedeva perdono, lo si vestiva di porpora, affinchè potesse essere riconosciuto un’ altra volta, e poi gli si presentava una scala dicendo che era libero di andare. E poiché l’altro trovava difficoltà a camminare sui flutti, lo gettavano in mare.
Di che razza fossero i pirati è difficile stabilire. Uscivano specialmente dalle cale di Oriente, come nel medio evo i Saraceni erano essenzialmente sul lido africano. Ma il pirata rappresentava l’anarchico di quel tempo, e su tutti i lidi fioriva la pianta della pirateria. Gli spagnuoli erano pirati; i Liguri, scriveva Cicerone, stimano bella cosa il predare. Roma che era in definitiva la predatrice di tutto il mondo, non poteva tollerare che nel grande impero che essa andava organizzando, vi fossero di questi speculatori privati che costituivano una continua minaccia per la sicurezza pubblica sia in terra che in mare. Le città marinare che aspiravano alla stabilità dei loro traffici, erano naturalmente con Roma per combattere la pirateria. E quindi si comprende come l’armare in corsa contro i pirati divenne l’ambizione di tutte le genti di mare. Se non che lo sport piacque tanto ed era così lucroso che il corsaro diventò pirata, e non fu più possibile distinguere l’uno dall’altro. Sesto Pompeo, il figlio di Pompeo Magno, che aveva liberato i mari, divenne subito un grande corsaro, quando suo padre fu spento, e Cesare e poi Augusto furono contro di lui. Da quell’epoca in poi rimase vivissima nelle popolazioni marinare la passione dell’armare in corsa. Ed infatti noi troveremo che il medio evo genovese è tutto un scintillio di episodi guerreschi determinati da flottiglie private, in corsa sui nostri mari. Invece di passare l’estate ai bagni o l’inverno al Cairo il nobile genovese guarniva riccamente la sua galea e si metteva in corsa. Anche qui si rivela la continuità storica, e l’istinto permanente di quella schiatta ligure, che nei tempi antichissimi «reputava cosa bellissima il predare».
Appena finita la guerra piratica, Pompeo fu mandato in Oriente (66-63 a.C.), ove durava da molti anni la guerra contro Mitridate re del Ponto. Si combatteva sopra le rive del Bosforo e del Mar Hero, in quelle belle regioni, che molti secoli dopo si chiameranno Costantinopoli, Pera, Gazzaria o Crimea, Caffa, Calcedonia, Hicomedia, Trebisonda. Oltre al regno del Ponto, l’Asia Minore formava altrettanti piccoli stati, governati da dinastie locali, Bitinia, Cappadocia, Paflagonia, Cilicia, Armenia, Siria ecc. Era il vecchio mondo orientale di Nabucodonosor, di Ciro, di Serse, fatto a brani dopo la morte di Alessandro Magno, corroso nei singoli stati da discordie interne, da sette sacerdotali, esaurito da continui mutamenti dinastici. Mitridate, uomo di gran valore, aveva tentato di ricostituire un impero in Oriente, e si avanzava verso la Grecia ed altri possessi dei Romani. Era stato sconfìtto a varie riprese da Silla nell’88 a. C.; ma la sua potenza risorgeva sempre più minacciosa, per cui Roma dovette decidersi a sostenere una guerra colossale, che fu la sua più grande preoccupazione dall’anno 92 al 63 a. C. Lucullo aveva arricchito straordinariamente sè stesso ed i suoi eserciti, invadendo e saccheggiando quelle antiche città, ove erano accumulati i tesori di venti secoli. La febbre delle ricchezze invase allora gli Italici, trascinati da un solo pensiero. «Tutto è da prendere; tutto è da rapire e da comprare a peso ed a misura di ferro» (I).
——————–
(I) Un aneddoto riferito da Plinio (XXXIII, 24) ci dà un’ idea del modo con cui si saccheggiavano le città dei regni d’Oriente. Augusto, invitato a pranzo a Bologna da un veterano, il quale aveva fatta la campagna d’oriente con Antonio succeduto a Pompeo, chiese al vecchio soldato se era vera la diceria che il soldato, che nel grande saccheggio del tempio della dea Anaitide aveva messo per primo le mani sul simulacro d’oro della dea, fosse in quell’ istante medesimo acciecato. Il veterano sorrise; l’audace sacrilego era proprio lui. Anzi egli aggiunse che Augusto stava allora mangiando «la coscia della dea». Il soldato aveva nel parapiglia arraffata una gamba d’oro massiccio del simulacro infranto ; l’aveva portata in Italia e venduta, comperando poi la casa di Bologna, probabilmente delle terre e degli schiavi, e vivendo coi redditi di quel piccolo patrimonio. Anche i Genovesi, così portati alla vita avventurosa d’oltre mare, obbligati per i trattati a concorrere a queste imprese, avranno fatto la loro parte. E se erano presenti all’operazione di Anaitide, avran cercato anch’essi di avere un pezzo di quelle gambe così divine. Il medio evo ci è buon testimonio che i Genovesi avevano imparato a perfezione il sistema di spogliare l’oriente per rivestire l’occidente. Venezia adornò il suo S. Marco colla quadriglia di bronzo presa a Costantinopoli, Genova pigliava il sacro catino, e qualche cos’altro; Pisa, Amalfi non furono da meno nel seguire l’esempio degli avi. Son tutti fatti che rivelano la continuità della stirpe e della storia.
——————-
Tutti si gettarono nell’esercito di Pompeo per aver parte a quella grande liquidazione del mondo orientale. Si costituirono società di ogni genere per trasporti e forniture, e per il commercio d’esportazione dall’Oriente. Cicerone e sua moglie Terenzia speculavano l’uno all’insaputa dell’altro, in queste imprese, a cui tutti partecipavano colla frenesia, che vedemmo nelle speculazioni di borsa dei tempi nostri (5). Sarebbe strano davvero che in quell’occasione, che fu l’età dell’ oro per i mercanti, solo le nostre città marinare se ne stessero in disparte, esse che da cinque secoli battevano il mare, che avevano combattuto alacremente per espurgarlo dai pirati. I mercanti di cui parlano tutti gli scrittori latini di quel tempo erano Greci, Cilicii, Siriaci, Africani, Spagnuoli, Marsigliesi ed Italici, sotto il qual nome venivano Genovesi, Pisani, Cumani, Napoletani, Amalfitani e Siciliani. È un falso convenzionalismo storico quello che ci ha fatto credere finora che i Genovesi abbiano conosciuto 1’ Oriente all’epoca della prima crociata.
Pompeo Magno espugnò Gerusalemme nell’ anno 60 a. C. Lasciò ai Giudei una larva di nazionalità, con un re tributario dei Romani. Chi sa quanti Genovesi si stabilirono allora nei porti della Palestina, e quanti assistettero inconscii al gran dramma, che doveva poi sconvolgere il mondo, la morte di Gesù Cristo !
La storia di quei tempi è troppo antica, ed i Romani erano troppo alieni dall’ occuparsi delle intime vicende dei loro sudditi, perchè si possano avere dagli scrittori latini delle notizie specifiche dei Genovesi in quel tempo. Ma il Ganducio ci ricorda una circostanza che dimostra come i Genovesi conservarono a lungo la memoria di Pompeo Magno, che li aveva guidati alla conquista del mare e dell’ oriente. Sopra un muro del Castello egli vide un busto in marmo, colla scritta «Imago Pompei Magni» (6).
Dalle orazioni di Cicerone noi veniamo a conoscere che un Ligure, e probabilmente un genovese, di nome Elio Staleno o Staglieno, prese parte alla guerra Mitridatica nell’anno 77 a. C. sotto il console Emilio Mamerco. Egli esercitava l’alta carica di Questore; era cioè incaricato della gestione finanziaria e delle forniture degli eserciti. Cicerone lo accusa di aver suscitato una sedizione per la sua cattiva amministrazione. In altra occasione lo accusa di avarizia sfrenata, di far l’avvocato a base di corruzione, comperando i giudici a 600.000 sesterzii per volta. Certo è che per confessione stessa di Cicerone, iste Ligus, com’egli lo chiama, era diventato un avvocato di grido «piacendo molto a Roma la sua eloquenza fervida, aggressiva ed irruente» (7). Si era imposto tanto, che Cicerone lo considerava come il principale autore della sua disgrazia, in quanto era riuscito come tribuno ad opporsi a che Cicerone fosse richiamato dall’ esilio (59 a.C.).
Il fatto di questo ligure che diventa questore, tribuno, senatore in Roma, dal 77 al 59 a. C., ha un valore grandissimo per la nostra storia, perchè dimostra due cose: la presenza dei Liguri in Oriente, ed il cammino che essi avevano fatto, valendosi del diritto di cittadinanza loro accordato. Nulla di tutto questo fu rilevato finora, eppure si tratta di fatti che hanno il loro fondamento nelle più autentiche fonti.
Dal 56 al 44 è l’epoca di G. Cesare. Per nove anni egli fu governatore della Cisalpina, cioè dell’ alta Italia dal Rubicone e dall’Arno alle Alpi, e per nove anni ebbe il comando della guerra nella Gallia transalpina.
Giulio Cesare aveva bisogno di formarsi un partito di gente nuova, per arrivare, secondo i suoi occulti disegni, al dominio di Roma. Egli prese ad accarezzare, come dice Svetonio, con ogni sorta di benefizii, le città della sua provincia. Costruiva strade, fori, teatri, acquedotti, e prometteva ai Transpadani ed ai Liguri della Cispadana (gli Ambroni di Svetonio, gli Ombrichi di Strabone), la piena cittadinanza romana, a cui tutti anelavano con impazienza, visti gli immensi vantaggi che portava con sè la qualità di cittadino romano. Svetonio ci fa conoscere che l’idea di farsi un partito con i Transpadani (Torino, Vercelli, Milano, Pavia, Verona, Padova, Aquileia) e cogli Ambroni (i Liguri dell’Appennino tortonese, piacentino, parmense e modenese, i Liguri della riviera di ponente, i Genovesi, i Lavagnin o Tigulli, quei di Val di Macra e di Garfagnana) era antica nella sua mente, giacchè da giovane «per Transpadanos et Ambrones coniurabat». Questo passo, tanto importante per la nostra storia, non fu mai inteso, perchè non si pensava che, parlando di Ambrones, Svetonio volesse accennare a dei Liguri (8). Così pure non si è mai pensato che la Cisalpina al tempo di G. Cesare aveva ancora gli stessi impianti militari che abbiamo visto funzionare ai tempi di Minucio Termo e di Mario, un corpo d’esercito a Piacenza, un altro a Genova; punto di convergenza Vado, campo di guerra la Gallia. Si aggiunga che Marsiglia si mise in rotta con G. Cesare e si comprenderà quale importanza dovesse avere Genova come base di operazioni nelle guerre fatte da G. Cesare contro la Gallia. Siamo anche qui in presenza di un’oasi ricchissima di storia, inesplorata finora.
Della famigliarità di G. Cesare colle famiglie della «Provincia» che egli accarezzava ci fa fede Plutarco, ove narra del suo modo di comportarsi nei pranzi famigliari a cui prendeva parte. È famoso l’aneddoto degli asparagi al burro, offertigli da una casa milanese in un banchetto. Se queste cose avvenivano a Milano, saremo troppo arditi pensando che nei suoi viaggi a Genova sarà stato trattato con laute imbandigioni e avrà gustato le nostre «ombrine» e le triglie coi barbigi?
L’epoca di G. Cesare costituisce la gran primavera dell’alta Italia. Gran numero di paesi prendono l’aspetto di città e queste vanno a gara nell’assumere il nome di Julia, o di Forum Julii. Torino, Vercelli, Asti, Lumello, Tortona, Libarna, Pavia, Parma, Modena si atteggiano a città in quel tempo (9).
G. Cesare non fu solo un protettore di occasione, un grande ambizioso, un grande capitano. Egli concepì quella stupenda organizzazione che rese grande l’impero, che gli procacciò tanta ammirazione anche fra i barbari, tanti rimpianti nel medio evo, che rese possibili tanti Cesari, tanti Kaiser, tanti C-zar, che, più o meno degnamente, assunsero tal nome da Augusto in poi.
Per limitarci alle cose che hanno diretta attinenza con la nostra storia, dobbiamo ricordare che G. Cesare, divenuto l’arbitro di Roma, fece approvare nell’anno 49 a.C. la legge Roscia, che estendeva a tutti gli abitanti della Cisalpina la cittadinanza romana. Il numero dei senatori fu portato a 900. I Cisalpini divennero i più attivi, i più intrapprendenti cittadini di Roma, tanto che Cicerone andava brontolando che Roma non era più dei Romani, ma dei Liguri e Transpadani. Nello stesso tempo era approvata la famosa Lex Julia, de municipiis, che diede agli Italiani quel tipo geniale del Municipio romano, che ancora in oggi non è spento, perchè le nostre leggi comunali altro non sono che la «lex Julia» adattata ai nostri tempi. La lex Julia piacque tanto che anche le città federate come Genova vollero foggiarsi alla romana pur mantenendo la loro autonomia.
Da tutti questi fatti si viene a comprendere quale doveva essere la prosperità di Genova ai tempi di G. Cesare. Quando si pensa che era il porto più importante della Gallia Cisalpina, governata da G. Cesare, sarebbe assurdo il pensare che soltanto essa debba essere stata esclusa dai suoi favori. Nel campo di Genova egli ebbe a soffermarsi certamente più volte durante i nove anni del suo governo, e non è possibile che egli non abbia lasciato i segni della sua munificenza o nel pretorio, o nel foro, o mediante la costruzione di altri edifici pubblici. Anzi non è fuor di luogo il supporre che come egli ha concepito l’idea di una stazione navale a Forum Iuli (Frejus), così abbia avuto la prima idea del porto di Genova. Così ragionando non ci pare di uscir fuori dei limiti di una prudente deduzione storica. Altri potrà ragionare diversamente e con più felici risultati. Ma ciò che fa meraviglia è che tutti questi elementi siano stati trascurati finora per concludere che le nostre origini si perdono nella «famosa notte dei tempi».
Coll’assassinio delle Idi di Marzo (44 a.C.) l’opera di G. Cesare fu troncata. Ma i suoi vasti disegni trovarono un continuatore in Ottavio, che gli fu pari nell’ambizione, se non nell’ingegno, e lo superò in crudeltà e scaltrezza.
Note e Bibliografia. (1) Mommsen, – Corpus I. L. (2) Plutarco, Vita di Pompeo. (3) Vedi Livio, Epit. in locum, libr. XCIX. (4) Livio, Epit. in locum, lib. XCIX. (5) Ferrero, Grandezza e decadenza di Roma. (6) Ganducio. (7) Spotorno, Storia letteraria della Liguria. (8) In una nota illustrerò questa tesi che è di una importanza capitale per la conoscenza della storia antica. Gli «Ambroni» di Plutarco (vita di Mario) e di Svetonio (vita di G. Cesare) e gli Ombrichi di Strabone e gli Obrigi e gli Allobrogi e An ti-Obrogi di Livio e di Plinio, e gli Umbranici, e gli Umbranates, e i S-umbri, I-s-umbri e quei di Ol-umbria, Vi-l-umbria, altro non sono che avanzi dell’ «antiquissimum genus» che i Greci chiamarono Ligui, Libui, Ligures e Liburni, e gli Italici chiamavano Umbri. (9) Abbiamo un Forum Juli nel Veneto, e un Forum Juli in Provenza. In Provenza si pronunziava Fre-Jules e quindi Fre-jù, in Italia, For-iuli e quindi Fr-iuli. Perciò io dubito che un «For Juli» fosse in antico la piazza S. Domenico, sapendo che la torre che ivi esisteva nel medio evo si chiamava «Friulan-a o Friulante ». Podestà. Il Colle di S. Andrea.